
Veduta
di Napoli a metà del XVIIImo secolo
NOBILTA’
RIBELLE
NEL
REGNO DI NAPOLI
SOTTO
I VICERE’
TOLEDO
E MEDINA-COELI
Michele
E. Puglia
PARTE
GENERALE
SOMMARIO:
INTRODUZIONE; I PRIMI PARLAMENTI; NAPOLI CAPITALE DEL REGNO; SEGGI E SINDACI; I
VICERE’ LOTTANO CONTRO
PARTE
SPECIALE PRIMA SOMMARIO: IL VICERE’ MEDINA COELI SEGUE LE ORME DEL VICERE’ DE
HARO; ETICHETTA E ARROGANZA SPGNOLA PER L’AMANTE DEL VICERE’; RAMMARICO DELLA
NOBILTA’ PER I PROVVEDIMENTI CONTRO IL DUCA E
PARTE
SPECIALE SECONDA SOMMARIO:
INTRODUZIONE
|
Q |
uando
Carlo V (1500-1558) aveva abdicato in favore del figlio Filippo I, aveva diviso
tutto il suo esteso impero lasciando a Filippo il regno di Spagna, di Napoli e
di Sicilia, il ducato di Milano e tutte le Indie Occidentali, e al fratello
Ferdinando I il regno d’Austria e tutti i territori ad esso collegati unitamente
al titolo imperiale (del SRI.).
Erano
così stati creati i due rami degli Asburgo, di Spagna (che nominava i vicerè
per Milano, Napoli, e Sicilia) e d’Austria, intimamente legati in quanto a ogni
generazione si intrecciavano anche con matrimoni incestuosi (in ogni caso
superati con facili dispense della Chiesa!) o al limite della pedofilia (quando
gli zii maturi sposavano le adolescenti nipotine in fiore ... ma ciò, per
l’epoca, non costituiva una novità (si veda in Specchio dell’Epoca: Casa
Savoia, vivaio di pulzelle per l’Europa); ma queste unioni non impedivano allo
stesso tempo di combattersi, per genetica
avidità, per appropriarsi dei territori altrui; in particolare era sempre
il ramo austriaco che aveva da avanzare pretese sui regni dei propri parenti; nel
caso in esame le pretese erano avanzate sul regno di Spagna e suoi viceregni, e
senza tanti scrupoli, come vedremo, si faceva ricorso alle guerre!
Giungendo
all’epoca che ci interessa (fine ’600 inizi ’700) troviamo in Austria regnante l’imperatore
Leopoldo I, di quel ramo, mentre in Spagna troviamo Carlo II, di questo ramo.
Ma
prima di giungere all’epoca di Carlo II e del viceré di Napoli duca
Medina-Coeli, volendo dare un quadro più generale del contesto storico del
Regno di Napoli di quel periodo, riteniamo opportuno fare un salto indietro e
risalire all’epoca del viceré don Pedro di Toledo (1532-1553) durante il quale
regnava l’imperatore Carlo V.
E’
da dire che questo periodo è stato il più carico di avvenimenti che avesse
potuto avere l’Europa (a parte tutte le guerre volute dall’imperatore) quali il
Rinascimento (**), la Riforma della Chiesa cattolica e la Controriforma
protestante introdotta da Lutero, avvenimenti maturati senza alcun diretto contributo
da parte del fortunatissimo imperatore (che a ogni morte di un parente
ereditava regni!), come avremo modo di vedere in una serie di articoli in
preparazione (Carlo V tra Rinascimento,
Riforma e Controriforma).
Di
questi avvenimenti, quello più controverso e più cruento era stato il movimento
della Controriforma, così erroneamente
definita (rispetto alla Riforma
protestante), che aveva dato uno stretto giro di vite, finalizzata a una
più rigida osservanza della fede e della religione “ccattolica” (in quanto ritenuta universale),
che emergerà dal fanatismo del Tribunale
della Inquisizione, definita Santissima,
ma in effetti “criminale” in quanto,
messa nelle mani di giudici criminali, perversi e psicopatici aveva aperto la strada a veri e propri
crimini contro l’umanità (v. in Articoli: L’Inquisizione ecc.).
Quei
giudici infatti, in una atmosfera di psicosi collettiva, pescavano le loro vittime
in un mondo di ignoranza, di false credenze e di menti malate, dominato da un
onnipresente Demonio, che nelle
azioni umane e tentatrici si riteneva agisse addirittura “con il permesso (del più potente) Dio... per i suoi imprescrutabili e oscuri disegni” (Kramer-Sprenger: Il martello delle Streghe), ispirate invece da fantasie
oniriche fatte di voli e incontri notturni, di adorazioni e accoppiamenti con i
Diavoli, ottenute con sostanze
allucinogene e ritenute reali, che nel
corso dei processi trovavano facili conferme nelle “confessioni” estorte con il ricorso alla tortura.
Lo
scopo principale di questi processi era dato dalla lotta del fondamentalismo
religioso il quale, mirando, come detto, alla integrità della fede, riteneva di
eliminare fisicamente chi se ne discostasse.
L’accusa
era in ogni caso quella di eresia,
combattuta con il genocidio di massa di donne (nella maggioranza) considerate streghe, e (nella minoranza) di stregoni,
ricorrendo alla tortura con cui si infliggevano indicibili sofferenze per ottenere
la “verità”; questa, dava luogo a
racconti fantastici, dai giudici ritenuti reali, con accuse che si estendevano
a macchia d’olio e coinvolgevano altre persone altrettanto innocenti che trovavano
la fine liberatoria dai tormenti o con il suicido (del quale era ritenuto
responsabile il Diavolo!), o sul rogo dove andavano incontro a una morte brutale
e altrettanto spietata.
Queste
ignominie, col passar dei secoli erano cessate, ma, ancora oggi vi è chi
giustifica il comportamento di quei giudici criminali, ritenendo (come aveva
sostenuto a suo tempo Bodin, v. in cit. art.
Inquisizione) che .... era scritto nelle Sacre Scritture che “le streghe dovevano essere uccise”!
Napoli
in questo contesto europeo (ma anche americano: basti il ricordo del processo di
Salem, 1692), è da considerare un’isola felice in quanto, stranamente (pur trovandosi,
come viceregno, in uno stato di sudditanza coloniale) si era ripetutamente opposta
alla istituzione del Tribunale, ricorrendo - come vedremo - anche alla rivolta,
a causa dei terribili echi che giungevano dalla Spagna (ma vi era l’interessato
e contraddittorio appoggio del papa Paolo III, il quale incoraggiava la
resistenza dei napoletani a causa del braccio di ferro con i monarchi spagnoli
che nei loro processi non volevano le interferenze della Santa Sede (v. in
Articoli cit.: L’inquisizione ecc. Parte prima, L’inquisizione spagnola).
Questo
“excursus” si conclude con la Congiura di Macchia, che si svolge tra la
fine del 1600 e l’inizio del 1700, durante il regno, in Austria, di tre
imperatori (Leopoldo I, suo figlio Giuseppe I e il nipote secondogenito Carlo III)
i quali, vantando diritti sul regno di Napoli, miravano a impadronirsene, riuscendo
anche ad appropriarsene per un breve periodo di tempo (1701-1734), dopo il
quale il viceregno assurge finalmente
a regno.
*)
Ci piace ricordare la frase profonda di Orson Welles nel film “Il terzo Uomo”, l’Italia aveva avuto guerre, assassini e
rivolte e aveva prodotto Leonardo, Michelangelo e Raffaello mentre la pacifica
Svizzera non aveva prodotto che l’orologio!
I
PRIMI
PARLAMENTI
NEL
REGNO
DI
NAPOLI
|
F |
ederico
II (1194-1250), volendo porre un freno al potere dei baroni, per favorire le
libertà dei Municipi aveva stabilito che ogni città, sia regia sia feudale,
fosse rappresentata da quattro deputati oltre a due deputati per ciascun feudo
o castello; oltre a costoro nelle assemblee denominate Parlamenti, partecipavano anche gli ufficiali maggiori del regno, i
Giustizieri, i Camerari e i Baglivi delle province; in tali assemblee era consentito a chiunque
di denunciare i torti ricevuti, di far ricorso contro qualsiasi ministro regio
o esporre pubbliche necessità.
I
Parlamenti si riunivano due volte all'anno a maggio e novembre (l’origine era
da collegare ai Campi di Maggio carolingi, v. in Carlomagno e l’idea dell’Europa).
NAPOLI
CAPITALE
DEL REGNO
|
C |
on
gli angioini, a causa delle restrizioni delle libertà, i Parlamenti divennero più
rari e meno liberi.
Carlo
I d'Angiò (1226-1285) fu il primo monarca a fissare la sua sede a Napoli e
introdusse la massima secondo cui i baroni, come primi cittadini dei feudi,
rappresentassero le popolazioni ad essi soggette, ciò che comportò la
abolizione della convocazione dei rappresentanti
dei Comuni, eccetto quelli delle città regie, come sarà successivamente
confermato dagli aragonesi (v. in Articoli, L’Europa verso la fine del
medioevo, P.IV).
I
Comuni del regno erano governati da nobili e popolani i quali si riunivano nei
paesi feudali al suono delle campane, per eleggere i magistrati; gli elettori
erano distinti in quartieri o rioni e denominati Piazze o Seggi.
Napoli
divenuta capoluogo del regno fu divisa in Sei Seggi (maggiori) e i popolani
divisi in ventitre Curie, denominate Ottìne (si tenga
presente che in pratica i popolani corrispondevano ai borghesi di Francia; da costoro si distingueva
la plebe
che non aveva diritti ed era considerata come “i fuori casta” in India.
Tutti
i nobili che abitavano nei rioni dei Seggi vi facevano parte, come anche i
grandi ufficiali della corona, i capi della milizia, i magistrati, e i
gentiluomini venuti al seguito di Carlo VIII, nonché i patrizi che da altre
città si stabilivano nel capoluogo, rendendo i Seggi ancora più cospicui.
Carlo
I per meglio assoggettarli, concedeva ai patrizi napoletani prerogative sul
pagamento delle tasse e onorificenze come i
cingoli di cavalieri; ma mentre i patrizi (cittadini) ambivano a tutti
questi onori e miravano ad acquisire feudi per poter poi entrare nella casta
baronale, i baroni titolari dei feudi disdegnavano di trasferirsi nella
capitale in quanto non consideravano il
trasferimento in città all'altezza del loro grado.
SEGGI
E SINDACI
|
L |
e
famiglie nobili che possedevano feudi e castelli al tempo di Carlo I d’Angiò erano
diciassette e furono portate a quaranta dal re Ladislao, gratificate con terre
e feudi donati o venduti o tolti a baroni da lui debellati.
Mentre
i re angioini avevano cercato di abbassare la potenza dei feudatari domando le
loro ribellioni e la loro ritrosia all'obbedienza con le armi, Alfonso I
d'Aragona (1396-1458) fu altrettanto largo di concessioni a causa del suo interesse a far riconoscere il figlio
naturale e proprio successore, Ferdinando (poi Ferdinando I o Ferrante).
Si
costituirono così i Seggi (o Sedili o Piazze) c.d. maggiori, costituiti da
nobili, che inizialmente erano ventinove (quanto i Rioni della città), ridotti a
cinque per i nobili e uno per il popolo (Capuano,
Nido (*), Porto, Portanova, S. Arcangelo (Montagna) e Forcella), che nominavano
un Sindaco (o Eletto), mentre le ventinove Ottìne (Rioni)
di popolani ne nominavano un altro (si era continuato fino a Carlo II, ma a
seconda dei periodi se ne nominavano anche di più).
Con
Ladislao che come detto, tendeva a innalzare il patriziato della capitale il numero degli Eletti nobili era di cinque e
uno delle ventinove Ottìne (ogni Ottìna
aveva un capitano che veniva scelto dal viceré da una rosa di Eletti);
l’elezione era annuale.
Con
Alfonso I i popolani si rivoltarono contro i patrizi
e per punizione il loro portico alla “Sellaria”, dove si riunivano, fu abbattuto e il loro
rappresentante escluso.
Ferdinando
I continuò a tener lontani dal governo della città i popolani favorendo il
patriziato mentre cercava di indebolire i feudatari che alla fine si
rivoltarono (v. in Articoli: La congiura dei Baroni).
Quando giunse a Napoli il francese Carlo
VIII (1494) si erano presentati solo i rappresentanti dei nobili per prestare
il giuramento di fedeltà e il re si era meravigliato che non vi fossero
rappresentanti della borghesia; gli fu fatto presente che i cittadini ne erano stati privati; il monarca diede quindi
il permesso di riunirsi in assemblea e i rappresentanti del popolo riuniti
nella chiesa di s. Agostino, nonostante la opposizione della nobiltà, nominarono il Sindaco o Eletto e il re concesse al popolo
(1495) molte prerogative per il governo stesso della città.
Tornato il governo di Ferdinando il
Cattolico (1507) le ulteriori richieste
della borghesia, di parità dei diritti con la nobiltà furono respinte; i Sedili
saranno aboliti da Ferdinando IV nel 1800.
*)
I primi titolati del Seggio del Nido furono i fratelli di Lucrezia Alagno, amante di Alfonso I, che dal re erano stati creati
conti.
I
VICERE’
LOTTANO
CONTRO
DELLA
NOBILTA’
|
Q |
uando
il regno di Napoli era finito sotto il potere degli spagnoli e da regno era
stato degradato a viceregno (1503-1734),
lo spirito che lo reggeva era quello della colonia da spremere e sfruttare; i monarchi
che si avvicendavano designavano i viceré il cui compito era quello di
governare per loro conto e questo compito era costituito principalmente dalla
raccolta di danaro attraverso imposte, gabelle e donativi (che superavano di
misura le stesse imposte*) che essi provvedevano a mandare a Madrid.
Tra
i tanti viceré (come detto, erano due, uno per il Regno di Napoli e uno per il
Regno di Sicilia) a Napoli ve n’erano stati di illuminati come quelli di cui parliamo
in questo articolo che, indipendentemente dal carattere personale di ciascuno,
avevano realizzato opere architettoniche che avevano migliorato e abbellito la
città e le altre parti del Regno.
Compito
diciamo morale dei viceré, fu quello
di abbattere la potenza e prepotenza dei feudatari che approfittavano della
lontananza del potere centrale per spadroneggiare i quali reagivano alle
imposizioni passando a sostenere i
monarchi concorrenti, fossero essi monarchi francesi o austriaci.
Ma
quando giunse a Napoli Carlo VIII ebbero l’amara sorpresa di essere stati
umiliati (v. in Articoli: cit. L’Europa verso la fine del medioevo P. IV: La
discesa di Carlo VIII), per cui il loro spirito di vendetta rimaneva senza
costrutto; né la elezione di un monarca all’interno del loro gruppo, come
desideravano e proclamavano, riusciva mai possibile, perché tra di loro non solo
non vi era nessuna coesione, ma si invidiavano e detestavano reciprocamente a
tal punto che la elezione di un monarca tra le loro file rimaneva solo la
esternazione di un desiderio irrealizzabile!
Alla
fine i grandi feudi, poco per volta furono
incorporati nella corona e non furono più ricostituiti se non con la
concessione di piccole signorie, pur necessarie per governarne gli abitanti del luogo, non concedendo
però loro la possibilità di diventare potenti per non dare ombra alla autorità vicereale.
Finirono
con il decadere anche i Parlamenti limitati all’intervento dei soli feudatari
e deputati delle città regie le cui
funzioni erano limitate soltanto al voto per i donativi al sovrano e a
richiedere in cambio compensi a beneficio della capitale e del ceto di quei
patrizi.
*)
Per avere una idea dei donativi, mentre per imposte veniva inviato l’importo di
400mila ducati, i donativi spesso superavano questo importo, come quello del 1539 a Carlo V di un milione e
cinquecentomila ducati...nel mese di gennaio e un altro di sessantamila ducati
nel successivo mese di marzo; nel 1541 per la guerra ai turchi il donativo fu
di ottocentomila ducati; nel 1545, di seicentomila ducati; nel 1548 per la
figlia Maria, di duecentocinquantamila ducati; nel 1552, di ottocentomila
ducati; con il figlio Filippo II, gli importi aumentarono a un milione (ed era
oro sonante!) nel 1556 e nel 1560 la cifra aumentò a unmilione e duecentomila e
due anni dopo, 1562, un altro milione d’oro...e come è noto sia Carlo V che
Filippo II erano sempre a corto di danaro nonostante dalle Americhe arrivassero
galeoni carichi d’oro (durante il regno di Carlo V) e d’argento (durante il
regno di Filippo II).
Pedro di Toledo duca d’Alba
|
DON
PEDRO DI TOLEDO
E LE SUE REALIZZAZIONI
PER IL BENENESSERE
DEL
REGNO
|
|
P |
edro
Alvarez de Toledo y Zuñiga (1484-1553), marchese di Villafranca, era stato nominato
viceré di Napoli (1532-1553), da Carlo V
e ben determinato a instaurare una buona amministrazione della giustizia, dopo
il suo ingresso in città con grande cavalcata, convocò tutti i magistrati e
ufficiali e disse loro che la giustizia
doveva essere amministrata proprio come era rappresentata, con la bilancia
nella sinistra e la spada nella destra; poiché vi erano molti ufficiali che
lasciavano a desiderare per la vita che conducevano e per la loro corruzione, una
parte li mandò via, alcuni li fece sposare, per altri si assicurò che
conducessero una vita integerrima.
A
Napoli proliferavano i delinquenti e una lotta nei loro confronti era
impossibile in quanto per la loro punizione
vi si frapponevano i nobili che (“da sempre” ci dice uno storico), si abbassavano al loro livello, servendosi di loro per la commissione di delitti e
quando venivano acciuffati i nobili usavano tutta la loro potenza per farli
graziare dai giudici: don Pedro li avvertì che da quel momento non sarebbero
serviti più né favori né minacce.
Ne
diede subito l’esempio con Giovan Francesco
Pignatelli, della casata imparentata con famiglie principesche, incolpato di
molti delitti, che impediva alla
giustizia di fare il suo corso e ai querelanti di ottenere giustizia tenendoli
sotto minaccia; il viceré fece dar corso
alla giustizia e Pignatelli fu giustiziato nel largo del Castello di fronte alla piazza dell’Olmo; nello stesso
tempo, don Pedro diede un esempio della sua imparzialità facendo processare un popolano molto ricco, che con il suo danaro intendeva
coprire un suo delitto (vantandosi che lo avrebbe composto con ventimila
ducati).
Per
evitare che si commettessero reati, il viceré emanò un editto col quale vietava
che nessuno potesse tenere nelle case armi bianche e da fuoco e nessuno potesse
portarle per la città, all’infuori della spada portata dai nobili (questo
editto era stato emanato dopo la rivolta in cui era stato arrestato Tommaso
Aniello nel 1547, v. sotto).
La
città era piena di portici, che erano quasi delle grotte, utilizzati dai malviventi
per assaltare i passanti; fra questi vi era la grotta di s. Martino a Capuana e
la grotta di s. Agata che il viceré fece abbattere con altri antichi edifici “che davano spavento a passarvi di giorno”;
per la stessa ragione fece abbattere le tavolate e i banconi che i venditori
tenevano, per la vendita delle merci nelle pubbliche piazze, utilizzati di
notte da malfattori che vi dormivano e si nascondevano; per i molti vagabondi (chiamati
“compagnoni” che circolavano (in
gruppetti di quattro) per la città, emise un bando con cui vietava le “quadriglie”, e finì con estirparli dalla
città.
Don
Pedro in meno di due anni provvide a far
circondare la città di una muraglia con baluardi e torrioni e con terrapieno all’interno e fossato fuori, ampliando
la città del doppio di com’era prima, facendo rinchiudere all’interno il monte
di Sant’Eramo (e ricostruendo il castello); durante questi lavori era stata
ampliata la bellissima via Toledo che porta il suo nome e si ammira tutt’oggi a
suo perenne ricordo.
Nel
1538 vi fu un terribile terremoto dove
in prossimità del lago presso Pozzuoli si aprì un’ampia voragine da cui
fuoriuscirono per due giorni pietre, fango, fumo e cenere, che cosparsero tutta
la città di Napoli.
Gli
abitanti decisero di abbandonare la città,
ma don Pedro li convinse a rimanere esentandoli per alcuni anni dal
pagamento delle tasse e la ricostruì facendo costruire un palazzo con una bella
torre, con fontane e giardini, facendo rifare la strada che la collegava con
Napoli e molti signori costruirono i propri palazzi, fece restaurare i bagni, fece rifare le mura esterne ed egli
stesso vi andava a passare la primavera;
nonostante ciò Pozzuoli fu incapace (commenta lo storico), di sollevarsi
economicamente da sola.
La
ricostruzione di Napoli (che gli attuali amministratori del tutto incapaci
lasciano tra il caos del traffico, l’immondizia e le condizioni delle strade
che rendono indecorosa la città e Roma si trova nelle stesse condizioni ...e il
polemico Sindaco in una situazione di tal degrado .... ha annunciato le multe a chi butta le cicche delle
sigarette per terra!), era stata
operata da don Pedro con una visione d’insieme straordinaria che aveva
toccato da una parte quella architettonica, dall’altra il settore sociale e, come
abbiamo visto, le carceri, nelle quali vi organizzò un Ospedale per i poveri
esenti da spese; inoltre restaurava l''Ospedale degli incurabili, costruiva
l'Ospedale di Santa Maria di Loreto per i fanciulli orfani e quello di Santa
Caterina per le donne, restaurando l'Ospedale di San Eligio ugualmente riservato
alle donne.
Don
Pedro aveva avuto la cattiva idea (1540) di cacciare gli ebrei dal regno “che divoravano con le usure le sostanze dei
poveri” giustifica lo storico, in compenso, fondò il Sacro Monte di Pietà
che concedeva prestiti su pegno, e, fino alla somma di dieci scudi, senza
interesse.
Anche
nel resto del regno il viceré, per difenderlo dai continui attacchi dei turchi,
visitandolo con architetti e ufficiali, aveva dato ordine di rifare i castelli
di Baja, di Capua e dell’Aquila e di costruire il
castello di Reggio, di Castro, di Otranto, di Lecce e di Gallipoli.
LA
SEDE
PER
L’AMMINISTRAZIONE
DEL
|
D |
on
Pedro pensò a una sede unica per l’amministrazione della giustizia e fece ricostruire
completamente castel Capuano, risalente al XIImo sec. (la lapide che ricorda “l’imperatore Carlo V e il viceré Toledo marchese di Villafranca porta
la data A partu Virginis
1540”) e vi riunì tutti gli uffici distribuiti per la città (Sacro Regio
Consiglio,
Dispose
anche che vi alloggiassero il Presidente del Sacro Consiglio, il Luogotenente
della Sommaria e il Reggente della Vicaria con un giudice criminale; in questa
occasione aggiunse altri giudici criminali, disponendo che ogni sabato il Tribunale
fosse visitato da uno dei Reggenti e limitando
le feste per le vacanze dei magistrati, riducendole al minimo possibile (*) .
Poiché
i quattro giudici del Tribunale della Vicaria che giudicavano sia i reati sia
le cause civili, non ce la facevano ad amministrare la giustizia, ne aggiunse
altri due in modo che quattro giudici giudicavano i reati e due trattavano le
cause civili: dispose inoltre che sia il Reggente sia i magistrati e gli
ufficiali si ritrovassero ad amministrare la giustizia nelle stesse ore (cosa
che non avviene oggi in Italia le cui udienze hanno inizio secondo le abitudini
di ciascun giudice!) stabilendo anche gli stipendi per tutti; lo stesso fece
per gli altri Tribunali del regno.
Infine,
per l'assistenza legale dei poveri fece aumentare lo stipendio all'Avvocato e Procuratore
dei Poveri (istituiti da Federico II); costruì anche il nuovo Ospedale di San
Giacomo, esclusivo per gli spagnoli e quando era iniziata la costruzione era sceso personalmente nel fossato delle
fondamenta per porre la prima pietra.
Il
viceré cercò di estirpare la piaga delle false
testimonianze in tutto il regno (nelle grandi città vi erano dei centri di
riunione dei testimoni, detti “scuole”!)
con una prammatica (1536), riconfermata anche dal viceré duca d’Alba (1561),
che stabiliva la pena di morte per chi, per la seconda volta, testimoniava il
falso nelle cause penali, mentre per quelle civili fu disposto il taglio della
mano e l’esilio perpetuo dal Regno.
*)
I giudici italiani, la cui produttività lascia a desiderare, stanno strepitando
per la riduzione delle loro ferie da un mese e mezzo a un mese, non tenendo
conto delle numerose feste religiose (e vigilie!) che Italia superano ogni limite!
L’ORDINE
PUBBLICO
E IL BANDO
DELLE
SCALE
|
M |
alfattori
e fuoriusciti trovavano ospitalità in molte case, spesati dai nobili che se ne
servivano per commettere ogni genere di reati; il viceré istituì una tal forma
di controlli che nessuno ebbe più l’ardire di ospitarli ...“e neanche di guardarli in faccia, per non
creare sospetti”, e ciò fece anche in tutto il regno; furono inoltre vietate
le “ciambellarie”
organizzate di notte per festeggiare le vedove che si risposavano; vietò che si
uscisse di casa armati dopo le due di notte fino al mattino e per evitare che
qualcuno si giustificasse sostenendo di ignorare l’ora, dispose che la campana
di s. Lorenzo che si sentiva per tutta la città, suonasse a martello alle due
di notte!
Oltre
ai capitani di guardia che in città assicuravano l’alloggio “ai dispersi”, creò dei nuovi bargelli (guardie) di campagna che
circolavano per le campagne in modo che i banditi non si ritenessero più sicuri che in città.
Tra
i tanti provvedimenti per riportare l’ordine pubblico nella città, don Pedro
pubblico il Bando delle Scale: Ladroni,
malavitosi e innamorati, di notte usavano scale di corda o di legno per entrare
nelle case, i primi per rubare e compiere le loro sceller4atezze, gliinnamorati per i loro
incontri amorosi.
La
faccenda rendeva la città “inquieta”
e suscitava le lamentele dei cittadini, per cui il viceré pensò di porvi
rimedio con un bando con cui vietava di notte l’uso delle scale, comminando la pena di morte; ma nonostante il
divieto... furono molti a perdere la vita; vi incappò anche un giovane nobile,
Col’Antonio Brancaccio che dal Capitano di guardia fu trovato di notte, con una
scala di corda, sopra una finestra con
la quale era salito “per conto d’amore”.
Brancaccio fu preso e portato alla Gran Corte della Vicaria e la stessa mattina
fu decisa ed eseguita la decapitazione, nonostante si fosse mossa tutta la
città per chiedere la grazia; ma il viceré fu inflessibile e disse che non vi
potevano essere eccezioni perché “ciò
sarebbe servito ad aprire la porta agli altri”, aggiungendo che “si meravigliava della instabilità di chi
prima gli aveva chiesto di rimediare alla faccenda delle scale, perché nessuno
si sentiva più sicuro in casa e ora chiedeva di impedire il rimedio”.
Per
tutte queste novità vi furono accordi, specie da parte di nobili superbi, i quali in stretto segreto (ma non tanto che il viceré
non ne venisse a conoscenza!), di chiedere direttamente, durante la permanenza
dell’imperatore a Napoli, la sua sostituzione; essi non lo accettavano, perché danneggiati dal buon funzionamento della
giustizia, e l’accusa che gli muovevano era che lo faceva “non per
giustizia ma per crudeltà”.
La
questione fu anche discussa in tutta la città, ma risultò che la maggior parte
era favorevole al viceré e quelli che gli erano contrari lo erano piuttosto per
risentimenti personali o perché gelosi del suo buon governo; tra costoro vi
erano il “ribelle” principe di
Salerno, il marchese del Vasto e Andrea Doria; tra i sostenitori, il duca di
Castrovillari Ferrante Spinello (il figlio Giovan
Battista sposerà la quarta delle figlie di don Pedro, Isabella*).
Il
marchese del Vasto aveva avuto modo di parlare direttamente con l'imperatore e
resosi conto della stima che egli aveva
nei confronti di don Pedro, prese subito le distanze dagli oppositori; vi fu
anche un Eletto del popolo, Gregorio Russo, che aveva accusato il viceré di
essere dispotico e violento con il popolo, ma fu subito privato dell'incarico,
sostituito da un certo Stinca; i nobili oppositori del
viceré dovettero rendersi conto che l'imperatore
prima di partire gli aveva fatto tutte le concessioni e tutti i favori possibili ..."da renderlo più forte di prima"!
*)
Don Pedro dalla prima moglie Maria Ossorio Pimentel
aveva auto tre maschi Federico, Garzia e Luigi e
quattro femmine, Anna, moglie del duca
Altamira, Giovanna, moglie del conte d’Aranda,
Eleonora moglie di Cosimo de’ Medici e madre di Maria, moglie di Enrico IV di
Francia, e infine Isabella.
Rimasto
vedovo della moglie, don Pedro ebbe come amante Vincenza, figlia del duca Ferrante Spinello di Castrovillari, deceduto,
vedova di Antonio Caracciolo; il fratello di lei Giovan
Battista Spinello, duca di Castrovillari sposerà la figlia di don Pedro, Isabella,
dopo la sua morte (1553); Giovan Battista quando l’imperatore si trovava a Napoli, si
era lamentato della situazione della disdicevole situazione della sorella; l’imperatore
lo rassicurò che don Pedro l’aveva sposata segretamente, ma chiese ugualmente a
don Pedro di regolarizzare la situazione
e don Pedro aderì e la sposò pubblicamente.
ERESIA E INQUISIZIONE:
GLI
ASTROLOGI PREVEDONO
TURBAMENTI
E DISTRUZIONI
|
M |
entre
il Tribunale della Inquisizione era stato istituito in tutti i paesi cattolici,
l’unico regno (meglio “viceregno”) che
si era opposto, era stato quello di Napoli e lo aveva fatto anche ferocemente; ciò era avvenuto, fin dai tempi del viceré Toledo, il
quale si era trovato a gestire dall’inizio, la propagazione dell’ “eresia
luterana” vale a dire delle nuove idee luterane provenienti dalla Germania,
che fu combattuta in modo diverso da tutti gli altri regni dove erano stati
istituiti i Tribunali.
Secondo
le previsioni degli astrologi "il
crudele aspetto di Saturno in Capricorno e Sagittario e di Marte con
Fra'
Bernardino Occhino, fra’ Pietro Martire Vermiglio e il catalano Giovanni Valdes (*) avevano raccolto molti "segreti eretici"; fra’ Bernardino con le sue prediche suscitava
ammirazione (anche da parte dell’imperatore che trovandosi a Napoli (1536),
andava ad ascoltarlo in s. Giovanni Maggiore).
Partito
l’imperatore, fra’ Bernardino continuava nelle sue prediche seminando
sottilmente i semi del luteranesimo (si diceva che “le sottigliezze” le potevano notare solo i dotti) e questo nuovo modo di predicare
piaceva molto anche al viceré Toledo, che per fugare ogni dubbio gli aveva
chiesto di dichiarare esplicitamente di essere contrario alla nuova dottrina; fra’
Bernardino si difese negando ed essendo finito il ciclo delle sue prediche, se
ne partì lasciando che altri facessero il suo lavoro.
Tre
anni dopo, avendo lasciato un buon ricordo, i napoletani richiesero la sua
presenza ed egli predicando questa volta nel Duomo, usava parole ambigue per
potersi difendere da possibili accuse; le sue predicazioni in ogni caso
suscitavano dibattiti e approfondimenti anche da parte di laici.
In
quel periodo soggiornava a Napoli Giovanni Valdés, gentiluomo spagnolo e
giureconsulto; era stato in Germania dove si era invaghito delle novità luterane e al suo ritorno le aveva
portate a Napoli con molti libri, e così incominciò a diffondere la dottrina
luterana, trovando vasto consenso; nelle sue prediche diceva di essere ispirato
dallo Spirito Santo; era molto apprezzato e riusciva a convertire non solo i
nobili, ma anche, e particolarmente, le donne, tra le quali vi erano (le
celebri rinascimentali) Vittoria Colonna e Giulia Gonzaga; con Pietro Martire
Vermiglio aveva formato una compagnia che si riuniva per pregare e seguire le
pratiche dei riformati; Valdés in spagnolo scrisse il libro “Cento e dieci Considerazioni” che
ricalcava le (novantanove) “proposizioni”
di Lutero, poi tradotto in italiano (stampato a Basilea nel 1550) e francese;
morì a Napoli (1540).
Tra
il 1541 e 1542 fra’ Bartolomeo Occhino dichiarò apertamente di essere luterano
e fuggì a Ginevra.
In
questo periodo erano apparsi due libri,
il Seminario della Scrittura e
il Beneficio di Cristo, senza
indicazione degli autori, ai quali si aggiunsero gli scritti di Erasmo e di
Filippo Melantone; avvertito, il viceré dispose che quei libri fossero bruciati
e vi provvide Ambrogio da Bagnol che fece un gran
fuoco davanti al palazzo dell’Arcivescovado; nello stesso tempo furono previste
severe sanzioni per coloro che detenevano o leggevano tali opere,
A
questo proposito, don Pedro dispose (1544) che le opere pubblicate venticinque
anni prima non dovessero essere ristampate e i libri che venivano stampati o
venduti dovessero essere esaminati dal Cappellano maggiore; furono proibiti i
libri pubblicati senza nome dell’autore e quelli non approvati.
L’imperatore
aveva richiesto al viceré di istituire il Tribunale dell’Inquisizione agendo
con la massima discrezione per evitare ciò che si era verificato nelle Fiandre,
dove gli abitanti preferirono fuggire per non essere sottoposti a giudizio,
lasciando il paese disabitato, e l’imperatore aveva dovuto disporre la sua
eliminazione.
Vi
era stato anche l’intervento del papa Paolo III (Alessandro Farnese 1534-49) il
quale aveva emesso l’editto che istituiva il Tribunale (ricordiamo che per i
Tribunali dell’Inquisizione agivano da una parte l’imperatore con il Tribunale
secolare o civile e dall’altra il papa con quello ecclesiastico e come abbiamo
detto. per la polemica con i monarchi spagnoli il papa incoraggiava
segretamente la resistenza dei napoletani!), su suggerimento del cardinale di
Burgos, fratello del viceré, il quale aveva mostrato l’editto agli Eletti e
agli Avvocati della città i quali rifiutarono quello ecclesiastico, e il viceré
concesse quello secolare; non volle però che se ne facesse pubblicità,
all’infuori di un cartello affisso al portone dell’Arcivescovado, temendo un
sollevamento popolare.
Nel
frattempo il viceré ordinava a Domenico Terracina, Eletto del popolo, di
convincere gli altri rappresentanti delle Piazze a mantenere la calma in quanto
Ma
nonostante tutti questi accorgimenti, la notizia si propagò per tutta la città
e ne venne fuori un tumulto di popolo che malediceva il viceré e i propri
rappresentanti, chiamandoli traditori
della patria; insorsero anche i nobili che ne approfittarono per vendicarsi
di Toledo che odiavano in segreto, unendosi anche ai popolani che (inaudito!) chiamavano fratelli (!) sollecitandoli a stare in guardia e non fidarsi del
viceré che voleva
Il
Terracina sospettato di non fare i loro interessi, fu sostituito con Giovanni Pascale e furono
nominati Deputati ai quali fu ordinato di
non occuparsi d’altro che l’Inquisizione fosse allontanata dalla città e
facessero attenzione che non trasparissero dai loro comportamenti atti di
ribellione; essi, con ogni sottomissione si recarono dal viceré pregandolo di
non fare introdurre l’Inquisizione che avrebbe annullato tutti i benefici che
egli aveva apportato alla città”.
Nel
frattempo il Tribunale della Vicaria (su disposizione del viceré) procedeva all’ arresto di Tommaso Aniello (*),
un “compagnone” che aveva gran
seguito, ritenuto uno dei fautori della sommossa, il quale aveva tolto dal
portone dell’Arcivescovado l’editto e lo aveva strappato; mentre Aniello era
portato alla Vicaria un’intera folla lo aveva accompagnato e si era fermata
sotto il castello, rimanendo in attesa; il Reggente Girolamo Fonseca, nel
vedere tanta moltitudine, giudicò opportuno rilasciarlo e preso dal marchese di
S. Lucido Ferrante Carafa sul proprio cavallo, fu portato in giro per le piazze
della città per acquietare la popolazione.
La
stessa sorte era toccata a Cesare Mormile nobile del Seggio di Porta Nuova,
amato dal popolo, che il Reggente giudicò opportuno rilasciare.
Tutto
ciò indispose il viceré che dissimulando il dispiacere, decise di aspettare il
momento opportuno per il castigo!
Quanto
agli “eretici”, essi si riunivano
liberamente, ma il Vicario generale, ottenuto il consenso del viceré (che
evidentemente faceva un sottile doppio gioco!), gli prestava il braccio secolare e di propria
iniziativa li faceva arrestare e li mandava a Roma ed esaminati “tutti si
mettevano nelle braccia della Madre Chiesa” (vale a dire che ritrattavano) e fatta la penitenza venivano
liberati: così si ritenne la città e il regno purgati dall’eresia!
*)
Da non confondere con il Tommaso Aniello
detto “Masaniello” capo della rivolta di maggior portata del 1647.
GIRO
DI VITE
DEL PAPA
PAOLO
IV CARAFA
Il
papa Paolo IV (Gian Pietro Carafa) poco
prima di morire (1558), per rafforzare ulteriormente la posizione della Inquisizione,
le assegnava il titolo di “Santissima”,
per dare ai suoi giudicati il crisma della “santità”
in modo che fossero considerati “giusti e inappellabili” e pubblicò una
inaudita, allucinante e abominevole Costituzione
in cui dichiarava che tutti i “prelati,
principi, re e imperatori caduti in eresia dovevano ritenersi privati di Beni,
Stati, Regni e Imperi, senza bisogno di specifica dichiarazione, e occupati dai
cattolici fossero restituiti solo dalla Sede Apostolica”...aggiungendo che
i Tribunali ecclesiastici non solo si sarebbero occupati di eresia, ma la loro
competenza sarebbe stata estesa ai delitti ordinari (di competenza dei giudici
secolari!).
Paolo
IV Carafa (1555-1559) era stato così odiato che quando morì i romani
distrussero la sua statua in Campidoglio, aprirono i cancelli delle carceri di
Roma e diedero fuoco agli uffici della Inquisizione dove furono bruciati tutti
gli archivi e poco mancò che fosse dato fuoco anche al vicino convento della
Minerva, sede dei detestati domenicani, impedito da Giuliano Cesarini.
Dopo
che Filippo II aveva in Spagna istituito (1558), con pompa teatrale, i
Tribunali che giudicavano con
spietatezza non solo accusati di eresia, ma ebrei (conversos) e mori (moriscos) e processavano perfino i morti che, condannati, venivano bruciati
in effige (in Italia era giunta la fama del perverso Torquemada), aveva chiesto
al papa Paolo IV la istituzione a Milano e Napoli, dei Tribunali come quelli di
Spagna; a Milano stava per scoppiare una rivolta fugata dall’intervento di
Consalvo da Cordova che diede assicurazioni che il Tribunale non sarebbe stato
istituito.
A
Napoli, erano stati giudicati per eresia e condannati a morte Giovan Francesco d’Alois di
Caserta e Giovan Berardino Gargano di Aversa (1564),
decapitati in piazza Mercato e i loro corpi bruciati, con la confisca dei loro
beni; i napoletani, vedendo che non si teneva conto di quanto stabilito nella
bolla emessa dal papa Giulio III (1550-55) e accordato dal’imperatore, che nel
Regno non potessero essere confiscati i beni degli eretici, si ebbe il fondato
sospetto che Tribunale ecclesiastico e quello secolare avessero concertato di
dar luogo ugualmente al Tribunale dell’Inquisizione, molte famiglie, temendo
una rivolta, come poi avvenne,
preferirono andar via dalla città; vi furono assemblee e furono mandati
dei rappresentanti presso il viceré duca di Alcalà, il quale per prudenza,
oppose il silenzio e la cittadinanza non soddisfatta, inviò un rappresentante
dal re in Spagna; la scelta cadde sull’arcivescovo di Napoli, il cardinale
Paolo d’Arezzo il quale giunto a Madrid
(1564), ben accolto dal re, ottenne ciò che i napoletani chiedevano (con tre
lettere del 1565, due per la città e una per il viceré) che non sarebbe stata
istituita la Inquisizione e che i giudizi in materia di religione sarebbero
stati trattati dal Tribunale ordinario; non mancarono tentativi anche nel
secolo successivo di istituire l’Inquisizione, ma le resistenze furono tali che
nel regno di Napoli riuscirono vani.
I
vari arcivescovi, sottilmente e segretamente erano riusciti a introdurre
ugualmente una specie di Inquisizione avendo introdotto carceri proprie e
personale proprio (consultori e notai), con sigillo proprio e la targa con la
scritta Santo Uffizio per formare
propri e segreti, e alla nomina come arcivescovo del cardinale Spinelli,
regnante Carlo III, v. P.III) si trovò
di fronte a questo stato di cose.
L’Eletto
del popolo fu incaricato di lamentarsene con il re il quale con un editto
(1746) abolì tutto quell’apparato, bandì due canonici, e ordinò che la Curia ecclòesiastica potesse procedere solo per via ordinaria per
i propri processi, ma dandone comunicazione al Tribunale secolare; ma poiché
gli abusi continuavano, l’editto emesso da Carlo III, sarà rinnovato con
Ferdinando IV (1761) e fu proibito alle autorità ecclesiastiche di emettere
editti o provvedimenti che non fossero stati esaminati prima dalla Real Camera.
RIVOLTA DELLA
POPOLAZIONE
CONTRO
L’INQUISIZIONE
|
D |
urante
il viceregno di don Pedro Toledo, dopo le assicurazioni che egli aveva dato relativamente
alla non istituzione della Inquisizione a Napoli (1547), aveva fatto venire in
città tremila soldati spagnoli alloggiati in Castelnuovo; alcuni di costoro erano
usciti dal castello, superando il fossato e ciò aveva indispettito i popolani
che prese le armi si diressero verso il castello; gli spagnoli cominciarono a
sparare e i popolani si riversarono nella Rua Catalana (c.d. quartieri
spagnoli) dove si diedero al saccheggio, uccidendo uomini, donne e bambini; fu
suonata la campana di san Lorenzo; i castelli incominciarono a sparare cannonate
sulla città; gli spagnoli che venivano trovati per strada erano trucidati e
fatti a pezzi; giunta la sera le acque si calmarono, ma riprese nei giorni
successivi e la rivolta durò diversi giorni (secondo Giannone durò quindici
giorni, altri parlano di tre).
Il
viceré sdegnato sosteneva che la città aveva commesso una
ribellione; si riunirono i giureconsulti e tra costoro Giovan Angelo Pisanello, che stabilirono che la città non poteva essere
accusata di ribellione e occorreva conservarla al suo re e si decise di
arruolare soldati per la sua difesa dando incarico a Giovan
Francesco Caracciolo Priore di Bari, a Cesare Mormile e a Giovanni Marzano di
Sessa, Eletto del Popolo.
A
inasprire gli animi si verificava un nuovo avvenimento (maggio 1547): veniva
condotto in prigione un individuo arrestato per debiti; un gruppo di giovani
gli chiese come mai fosse stato arrestato e l’individuo rispose falsamente che
“era stato arrestato per conto
dell'Inquisizione”; al che i giovani lo liberarono e lo fecero fuggire; ma
costoro furono subito fatti ricercare dal Reggente e su cinque arrestati ne
furono trattenuti tre e portati in Castelnuovo; fu emessa una sentenza che
doveva essere di esempio (alcuni consiglieri erano stati forzati a firmarla),
che condannava a morte i tre giovani e l'esecuzione ebbe luogo nel largo di
fronte a piazza dell’Olmo; ciò non fece che inasprire ulteriormente la
popolazione già in armi.
Il
viceré al fine di calmare il popolo pensò di fare una passeggiata per la città (nonostante
i deputati gliel’avessero sconsigliata) con il suo seguito di nobili, ma anche
di soldati; nessuno del popolo, contrariamente a come si era sempre comportato
in precedenza, gli rivolse alcun cenno di saluto e la cavalcata fu considerata
fatta per disprezzo.
SI
MANDANO
AMBASCIATORI
DALL’IMPERATORE
|
D |
opo
aver tenuto un pubblico Consiglio, per opporsi alla Inquisizione, si decise di
fare una “unione” tra nobili e popolo
e di mandare degli ambasciatori dall’imperatore; fu eletto ambasciatore il
principe di Salerno Ferrante Sanseverino, nemico di don Pedro (*), accompagnato
da Placido di Sangro.
Il
principe Sanseverino prima di partire si
recò in visita dal viceré il quale gli disse che non c’era bisogno di andare
dall’imperatore in quanto era già stato concordato che l’Inquisizione non
sarebbe stata istituita e comunque egli dava la sua parola di far pervenire un
decreto dell’imperatore che avrebbe confermato che essa non sarebbe mai stata
messa a Napoli; ma il principe rispose che non poteva non andare in quanto era
stato incaricato dalla città, e andò via.
Il
viceré da parte sua (era stato così stabilito) aveva nominato il marchese della
Valle come ambasciatore al quale aveva dato lettere per Carlo V (che si trovava
a Norimberga), in cui raccontava tutto ciò che nel frattempo era avvenuto a
Napoli.
Mentre
il principe Sanseverino si fermava a Roma, il marchese Della Valle aveva proseguito
per Norimberga e aveva consegnato all’imperatore le lettere del viceré, sì che
quando giunse Sanseverino, Carlo V era già informato di tutto ciò che era
accaduto a Napoli: la sua risposta, mandata per iscritto a don Pedro, era che il viceré doveva essere considerato come
la sua stessa persona.
Il
principe Sanseverino alla corte dell’imperatore non aveva riscosso molto
credito e si dubitava anche della sua legittimità di ambasciatore, per non
essere stato eletto da tutte le Piazze e fu richiesto a Napoli che mandasse
nuovi ambasciatori che confermassero le richieste del principe; furono mandati
Giulio Cesare Caracciolo per i nobili e Giovan
Battista Pino per il popolo.
Al
suo ritorno a Napoli il principe Sanseverino riferì di aver parlato con
l’imperatore della sostituzione del viceré e che l’imperatore gli aveva
promesso la sostituzione (!), poi si recò con un gran seguito di nobili dal
viceré che diede ordine di far entrare solo lui e lasciar fuori gli
accompagnatori.
Il
viceré lo ricevette assiso nella sala del trono; il principe cominciò a fargli
il resoconto dell’ambasciata ma don Pedro che era già stato reso edotto di
tutto, anche della richiesta fatta dal principe all’imperatore di sostituirlo
con altro viceré, tagliò corto e gli disse: “principe,
sono al corrente di tutto ciò che avete discusso con l’imperatore e anche
quello che state trattando a Napoli, mettetevi la mente in quiete e attendete a
servire sua maestà, perché delle cose passate tra me e voi non se ne parli più,
come se non fossero mai avvenute”... dopo di che lo licenzio!
In
questo periodo vi era stata una tregua e la città era desiderosa di conoscere
la risposta dell’imperatore; don Pedro era in Castelnuovo (era il mese di
agosto) e fece chiamare i delegati che entrati nel castello furono terrorizzati
dal fatto che alle loro spalle era stato alzato il ponte levatoio, ma il viceré
li rassicurò dicendo che perdonava la città e considerava non avvenuta alcuna
ribellione e che se essi (Cesare Mormile, Caracciolo e Giovanni di Sessa)
fossero andati da sua maestà
(ricordiamo che questo titolo era stato usato per la prima volta da Carlo V
dopo la sua incoronazione a Bologna, ne parleremo nei citati articoli in
preparazione su Carlo V tra Rinascimento, Riforma e Controriforma) avrebbero
avuto ugual giustizia.
I
tre delegati andarono via felici per lo scampato pericolo e lieti di dare la
buona novella alla città ....ma dopo alcune ore fu pubblicato un bando che
annunciava che l’imperatore escludeva la grazia per trenta persone tra le quali
erano compresi i tre delegati, che venuti a conoscenza del bando si diedero
alla fuga e di loro fu preso solo Placido di Sangro.
Il
viceré diede ordine che nessun altro di quelli che avevano commesso reati
durante la rivolta fosse arrestato, neanche quelli che gli avevano saccheggiato
il suo podere a Pozzuoli; e successivamente molti furono graziati, escluso Cesare
Mormile e Giovan Vincenzo Brancaccio che fu subito
preso e gli fu tagliata la testa.
Per
i nobili che erano andati a servire il re di Francia come il principe di
Salerno, fu disposta la confisca dei beni (il principe Sanseverino aveva a
Napoli un magnifico palazzo con facciata bugnata a diamante che divenne Casa e
Chiesa dei Gesuiti).
Nel
frattempo giunse una lettera ufficiale dell’imperatore che dichiarando la città
“fedelissima” e perdonando gli
eccessi, irrogava una penale di centomila ducati e confermava che tutto ciò che
il viceré aveva detto e fatto era da considerare come “sua volontà” e per
l’avvenire doveva essere considerato come la sua stessa persona.
*)
I Sanseverino, principi di Salerno, erano sempre stati nemici degli aragonesi,
Roberto, padre di Ferrante e l’avo Antonello, avevano seguito il re di Francia
con le armi; dichiarati dagli aragonesi ribelli, erano stati privati dei loro
feudi.
Ferdinando
il Cattolico in occasione della pace stipulata con il re di Francia, aveva
restituito i feudi ai baroni che ne erano stati espropriati e tra costoro fu
graziato anche Roberto Sanseverino al quale Ferdinando aveva dato in moglie la
figlia del duca di Villaermosa, suo fratello
naturale.
Da
costoro nacque Ferrante educato in Spagna sotto le cure di Bernardo di Villamarino, conte di Capaccio (poi Luogotenente generale
del Regno di Napoli) del quale Ferrante sposò l’unica figlia ereditando il
feudo alla morte del padre; Ferrante aveva ereditato anche il ducato di Villaermosa (in Spagna), rendendo le sue ricchezze,
immense; non avendo figli, aveva tentato di far apparire la moglie incinta, ma
il viceré, per mezzo del Fisco al quale andavano i beni dei feudatari quando
non vi erano eredi, inviò dei commissari
per assistere al parto, che non ebbe esito.
I
rapporti tra Ferrante e don Pedro inizialmente erano stati di buona amicizia,
ma per la lotta condotta da don Pedro contro le prepotenze dei nobili e le
altre vicende (indicate nel capitolo che segue), i rapporti si rabbuiarono fino
a diventare odio celato.
Il
principe, di media statura, bel viso, biondo con occhi chiari, di animo
magnanimo e liberale, di vivace
intelletto e di piacevole favella, presso la sua corte ospitava uomini di
ingegno e rappresentanti di ogni campo del sapere; tra i primi nobili d’Italia
e di Spagna poteva essere considerato un sovrano piuttosto che un vassallo del
re; a questi pregi però corrispondevano altrettanti difetti; era infatti
altezzoso, superbo e pieno di sé, covava odi e risentimenti, aveva amicizie di
basso livello e di malavitolosi istinti, ma
soprattutto aveva un forte debole per le donne.
Avido
di gloria, amava la magnificenza e il fasto che, da una parte gli conciliavano
l’ossequio dei nobili, dall’altra suscitavano l’invidia e la gelosia dei sovrani
che seppur egli fosse di nascita e di parentado elevati, si sentivano
defraudati di una parte degli onori che volevano fossero solo ad essi riservati:
l’alterigia e la ribellione lo condussero alla sua misera fine.
LA
RIBELLIONE DEL
PRINCIPE
SANSEVERINO
E
DI ANTONIO GRISONE
|
I |
l
principe Sanseverino da Napoli si stava recando a Salerno (1551) e durante il
viaggio era stato ferito al ginocchio con un colpo di archibugio da Persio di
Ruggiero, gentiluomo salernitano, il quale fu subito arrestato e portato in
prigione a Napoli dove, sotto tortura, confessò che lo aveva fatto per una
questione d’onore.
Ma
il principe aveva sospettato che il mandante fosse stato il viceré, per cui il
processo andò in certo qual modo per le lunghe, al fine di accertare questo
sospetto che risultò infondato, per cui Persio
condannato a morte continuò ad affermare la sua versione; fu comunque
decapitato.
Con
il viceré non correva buon sangue in quanto poco tempo prima il viceré lo aveva
fatto citare per una questione relativa a diritti della dogana di Salerno che
sarebbero stati riscossi dal principe abusivamente, con tutte le rendite
riscosse dalla sua famiglia; era risultato che doveva essere restituita una
cifra astronomica tale che avrebbe portato via al principe tutto il suo principato,
ma la pretesa era infondata.
Il
principe, una volta guarito se ne andò via dal regno recandosi a Padova,
dicendo che doveva curare una lesione del nervo dovuto alla ferita subita: lo
scopo però era quello di ribellarsi all’imperatore passando a servire il re di
Francia.
Sanseverino
per giustificarsi con la città di Napoli per il suo comportamento, aveva fatto
pubblicare un manifesto in cui diceva di aver prestato molti servigi, anche con
le armi, all’imperatore, e di aver ricevuto in cambio, dall’imperatore e dai
suoi ministri pessime ricompense.
Avutane
notizia il viceré aveva commentato che il principe aveva omesso di dire nel manifesto che la maggior ricompensa
ricevuta dell’imperatore era costituita dalla donazione del più grande e bel
principato, come era quello di Salerno; gli fu fatto subito un processo che
dichiarandolo ribelle, lo condannava a morte,
con la confisca del principato di Salerno con tutte le sue dipendenze.
La
ribellione del principe non era considerata cosa nuova in quanto da tempo egli, recandosi presso la corte di Francia, si era
lasciato prendere dalla devozione nei confronti di quel re di cui raccontava le
liberalità e a Salerno si faceva servire alla
francese con tutte quelle usanze,
delle quali il viceré era costantemente tenuto informato!
Recatosi
in Francia il re (Enrico II succeduto a Francesco I), gli affidava il comando
di galere partite per Costantinopoli, dove il principe si fermò per tutto
l’inverno in attesa di avere da Solimano il Magnifico l’aiuto promesso, essendo
stata concordata con il re di Francia la conquista del Regno di Napoli.
Nel
frattempo una parte della flotta turca formata da centocinquanta navi partita
da Costantinopoli (1552) al comando di Sinan Pascià e sotto la guida di Dragut Rais, metteva le ancore presso Procida, con gran
spavento della popolazione di Napoli,
anche perché giornalmente alcune navi turche si recavano a Capo
Posillipo dove si scontravano con navi genovesi che si trovavano in quella
zona; la flotta turca si fermò dal quindici luglio al dieci agosto e andò via dopo
che il viceré per mezzo di Cesare Mormile aveva versato a Sinan Pascià la somma
di duecentomila ducati.
Antonio
Grisone, vassallo di Sanseverino, gli aveva scritto una lettera cifrata per sollecitare il re di
Francia a mandare l’esercito per la conquista del regno; la lettera era stata intercettata e consegnata al viceré che lo
fece subito arrestare e condurre nelle prigioni di Castelnuovo dove, dopo aver
confessato sotto tortura, fu condannato a morte e decapitato nel largo del
castello dove di solito avvenivano le esecuzioni.
Il
principe (da sempre sensibile al fascino femminile) nel periodo passato a Costantinopoli
si era dato agli amori e alle dissolutezze, perdendo così la stima di Solimano;
tornando in Francia si era dato a sostenere la causa degli ugonotti, perdendo
tutti i contatti con la Corte; ultimo dei principi di Salerno, morirà ad
Avignone (1568) ridotto in miseria, all’età di settantun anni.
La
esecuzione del suo vassallo Grisone aveva suscitato il cordoglio generale in
quanto benvoluto da tutti e i nobili nel parlarne con il viceré si erano
sentiti rispondere che Grisone “da una parte mostrava la sua grande fedeltà
alla corona di Napoli, dall’altra ingannava tutti in quanto era astuto,
arrischiato, di gran parentado, di molti amici, di gran credito nelle cose
pubbliche e ciò faceva ritenere che nessun cittadino avrebbe rifiutato a
seguirlo nella ribellione” (per la ventilata conquista del regno ndr.)!
CIRCA
UN SECOLO E MEZZO
DOPO
IL VICERE’ TOLEDO
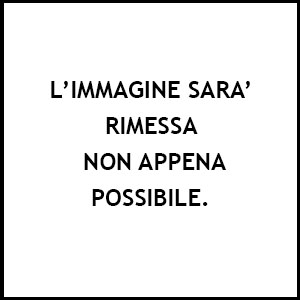
L’IMPERATORE
D’AUSTRIA
LEOPOLDO I
|
L |
eopoldo I (1657-1705) era secondogenito
destinato alla carriera ecclesiastica, ma la morte prematura del fratello
Ferdinando IV (1654) aveva portato al trono questa seconda linea degli Asburgo
viennesi.
Aveva dovuto affrontare guerre, con i turchi
che con Kara Mustafà erano arrivati a Vienna (1683) e con Luigi XVI, e aveva
potuto uscirne con soddisfazione avendo come generale il brillante principe
Eugenio di Savoia.
Leopoldo era uomo di spirito (lo vediamo
dipinto nel celebre ritratto in abito di teatrante!), che non abbandonò neanche
in punto di morte, avendo osservato che al suo letto erano state accese due
candele, facendo notare che per l’imperatore dovevano essere quattro; amante del teatro e dell’arte, anche dal
punto di vista artistico il suo periodo era stato fortunato essendo stato il
periodo del “rococò” il barocco
imperiale che si diffonderà in tutta Europa.
Aveva avuto tre mogli, la prima delle quali
era la nipote Margherita figlia di suo zio Ferdinando IV di Spagna che aveva
sposato sua sorella Marianna!).
Leopoldo I vantava i suoi diritti sul trono
di Spagna a causa della rinuncia fatta da Maria Teresa quando aveva sposato
Luigi XIV (come sorella di Carlo II) per cui egli era il parente più prossimo
(in mancanza di principi austriaci, seguiva il duca Vittorio Amedeo di Savoia
discendente da Caterina figlia di Filippo II di Spagna) e come avente
diritto avanzava le sue pretese per il
figlio secondogenito arciduca Carlo (1685-1740).
Si opponeva però Luigi XIV il quale, sebbene
la moglie avesse rinunciato ai diritti di successione, li faceva valere
ugualmente... e il re Sole quando c’era da far valere dei diritti...non si
risparmiava le guerre!... e fece scoppiare una guerra di successione tra
Francia e Austria durata tredici anni.
Morto Leopoldo I, gli succede come
imperatore il figlio Giuseppe I; morto prematuramente di vaiolo (1711) gli
succede il fratello arciduca Carlo, VI come imperatore, III come re di Napoli e
nominalmente di Spagna (in quanto sul trono
come vedremo, vi era Filippo V), IV di Sicilia.
Carlo VI aveva sposato Elisabetta Cristina
di Brunswick-Wolfenbȕttel, da cui ebbe due
figlie femmine Maria Teresa, poi imperatrice di felicissima memoria, che sposò
Francesco Stefano di Lorena e la sorella Maria Anna che sposò il fratello Carlo
di Lorena.
Carlo VI continuò a volersi impadronire del
Regno di Napoli (l’ingordigia dei grandi è pari al livello da essi raggiunto!)
e riuscì anche a spuntarla, come vedremo.
Sul trono di Spagna, appena morto Carlo II
(1700), si insedia Filippo V, primo della dinastia dei Borbone che come dinastia sarà di breve
durata e il suo regno sarà contrastato non solo con le rivendicazioni di
Leopoldo I e di Giuseppe I e dell’arciduca
Carlo, ma sarà lo stesso arciduca Carlo a recarsi a combattere in Spagna dove
Valenza e Barcellona gli si ribellarono (1706) passando dalla parte dell’impero
austriaco; giunto in Italia, dopo aver conquistato il milanese, passò a
occupare Napoli, come vedremo più avanti.
CARLO II
RE DI SPAGNA
E
DELLE
DUE SICILIE
E
FILIPPO
V
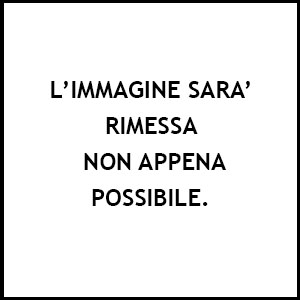
Carlo II con collana del Toson d’Oro
|
A |
lla
morte di Filippo IV di Spagna (1605-1665), del ramo Asburgo di Spagna, era
stato incoronato all’età di cinque anni il figlio, avuto dalla moglie Maria Anna
d’Asburgo-Austria (*) col nome di Carlo II (1661-1700), come re di Spagna,
(Carlo IV come re di Napoli e Carlo III come re di Sicilia); essendo fanciullo,
governava la madre con il consiglio di
reggenza.
Carlo
II portava impresso nel volto l’accentuato prognatismo con il labbro inferiore
pendulo degli Asburgo, per la maggior parte brutti...ma erano re e
imperatori...e non si faceva caso! La natura pensava invece a far belli i
bastardi (p.es. la figlia di Carlo V che aveva sposato Alessandro de’ Medici,
prima e Ottavio Farnese dopo, o don Giovanni, fratellastro di Filippo II), nati
fuori dall’intreccio dei matrimoni combinati.
Contrariamente
al fratellastro bastardo don Giovanni, in buona salute (escluso dalla successione),
Carlo quando nacque era così piccolo che non poteva essere fasciato e fu messo
in una scatola piena di cotone e crescendo non riusciva a camminare, tenuto
(con la bocca che penzolava aperta) fino all’età di dieci anni tra le braccia
delle dame di corte; era affetto da rachitismo e da acromegalia, malattia ormonale della crescita (scoperta nel 1886),
che colpiva vari organi compresa la sessualità per cui era anche impotente; era
debole di carattere e d’intelligenza al limite dell’imbecillità, era triste e
malinconico e quel che é peggio, inavvicinabile in quanto emanava un odore
nauseabondo perché non si lavava.
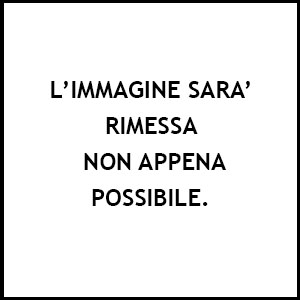 |
| Maria Luisa d’Orleans |
Aveva avuto due mogli giovani e belle: Maria
Luisa d’Orleans detta “mademoiselle”
(nipote di Luigi XIV, figlia del fratello Filippo d’Orleans e di Enrichetta Stuart),
morta (1689) si diceva, avvelenata da Maria Mancini (ma l’accusa era del tutto
infondata), nipote del cardinale Mazzarino e moglie del principe Lorenzo
Onofrio Colonna, Connestabile di Napoli; di spirito libero e insofferente aveva
lasciato il marito e da Roma si era recata in Spagna dove dopo varie vicissitudini,
fuggita da un convento, fu imprigionata nel castello di Segovia.
In
seconde nozze Carlo II sposa Marianna di
Neuburg; ambedue le mogli erano state ritenute
sterili, ma piuttosto dovuta alle sue pessime condizioni di salute che gli
consentirono di vivere fino all’età di trentanove anni.
Maria
Luisa si rammaricava con lo zio Luigi XIV per averla destinata a quel
matrimonio (lei anelava a sposare il cugino Delfino che peraltro le premorì!);
il re per incoraggiarla le aveva detto “di
non aver potuto ottenere una più grande alleanza per la propria figlia” ed essa rispose: “Ah, sire, ma avreste potuto far meglio per vostra nipote”!
Essendo
da tempo malato, Carlo II aveva redatto un primo testamento (1698) col quale
nominava erede il nipote figlio dell’Elettore di Baviera (che aveva sposato sua
sorella), ma questo nel frattempo moriva e Carlo II fece un secondo testamento
con il quale nominava erede Filippo di Borbone, duca d’Angiò secondogenito (in
quanto alla linea primogenita era riservata la successione al regno di Francia),
del Delfino duca di Borgogna; questo morirà di vaiolo e il suo primogenito alla morte di Luigi XIV (1715) diventerà Luigi XV (**).
Uno dei capolavori politici del cardinale Mazzarino era
stata la pace dei Pirenei (1659) dalla quale era derivato il duplice matrimonio
tra Luigi XIV e Maria Teresa (1638-1683), figlia di Filippo IV e il figlio Carlo
con Maria Luisa d’Orleans, il quale, come
detto, nel secondo testamento, nominava come primo
erede al trono di Spagna il suo pronipote (e di Luigi XIV), Filippo d’Angiò, a patto che i
domini spagnoli rimanessero uniti e che i suoi eredi rinunciassero ad ogni
diritto sulla corona di Francia.
Così Filippo di Borbone duca d’Angiò poté salire sul
trono di Spagna col nome di Filippo V
(1700-1746), inizialmente senza dar luogo a complicazioni, emerse non appena
Luigi XIV pretese che il nipote, contrariamente agli accordi, conservasse i
diritti al trono francese.
Contro la Francia che non si atteneva ai patti, si
formava una lega e venne combattuta la Guerra per la
successione di Spagna (dal 1701 al 1713), durante la quale le armi francesi subirono dure sconfitte: in
conclusione il trono di Spagna rimase a
Filippo V, pur essendo stata
*)
Da uno studio di genetica di docenti dell’Università di Santiago di Compostela sugli Asburgo di Spagna, nel caso di ripetuti
matrimoni tra consanguinei, e nel caso specifico di Carlo II, il tasso di
accumulo di gemi era di 1 su 4 pari al
25,4% pari al tasso che si riscontra nei figli generati da incesti stretti come
padre e figlia o fratelli e sorelle.
**)
Luigi XIV aveva avuto il figlio Luigi 1° Delfino (morto di rosolia il 1711) il
cui primogenito, duca di Borgogna (2° Delfino) era morto l’anno successivo di
vaiolo (1712); questo aveva avuto due figli, il primogenito moriva lo stesso
anno (1712); il secondogenito, 3° Delfino, sarà Luigi XV; il secondogenito del 1° Delfino era Filippo,
duca d’Angiò (che aveva sposato Maria Gabriella di Savoia), divenuto Filippo V
re di Spagna, v. in Genealogie i Borboni di Francia.
TRA GUERRE E
TRATTATI VIOLATI
DEI PAESI EUROPEI
|
L |
a proclamazione di Filippo d’Angiò (1683-1746) come
Filippo V aveva avuto luogo a Versailles (1701) e subito dopo la sua
proclamazione egli si reca a Madrid; ciò suscita le preoccupazioni non solo
dell’Austria, diretta interessata, ma anche dell’Inghilterra, dei Paesi Bassi,
del Portogallo (con Pietro II) e del ducato di Savoia (con Vittorio Amedeo II),
che si uniscono per far rispettare il trattato dell’’Aia (1698) in cui era
stato riconosciuto erede Giuseppe Ferdinando di Baviera (che aveva sposato
Margherita seconda figlia di Filippo IV), mentre i territori al di fuori della
Spagna (in Europa) sarebbero stati da dividere tra Austria e Francia.
Si combattè nei Paesi Bassi, in
Germania e nel Nord Italia; gli inglesi occupano Gibilterra (1704); l’arciduca
Carlo si insedia a Barcellona (1706) dove viene proclamato re dagli abitanti
della Catalogna e dell’Aragona e gli anglo- portoghesi impossessatisi per pochi
giorni di Madrid lo proclamano re di Spagna; i francesi sono costretti a
ritirarsi dal Milanese; il duca di Marlborough si
impadronisce dei Paesi Bassi spagnoli.
In Austria muore Giuseppe I e il fratello, l’arciduca
Carlo, diventa imperatore, mentre le truppe francesi comandate da Vendôme, rafforzano
la posizione di Filippo V che possiede tutta
Gli stati ancora in guerra firmano (1713) il trattato di Utrecht
(*) in base al quale Filippo V è riconosciuto re di Spagna e delle Indie, con
rinuncia ai diritti di successione in Francia;
Filippo V dopo la morte di Maria Luisa di Savoia (1714),
sposa Elisabetta Farnese erede dei ducato di Parma e Piacenza (avente diritto
di successione sulla Toscana in
quanto discendente da Margherita de’
Medici figlia del Granduca Cosimo III) e vuole rientrare nel possesso dei territori
italiani; il suo tentativo di impadronirsi della Sardegna e Sicilia non riesce
in quanto si trova contro Inghilterra, Francia, Olanda e Austria; viene firmata
la pace dell’Aia (1720) in base alla quale
In seguito a un’ulteriore guerra di successione polacca
(1733-38)
Ma riprende un’altra guerra di successione austriaca (1740-1748) durante la quale Spagna e Francia
stipulano un secondo patto di famiglia
in base al quale all’Infante Filippo verrebbero assegnati Milano e Parma, ma, nel
frattempo Filippo V muore (1746) e gli succede
il figlio di primo letto Ferdinando VI (1746-1759).
A questo punto, gli austriaci sono padroni dell’Italia
settentrionale e stanno per attaccare Napoli, per cui si giunge alla pace di
Aquisgrana (1748) con la quale i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla sono
assegnati all’Infante Filippo, nel frattempo divenuto Ferdinando VI, il quale muore senza figli e gli succede il fratello Carlo
III re di Napoli.
Carlo partendo per la Spagna, lascia il regno al figlio
Ferdinando...le guerre continuano, ma (per fortuna di chi scrive che non le
ama!) non riguardano il Regno di Napoli che dopo la carrellata partita dalla
formazione dei Seggi, passando per il periodo fondamentale per Napoli, del
passaggio verso l’era moderna con il viceré Toledo, passiamo a esaminare nelle
due parti successive il periodo del viceregno
di Medina-Coeli, che aveva dovuto tenere energicamente a bada la violenta e
anarcoide nobiltà sempre ribelle a ogni forma di legalità e al focolaio di ribellione che - non unico - era emerso con la congiura di Macchia.
*)
TRATTATO DI UTRECHT (11.iv.1713) fra Inghilterra, Olanda, Portogallo, Savoia,
Prussia,Francia, Spagna si stabilisca la rinuncia di Filippo, per sé e suoi
discendenti, al regno di Francia e dei
duchi di Berry e d’Orleans; a Filippo rimanevano
FINE
PARTE GENERALE
