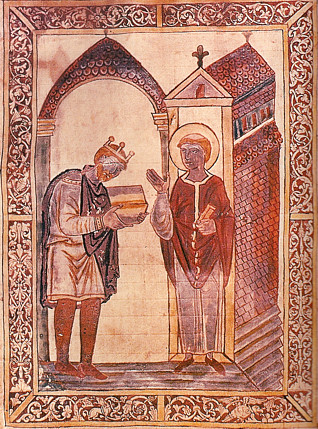
GLI ULTIMI
CAROLINGI
di
Michele Ducas Puglia
PARTE PRIMA
Carlomagno sul letto
di morte
miniatura del XVmo
sec.
SOMMARIO PARTE PRIMA: LUDOVICO IL PIO DIVIDE L’IMPERO
ASSEGNANDOLO AI SUOI TRE FIGLI; I FIGLI DI LUDOVICO IL PIO DIVENTANO QUATTRO;
L’AQUITANIA;
SOMMARIO PARTE SECONDA:
LUDOVICO IV D’OLTREMARE NIPOTE DI ATHELSTAN DI BRITANNIA LUDOVICO IV PRIGIONIERO A ROUEN; LA
“QUERELLE” DEL VESCOVADO CONTESO DAL NIPOTE DEL DUCA UGO DI FRANCIA; LUDOVICO V
FENEANT; IL SINODO DI INGHELHEIM E
GLI ULTIMI GIORNI DI LUDOVICO D’OLTREMARE; LOTARIO; CARLO DI LORENA ESTROMESSO
DALLA SUCCESSIONE; L’ASSEMBLEA DI SENLIS RIUNITA PER GIUDICARE ADALBERONE ELEGGE
UGO CAPETO RE DI FRANCIA; UGO CAPETO E L’ORIGINE DELLE DINASTIE; CAUSE DELLA
DISSOLUZIONE DELL’IMPERO CAROLINGIO.
LUDOVICO IL PIO
DIVIDE L’IMPERO ASSEGNANDOLO
AI SUOI PRIMI TRE FIGLI
|
N |
ell’articolo sul “Disfacimento dell’impero Carolingo” abbiamo visto come Carlomagno, lungimirante per tante realizzazioni, non lo era
stato con la “renovatio imperi” alla quale aveva dedicato molti
anni della sua vita, unificando territori (in “Carlomagno e l’Idea dell’Europa”) che avrebbero
dovuto ricostituire l’impero romano
(se mai egli avesse avuto una tale idea!) e avesse commesso il grave errore di
dividere tra i figli viventi, tutto il territorio che costituiva l’impero
conquistato.
Carlo, “augurandosi
che tra i figli regnasse l’armonia”, aveva assegnato (nel placito di Thionville dell’806) a ciascuno di essi (seguendo la tradizione germanica fondarta sulla legge salica), i
vari territori, vanificando l’idea di un impero fondato sull’unione
territoriale, che di fatto, rimaneva un impero semplicemente ideale.
Il Caso aveva
voluto che dei suoi tre figli maschi, due, Lotario e Carlo (le
vicende di Pipino al quale era stato assegnato il regno d’Italia, le
abbiamo esaminate nell’articolo “Storia
sconosciuta dei primi re d’Italia”), morissero prematuramente, e l’impero confluisse nelle mani di
Ludovico il Pio che non solo aveva ripetuto l’errore paterno, dividendolo tra i suoi figli, con
l’aggravante della circostanza che egli stesso non aveva né la “spiccata” personalità del padre, né la giusta “autorevolezza” nei confronti dei figli
tra i quali non regnava “l’armonia”
(come Carlomagno si era augurato per i suoi
figli), ma, litigiosi e ribelli,
tendevano a ingrandire, ciascuno il proprio territorio, non per ricostituire l’impero, come ha suggerito
qualche studioso, perché non erano all’altezza neanche di pensarlo, ma per mera avidità: e solo per questo si erano
combattuti tra di loro rivoltandosi anche contro il padre.
Il suo soprannome di “Pieux”, “Pio” era
dovuto alla dedizione quasi maniacale di praticare i precetti cristiani,
con la richiesta di continui perdoni pubblici e privati per i suoi peccati, umilianti per un imperatore. Tra le sue
occupazioni quotidiane vi era la messa, la lettura di libri di pietà, il canto
dei salmi e continue preghiere... ma quando c’era da tagliar teste in guerra non
si risparmiava; era infatti stato scritto che “aveva l’anima di un monaco e il corpo di un
guerriero”.
Gli era stato dato anche un altro soprannome di “Louis le Debonnaire”
(Louis sta per Ludovico-Hludovic, o altre forme, usato dai cronisti), assegmaogli dai suoi detrattori, non con il significato di
“buono” ma
di “bonario”, vale a dire “dalla mente limitata, non molto acuta”.
Ma, a parte, come detto, la mancanza di personalità che
gli avrebbe dato la caratura paterna,Ludovico aveva
ricevuto una educazione degna di un principe (v. in Articoli: L’educazione del giovane feudatario
ecc.): conosceva il latino
scritto e parlato e il greco da poterlo comprendere; tra le letture vi era s.
Agostino ma conosceva gli storici antichi e i canti germanici. Di carattere era
subdolo, indeciso,
debole e indolente,
peculiarità che nascondeva sotto un aspetto di virilità e
energia.
Era stato messo sul cavallo a tre
anni; a tredici anni aveva ricevuto l’educazione del futuro guerriero, “di media statura, era cresciuto robusto, dal
petto forte con spalle larghe e braccia muscolose; aveva occhi chiari e grandi,
naso lungo e dritto, carnagione chiara”.
Ludovico, quando Carlomagno lo
aveva associato
all’impero (Aquisgrana, 813), si era
pronunciato sulla indivisibilità
dichiarando che “non era lecito spezzare
l’unità del regno ricevuto da Dio, mediante una spartizione fatta dagli
uomini”.
Ma quattro anni dopo la morte del padre (814) si smentiva,
dividendo il suo regno (817) fra i figli e attribuendo anche questa decisione alla volontà di Dio: ma era stata la
moglie Irmengarda a suggerirla dopo l’incidente che
gli era occorso, del crollo della galleria che
collegava il palazzo (di Aquisgrana) alla cappella, su
cui egli si trovava con tutto il suo seguito.
Egli quindi associava al trono il figlio primogenito
Lotario I (che si recava a Roma nello stesso anno, dove lo
incoronava
il papa Pascale I appena eletto); assegnando a Pipino II l’Aquitania e
*)
I TRE FIGLI DI LUDOVICO
IL PIO
DIVENTANO QUATTRO
|
A |
bbiamo visto (nel cit. Art.
sulla Dissoluzione... ecc.) che dopo la morte
della moglie di Ludovico il Pio, Ildegarda (818), i nobili del suo seguito gli avevano
suggerito di sposare Giuditta (figlia di Welf di
Baviera) e unanimamente riconosciuta dai cronisti
dell’epoca di rara bellezza.
Giuditta aveva evidentemente fascino che unito alla scaltrezza usava nei maneggi di corte
(per i suoi rapporti con Bernardo di Settimania v. cit. Articolo “L’educazione del giovame feudatario...ecc.), e nel momento in cui le era nato
il figlio Carlo (823), si era battuta per far valere i diritti che
sarebbero spettati al figlio di una regina, nella difficile situazione di una
divisione dell’impero già predisposta, e giunta inaspettata per gli stessi
nobili che avevano suggerito il matrimonio e trovando degli oppositori, primo
fra tutti il ministro Wala, che si opponeva alla
modifica dei precedenti accordi di
divisione (817).
Giuditta non si era data pace, e agendo su Lotario, designato padrino
e padre spirituale di Carlo (che diventerà Carlo il
Calvo), appoggiato dal padre, riuscì a
ottenere da lui il giuramento di considerarsi tutore e difensore del giovane
fratello contro tutti i suoi nemici e del territorio che il padre gli avrebbe
assegnato.
Probabilmente all’assemblea di Worms (829), o con solo decreto scritto di proprio pugno,
Ludovico il Pio modifica il precedente atto di divisione (817) fra i tre
fratelli e assegna a Carlo il Calvo l’ “Allemania” che comprendeva l’Alsazia,
Per di più Ludovico mette il pargolo
sotto la protezione di Bernardo di Settimania (che era stato a sua volta
tenuto a battesimo dall’imperatore), nominandolo ciambellano di corte (v.
cit. Articolo “L’educazione del giovane
feudatario...ecc..).
Dopo gli avvenimenti (esaminati nel cit.
art. del Disfacimento dell’impero carolingio), che avevano coinvolto i figli di Ludovico il Pio († 840), vediamo
ora il susseguirsi dei loro discendenti che nel giro di qualche generazione
porteranno alla estinzione della dinastia (v. anche in
Genealogie).
Dai primi tre
figli della prima moglie Irmengarda, nascono: (A): Lotario I; (B):
Pipino II; (C): Ludovico il Germanico; e dalla seconda, Giuditta
(D): Carlo il Calvo;
(A). Lotario I, imperatore ha tre
figli: (a1): Ludovico II, (a2): Lotario
II, (a3): Carlo di
Borgogna († 863).
(B): Pipino II
re d’Aquitania (il cui territorio si estendeva dalla Loira ai Pirenei e
come vedremo, suscitava le mire di Carlo il
Calvo), muore (864) senza figli.
(C) Ludovico il Germanico
(† 876) al quale passava il regno germanico; aveva avuto tre
figli (C1): Carlomanno; (C2): Ludovico III e (C3): Carlo il
Grosso;
Da
Giuditta (che
aveva avuto anche una figlia di nome Gisella),
nasce:
(D):
Carlo il Calvo (823-877), il
quale, nonostante fosse stato malvisto, osteggiato e combattuto dagli altri
fratelli, diveniva re di Francia, e per due anni anche
imperatore, incoronato da Giovanni VIII il quale cercava di
avere un protettore, titolo che, come vedremo, poi passerà a
Carlo il Grosso e rimarrà
definitivamente alla Germania.
Carlo il Calvo
(† 879) ha tre figli, Ludovico II il Balbo,
Ludovico III,
morto (882) per
rottura di vena a seguito di uno sforzo durante un’azione, e
Carlomanno, morto (884) a
seguito di emorragia causata da una
ferita durante una partita di caccia.
Vediamo ora che
nel contesto di tutti i territori ereditati da Carlomagno, due erano i principali regni che attiravano le
mire altrui: l’Aquitania, che suscitava i desideri
di chi regnava sui territori di Francia, e
L’AQUITANIA E
L’AQUITANIA
|
E |
ra stata assegnata a
Pipino II, appoggiato da Lotario II; contro costoro
muovono Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo
dai quali sono battuti a Fontenay presso
Auxerre (841).
Carlo e Ludovico, al fine
di contrastare Lotario II, con il giuramento (843) di Strasburgo (antica Argentoratus-Argentina, mentre il
suo nuovo nome deriva da strasse e bourg per la sua posizione di
strada di collegamento con l’Alemania), redigendo il
celebre atto (*) nelle due
lingue todisca (l’atto di Carlo, per essere capito
dagli uomini di Ludovico) e francisca (l’atto
di Ludovico, per essere capito dagli uomini di Carlo) sanciva ufficialmente la
nascita delle due separate nazionalità, tedesca e francese: ma per il loro
consolidamento ci vorrà ancora del tempo!
Nel mese di dicembre di questo stesso anno, Carlo
(ventenne) celebra il matrimonio con Ermentrude figlia
di Modone e Inghiltrude e
nipote di Adalardo il quale,
scrive Nitardo (**), “aveva avuto grande influenza su
Ludovico il Pio facendogli
accordare a chiunque, tutto ciò che a ciascuno piacesse
ottenere” (si trattava nella maggior
parte dei casi delle concessioni fatte ai vassalli che con le altre operate dai
suoi figli, porteranno alla costituzione dei feudi).
In questa spartizione l’Aquitania era stata assegnata a Carlo il Calvo, senza
tener conto che il titolare fosse Pipino II.
Quest’ultimo, come detto, era stato abbandonato da
Lotario II,
sostenuto solo dal suo braccio destro Bernardo di
Settimania che, convocato da Carlo il Calvo, sarà da
questo ucciso (v. cit. Articolo “Educazione del giovane
feudatario...ecc..).
Carlo, a seguito di un
compromesso con Pipino II al quale con il trattato di Sain
Benoit sur Loire (845) aveva lasciato
*) Per l’amore di Dio e per la salvezza del popolo cristiano è nostro comune...., da questo giorno in avanti, fin quando Dio mi darà il sapere-senno e il potere, difenderò mio fratello Carlo (nell’altro: Ludovico) che qui, in suo aiuto e con ogni mezzo e anche per dovere, secondo equità difenderà suo fratello a condizione che anch’egli faccia altrettanto nei miei confronti; e io non prenderò mai nei confronti di Lotario, di mia volontà, nessuna iniziativa che possa danneggiare il detto mio fratello Carlo, ecc..
**) Nitardo
annotava che in quell’anno (843) l’inverno era
stato eccessivamente lungo e rigoroso e
abbondante nelle malattie, molto nocivo all’agricoltura al bestiame e alle
api.
|
L |
’imperatore Lotario
I aveva assegnato al secondo
figlio (A2):
Lotario II
(869), il territorio designato come
Egli muore (863) senza figli e il regno avrebbe dovuto
passare a suo fratello (A1): Ludovico II, imperatore e re d’Italia, il quale, sceso in Italia a
combattere i saraceni che avevano invaso il Sud e i signori del ducato di
Benevento, muore (875) a Brescia (v. in Articoli: Il disfacimento dell’impero carolingio).
Già da prima (869), Carlo il Calvo, di propria
iniziativa, all’insaputa del fratello, si era recato a Metz e si era fatto
incoronare re della Lotaringia.
Il papa Giovanni VIII, alla ricerca di un
protettore, lo trova in Carlo il Calvo
che stava scendendo in Italia (875 ) e lo
incorona nel Natale dello stesso anno; nel febbraio successivo Carlo, sulla via del
ritorno si fa incoronare a Pavia (876) re
d’Italia.
Gli vengono però mandati inviati
da parte di Ludovico il Germanico che gli ingiungono di ritirarsi dalla Lotaringia; Carlo a sua volta propone
la spartizione del territorio, che è subito accettata.
I due convennero, con vescovi e vassalli, Carlo a Herstal e Ludovico a Meersen e dai loro vescovi fu stilato (870) l’atto di
divisione che contiene la dettagliata indicazione di tutte le località a
ciascuno assegnate, con la linea di demarcazione
determinata dai due fiumi dell’Ourthe e della Mosa: a Carlo andava la parte che si trovava a occidente, a Ludovico la
parte che si trovava a oriente, con l’impegno che i due monarchi “non avrebbero cercato di impadronirsi dei
territori aggiudicati, né con la violenza né con scaltrezza”.
Ma tutti questi accorgimenti non valsero a saziare gli
appetiti di Carlo il Calvo il quale alla morte di Ludovico il Germanico
(876) andò a occupare il territorio della Lotaringia, precedentemente assegnato al fratello.
Il figlio di Ludovico il
Germanico, Ludovico III re di
Germania, gli chiese di rinunciare a questo disegno, ma Carlo rimase sordo a tali
rimostranze, per cui il giovane principe andò ad affrontarlo con il suo esercito
e lo sconfisse nella battaglia di Heyenfeld presso
Andernach (876).
Questo fu l’ultimo tentativo di Carlo il Calvo di
appropriarsi di territori altrui, perché l’anno
seguente (877), tornando dall’Italia mentre attraversava il Moncenisio, moriva
anche lui.
Vediamo ora le vicissitudini di ciascuno dei due delineati
reami (ancora individuati nei territori dei Franchi Occidentali e Franchi Orientali) con gli ultimi
discendenti di Carlomagno, di Francia e di Germania,
considerando che tutto il periodo dalla morte
di Ludovico il Pio, fino alla fine dei carolingi,
è un periodo burrascoso di guerre
intestine, disordine e anarchia, i cui avvenimenti risultano oscuri e complessi
si riesce a ricostruirli con fatica.
DA FRANCIA E
GERMANIA
|
L |
a disputa era sorta alla convenzione di Mersen (870) in cui
I grandi della Lotaringia,
gelosi della loro indipendenza oscillavano tra l’uno e l’altro dei monarchi,
salvo a invocare nel momento del bisogno, l’aiuto della
Francia.
Ciò avvenne quando Raniero dal
Lungo Collo, capo dell’aristocrazia lotaringa, fece
appello (911) a Carlo III il
Semplice eleggendolo re della Lotaringia.
Il figlio di Raniero, Gilberto, si rivolge contro
Enrico il Germanico (919) e con il trattato di Bonn (921) si stabilisce lo “statu quo”
nel senso che Carlo è confermato re dei Franchi Occidentali e Enrico re dei Franchi Orientali.
Carlo non aveva né risorse di uomini né
di beni per opporsi ai feudatari e ciò provoca la sua deposizione (922),
sostituito con Raul (Rodolfo) di Borgogna che però trova opposizione da parte
dei principi del nord capeggiati da Erberto di Vermandois che detiene le due città di Reims e Laon.
Raul cerca di conquistare il viennese e lionese (che fanno parte del reame di Provenza) ma è troppo debole per poterlo
realizzare.
La caduta di Carlo il Semplice, preannuncia quella della dinastia, dovuta alla sua
ostinazione a riconquistare
RAMO DI
FRANCIA
|
A |
bbiamo visto che dei figli di (A) Lotario I:
(a1)
Ludovico II
re d’Italia († 875) mette al mondo solo due femmine,
Ermengarda (il cui nome ricorda la sfortunata figlia di Desiderio,
moglie ripudiata di Carlomagno, v. in Specchio
dell’Epoca: Il Gineceo di Carlomagno) e, Angilberga, e con costoro il ramo da lui rappresentato si estingue.
Gli altri due fratelli,
(a2) Lotario II re della Lotaringia (†
869)
sposa
Teotberga figlia
di Bosone (in Articoli, v. cit. Disfacimento
dell’Impero ecc.), ripudiata e sostituita da
Gualtrada, senza che nessuna delle due gli avesse procreto figli.
E il terzo figlio di (a3)
Carlo di Borgogna (†
863), non ha
discendenti e così quest’altro
ramo si
estingue.
(D):
Carlo il Calvo (823-877): dalla prima moglie
Ermentrude (†.869) aveva avuto quattro figli,
(d1) Ludovico II il Balbo
(† 879) che gli succede,
Lotario deceduto, (d2): Carlo
d’Aquitania morto senza
eredi († 866); Carlomanno e Giuditta (che sposa
Baldovino I di Fiandra). In seconde nozze sposa la sua concubina Richilde dalla quale nascono quattro figli, tutti morti in giovane
età
(d1): Ludovico il Balbo a
sua volta aveva avuto tre figli, dei quali, i primi due dalla prima moglie
Ansgarda (figlia del conte
Arduino): Ludovico III († 880)
e Carlomanno (†
884) che si
dividono il regno, muoiono anzitempo. Ludovico III aveva sposato
Ansgarda per volontà del padre il quale poi gli impone
di ripudiarla e sposare Adelaide incinta del suo terzo
figlio.
Infine Carlo III il Semplice (879-929), dopo varie vicissitudini, raccoglie nelle sue
mani le eredità dei suoi fratellastri e diventa re di Francia (v. sotto).
RAMO DI
GERMANIA
|
A |
bbiamo visto che Ludovico
il Germanico aveva avuto tre figli: Carlomanno, re di Baviera e d’Italia,
Ludovico III re di Germania e Carlo il Grosso che da Carlo
il Calvo, prende la corona di
imperatore.
Carlo il Grosso († 888)
riconosciuto re di Francia all’assemblea di Ponthieu
(885) si era trovato ad avere riunito nelle sue mani
tutto l’impero carolingio, ma non fu in grado
di mantenerlo nei tre anni che gli erano rimasti da vivere.
Grosso di corpo, debole di spirito e privo di coraggio,
non fu capace di difendere il regno dai Normanni mostrando la sua viltà quando essi avevano posto l’assedio a Parigi (886) e i
suoi sforzi per assicurare al figlio bastardo Bernardo, decisero
la sua rovina.
Deposto alla dieta di Tribur
(887), morì due mesi dopo (888), non senza aver avuto qualche anno prima (887)
una disavventura familiare con la moglie Riccarda, accusata d’infedeltà: egli la
ripudiò e la regina chiese il giudizio di
Dio, ma lui la mandò nell’abazia di Andaleau in Alsazia che lei
aveva fondato. Si dice che il suo cervello, negli
ultimi tempi si fosse indebolito, ma la sua morte aveva eliminato ogni
problema.
Bernardo († 890)
muore senza eredi e rimane il ramo di Carlomanno il quale ha un figlio anch’egli illegittimo Arnolfo di Carinzia (887- 896) che assume, senza contrasti e resistenze, il titolo di re
di Germania.
Con Arnolfo, si ha lo smembramento dell’antico regno di Ludovico il Germanico: Mentre la parte dei Franchi Occidentali seguiva le sue
sorti, i territori che gli rimanevanto della parte orientale venivano ulteriormente
smembrati.
Infatti, per fronteggiare le spinte autonomistiche dei grandi
feudatari è costretto ad appoggiarsi alla Chiesa, in particolare ai vescovi, ai
quali concede feudi e immunità, con la conseguenza che ha inizio la politica
tipicamente tedesca dell’antagonismo tra feudalità laica e la potente feudalità
ecclesiastica.
Arnolfo era stato a Roma per farsi incoronare, ma i romani
gli opposero resistenza
che riuscì a vincere e fu incoronato da papa Formoso (896).
Tornando in Germania la trova nella più completa anarchia
(la stessa che travagliava
Alla sua morte, gli succede come re di
Germania, il figlio Ludovico IV il Fanciullo
(896-911) avuto da una concubina, mentre l’altro
figlio Sventiboldo
(† 900)
diventa re della Lotaringia.
Ludovico il Fanciullo, re di
Germania non aveva
saputo far fronte agli attacchi dei Normanni, Moravi e
Ungari, e i singoli feudatari erano stati costretti a
difendersi per conto proprio. L’unità del paese subisce uno sgretolamento del
quale ne approfittano i grandi feudatari per rendere
autonomi i loro feudi, costituendo i ducati di Sassonia, Franconia, Baviera, Svevia e Lorena. Egli, dopo un attacco
di Magiari fugge a Ratisbona dove muore all’età di
venti anni (911).
Morto
Ludovico il Fanciullo
sale al trono il duca Corrado di Franconia (911-919) che per le sue particolari doti riesce a
mantenere l’unità dei feudatari, ma
muore lasciando
Gli succede
Enrico l’Uccellatore (919-936), della casa feudale di Sassonia che riesce a
sottomettere gli altri duchi, costringendoli all’omaggio feudale.
Con la cacciata
degli Ungari, Enrico
I riesce ad aumentare il suo prestigio,
ottenendo dai feudatari, alla sua morte, la elezione del figlio Ottone I (936-973) il
quale provvede a consolidfare il suo potere in
Germania, seguito dal nipote Ottone II (973-983) e
pronipote Ottone III (983-1002) i quali pongono le basi del futuro Sacro Romano Impero
Germanico
CARLO III IL
SEMPLICE
|
I |
l soprannome gli era stato dato in senso spregiativo, per
aver dovuto prendere la decisione, quando regnava, del riconoscimento al
normanno Rollone, del ducato di Normandia, “ma di carattere era sincero e leale e dallo
spirito lucido e risoluto”.
Di lui all’età di otto anni si
era preso cura come un padre, Folco, arcivescovo di Reims, che per la giovane età non poteva metterlo sul trono.
Di questa situazione ne approfittarono gli
avidi vassalli, ciascuno dei quali cercava di ingrandire il proprio patrimonio a
spese degli altri, e nessuno pensava a difendere il re e il regno con la
conseguenza, come scrivono i cronisti, “che la discordia portò rovine, incendi, saccheggi e devastazione”.
I vassalli (che in questo periodo, con le concessioni
ricevute - come vedremo in apposito articolo - possiamo
già definirli feudatari),
riconosciuta la necessità, attesa la minore età di Carlo, elevano al
trono Eude-Oddone
(888),
figlio di
Roberto il Forte discendente dal germano Vitichingo (Witichin), il quale
aveva ottenuto (861) il titolo di duca
della Celtica (o Gaule o Neustria che diventerà
Francia) .
Eude nello spazio di cinque anni, per sette volte (come scrive
Richer) aveva combattuto e disfatto i Normanni, e per nove
li aveva messi in fuga, lasciando, dopo la loro espulsione, il territorio
saccheggiato, seguito per di più da una gran carestia “la terra rimase incolta per tre anni, non si faceva alcun commercio di vino in
quanto le vigne erano state tutte
distrutte”.
Nel frattempo Carlo (nato nell’anno
879), aveva raggiunto il quindicesimo anno di età (*) e il vescovo,
Folco ritenendolo legittimato ad avere il regno, avuta la
disponibilità dei principi del Belgio e della Celtica e approfittando della
assenza di Eude che si era recato in Aquitania per
ridurre all’obbedienza quei signori pensò di incoronarlo. Riunì quindi a Reims (893) i vescovi del Belgio, i metropoliti di Colonia,
di Treves e Mayence con i
loro vescovi sostenitori, e i vescovi
di Laon, Chalons, e Therouanne, con l’assenso dei conti Erberto di Vermandois e Pipino di Senlis,
provenienti dalla schiatta di Carlomagno, lo incoronò nella
chiesa di Saint Remy.
Ma Eude rinetrato, costrinse il giovane re a darsi alla fuga e
perseguì quelli che lo avevano eletto; Carlo
cercò rifugio in Lotaringia e dopo, in Borgogna presso Arnolfo di Carinzia (v. in Ramo Germanico)
dal quale sperava di ottenere soccorso...e
Arnolfo
intervenne ...ma solo per assicurare la corona della Lotaringia al figlio Sventiboldo.
Arnolfo
infatti aveva convocato Eude e Carlo all’assemblea a Worms, dando
l’impressione di volerli conciliare; a questa assemblea (896) Carlo non partecipa
personalmente (per la sua giovane età) ma vi giungono inviati in sua
rappresentanza, mentre Eude giunto di persona fu accolto con molti onori.
Egli ottenne, come scrivono le cronache, tutto quello che
auspicava, vale a dire il suo riconoscimento di re della Neustria, ma dovette
assistere alla elevazione di Sventiboldo al trono della Lotaringia,
mentre a Carlo fu concessa una frazione di territorio (probabilmente la
contea di Laon e il Rèmois).
Dopo due anni Eude preso da
depressione (all’epoca era considerata malinconia), “aggravatasi” (come scrive il cronista)
“in alienazione mentale, morì di follia, secondo alcuni o di delirio secondo
altri” (898) all’età di quarant’anni, e Carlo
ottenne finalmente il
regno.
I Normanni nel frattempo, invasero
Nel frattempo muore Ludovico il Fanciullo (912) e Carlo, dopo quattordici anni, raccolse anche l’eredità della
Lotaringia, i cui vassalli chiedevano il
riconoscimento dei loro diritti feudali, che riuscirono a
ottenere.
*) Si tenga presente che non vi è nessun
errore nell’indicazione del compimento dei quindici anni, come potrebbe
apparire, essendo Carlo, nato nell’879, quindicenne nell’
893 e non quattordicenne, in quanto alla nascita si riteneva che il
neonato avesse un anno, e il nuovo anno non si calcolava dal mese di gennaio, ma
dalla Paqùsqua.
IL CARATTERE
|
D |
ivenuto re Carlo il
Semplice si mostra pieno di benvolenza; egli aveva un bel corpo e di natura era semplice
e buono; aveva poca attitudine per gli esercizi militari ma era molto versato
per lo studio delle lettere; donava con liberalità e non conosceva l’avarizia.
Aveva due grandi difetti: “amava in eccesso i piaceri e non aveva troppo a
cuore rendere la giustizia”.
I principi della Gallia si
legarono a lui per affetto e per giuramento: lo stesso Roberto, fratello di Eude, uomo abile e pieno di
coraggio non gli rifiutò l’aiuto militare (tutti e due, con il padre avevano il
titolo di duchi e di conti di Parigi) e lo accompagnò presso le piazzeforti di
cui prese possesso senza difficoltà. Poi nominò per i Sassoni, Enrico (Enrico
I l’Uccellatore), duca, di razza reale e originario del
paese.
Il re aveva una predilezione particolare per Aganone, e lo aveva tolto da un rango
oscuro per elevarlo al potere.
Aganone era sempre con lui e spesso si divertiva pendendogli il
cappello dalla testa e mettendolo sulla sua; questa
intimità indispettiva i nobili del seguito che si lamentavano che il re
avesse preso presso di sé come consigliere, un uomo di nascita oscura che avviliva
la dignità reale. Era come se essi avessero colpa della nobiltà e minacciavano,
se non avesse eliminato tale familiarità, di ritirarsi
da membri del consiglio. Carlo non teneva conto di tali rimostranze e non
allontanava il suo favorito.
Una volta Enrico di Sassonia e e il duca Roberto si erano recati a palazzo per
conferire con il re “e per quattro giorni non avevano ricevuto
risposta”. Enrico, irritato, aveva commentato: “o Aganone regna
con Carlo o Carlo e Aganone si sono ridotti alla condizione di
semplici segretari”, e si allontanarono con indignazione “da questo re insensato”. Si era
verificato anche un altro inconveniente.
Il re a Soissons riceveva
pubblicamente tutte le persone di media condizione che vi accorrervano per visitarlo e alle udienze Carlo era seduto al
centro, alla sua destra aveva Roberto e alla sua
sinistra Aganone. In una di queste udienze Roberto “covava una segreta indignazione nel
vedere un uomo di bassa estrazione trattato come suo eguale e messo al di sopra
dei grandi”.
Reprimendo la collera e dissimulando il suo risentimento,
si allontanò per consigliarsi con i suoi, e mandò un messaggio a Carlo per dirgli “che non poteva sopportare che Aganone fosse messo sul suo stesso rango e preferito ai
grandi del regno, e che gli pareva indegno che il re si legasse a un uomo di questa specie, mettendo da parte i più nobili
della Gallia; e se Carlo non avesse fatto rientrare
Aganone nella primitiva condizione, lo avrebbe fatto
lui senza pietà”.
Il re, non potendo accettare l’oltraggio fatto al suo
favorito, rispose “che avrebbe potuto più
facilmente privarsi di tutti gli altri, che della
intimità di Aganone”.
Ciò indispettì a tal punto Roberto che partì senza
attenderne il permesso, con la maggior parte dei principi (a eccezione di Ervé, vescovo di
Reims che si preccuperà di
ricoconciliarli) e si ritirò a Tours con gran risentimento per la condotta del sovrano.
Roberto si rivolse quindi a Baldovino di Fiandra (la cui
madre era Giuditta, figlia di Carlo il Calvo) che aveva abbandonato il partito del re, per legarsi a
quello del duca Roberto.
LE SOFFERENZE
PROVOCATE
DALL’ “ANATEMA”
|
I |
l re partì per una spedizione contro Baldovino di Fiandra
(899) e mise l’assedio a Arras che tolse a Baldovino concedendola
all’arcivescovo Folco con l’abazia di San Vasto, il
quale, per la distanza e la scomodità per raggiungerla, la scambiò con l’abazia di san Medardo del conte Altmaro, unitamente al castello di Arras.
Baldovino indispettito fece ammazzare Folco da un suo
sicario di nome Vinemaro (Winemare), contro il quale i vescovi lanciarono l’anatema, che all’epoca, nella ingenua credulità generale si riteneva fosse causa di
indicibili sofferenze, che non solo allontanavano l’anatemizzato dai suoi cari e lo facevano morire senza i
conforti religiosi, ma era considerato il peggiore dei mali (anche fisici) che
potessero capitare, in quanto premessa delle sofferenze riservateal malcapitato,
nell’Inferno!
Nel caso di Vinemaro sono
descritte con abbondanza di particolari dal cronista, che, come monaco ci
credeva anche lui: “Dio lo colpì con
una incurabile idropisia; mentre il suo corpo si
gonfiava, un fuoco lo bruciava esteriormente e all’interno un violento incendio
lo divorava. I suoi piedi subirono un considerevole rigonfiamento e dalle sue
parti naturali uscivano dei versi; le sue gambe erano gonfie e lucide, il suo
alito fetido, la colica faceva uscire poco a poco i suoi intestini e con tutto
questo egli provava una sete intollerabile; alle volte sentiva il desiderio di
mangiare, ma ciò che gli veniva presentato gli
suscitava disgusto; era in preda a una continua insonnia. Divenne insopportabile
a tutti e per tutti oggetto di orrore. I suoi amici e i
suoi domestici si allontanarono da lui non potendo
sopportare il fetore del suo corpo, tale che nessun medico poteva avvicinarlo
neanche per curarlo. Divorato da tutte queste afflizioni, privato della
comunione cristiana, corroso dal suo gesto infame e sacrilego egli fu
respinto da questa vita”.
Roberto continuava a tenere alle strette
Carlo, attraverso i grandi, i quali, nel
suggerire di allontanare Aganone, agivamo piuttosto
nell’interesse di Roberto, non perché
ritenessero possibile l’allontanamento, ma per preparare a Roberto
l’accesso al trono.
Il re continuava a rispondere che mai si sarebbe separato
da Aganone, e Roberto, alla fine, decise di inviare
messaggeri da Enrico I perché lo aiutasse a detronizzare Carlo, e forte
dell’adesione di Enrico, incominciò a prepararsi per impossessarsi del trono,
facendo a tutti grandi liberalità e promesse.
Con i grandi, Roberto concordò di
recarsi a palazzo dov’era il re, e di tenervelo prigioniero, e così
fecero.
Ma il vescovo Ervé che vegliava sul re e
aveva presentito una mossa del genere, giunse al palazzo con i suoi soldati,
chiedendo dove fosse il re; gli fu risposto che “era di là che teneva consiglio”. Il vescovo forzata la porta entrò trovando il re seduto con
poche persone, che erano quelle messe lì per tenerlo sotto guardia.
Il
vescovo capita la situazione, si rivolse al re, dicendogli: “vieni mio re, segui i tuoi servitori” e
lo portò via passando in mezzo a coloro che lo avevano fatto prigioniero. Il re
montato a cavallo
e uscito dalla città con il seguito del vescovo (di centocinquanta
uomini d’arme), fu portato a Reims.
Dopo la partenza del re, i sequestratori, furiosi per la
vergogna di essere stati giocati, tornarono confusi da Roberto al
quale riferirono quanto era successo.
L’INFIDO
GISLEBERTO
SEMPRE PRONTO A
TRADIRE
|
C |
arlo si rivolge a Gisleberto (duca di Lorena) il più potente vassallo del regno, tenuto
in grande considerazione dal suocero Enrico di Sassonia, del quale aveva sposato
(926) la figlia Gerberga.
Costui era figlio di Raniero dal Lungo Collo († 910)
che aveva un sercondo figlio con il suo stesso nome,
Raniero II conte di Haineau, ognuno dei quali, dal re,
al momento dell’insediamento, era stato riconfermato nel
rango.
Gisleberto è stato descritto “di taglia media ma grosso con membra forti,
il collo robusto, gli occhi cattivi
e strabici e talmente mobili che non si riusciva a vederne il colore; i suoi
piedi in continuo movimento, il suo spirito leggero, il suo linguaggio oscuro,
le sue domande fallaci, le sue risposte, equivoche: raramente vi era coerenza e
chiarezza in ciò che diceva. Eccessivamente prodigo nei suoi beni, bramava
avidamente quelli degli altri; mostrava benevolenza di fronte ai superiori e
suoi pari ma in segreto aveva invidia nei loro confronti; le discordie e i
litigi gli procuravano grande
gioia”.
Egli nutriva nei confronti di Carlo una grande avversione e meditava continuamente la sua rovina, in
quanto desiderava avere il regno, non per Roberto ma per sè stesso.
Con i grandi era molto liberale e ad
essi distribuiva parte dei suoi beni, ai più importanti donava terre o superbi
palazzi; conquistava i piccoli con forti somme di oro e di argento; “a questo modo, aveva portato dalla sua parte
un gran numero di persone, ma sconsideratamente, in quanto non le legava a sé
con giuramento per poter consumare i suoi crimini: per questo si vide facilmente abbandonato da tutti
quelli che aveva beneficato”.
Carlo, avendo saputo tutto
questo, si recò con l’esercito nella Lorena per portar
guerra ai belgi (lorenesi) i quali con Gisleberto non osarono affrontarlo e si rinchiusero nelle
fortezze e nelle città.
Il re mandò a coloro che lo avevano abbandonato dei
messaggeri, facendogli dire che con un solenne decreto
reale avrebbe confermato tutte le donazioni fatte da Gisleberto, in terre e palazzi, e che egli avrebbe preso le
loro difese nei confronti di Gisleberto, se questo
avesse tentato di riprendere tutti i benefici che essi avevano ottenuto. Con
questa promessa, tutti si recarono dal re per prestargli giuramento e a tutti
furono confermati i benefici ricevuti e tutti si unirono al re per andare contro
Gisleberto.
Ma questo lo prevenne, e si recò dal re per chiedere il
suo perdono e la sua benevolenza, assicurando che avrebbe mantenuto il
riconoscimento dei benefici e chiedendo per sé solo i benefici di coloro
che erano morti durante l’anno (che erano la più gran parte), che il re, con la mediazione di
Enrico, gli
concesse.
Nel frattempo il re si recò a combattare i Normanni che infestavano il regno e Gisleberto, libero dalla presenza del re, incominciò a maltrattare tutti quelli che dal re avevano
ricevuto il possesso dei benefici.
Faceva infatti prendere
segretamente alcuni o trattava con violenza e senza tregua altri, per far
lasciare ciò che essi possedevano. Alla fine riuscì a rientrare nel possesso dei
suoi beni e si mise a complottare contro il re “più furiosamente che mai”.
Gisleberto si recò dal suocero Enrico per chiedere aiuto, dicendogli che per il re sarebbe stata sufficiente
Gisleberto dunque, non avendo potuto
avere aiuto da Enrico, si recò da Roberto a Soissons
dove convennero tutti i grandi e concordarono di detronizzare Carlo. Roberto ebbe il voto di tutti i
signori presenti e fu
incoronato a Reims, nella chiesa di
Saint Remy (923) dal vescovo Ervé, che morì tre giorni dopo a causa di lunga
malattia.
Carlo sconsolato diceva ai
suoi che avrbbe preferito morire piuttosto che perdere
il trono; i suoi sostenitori decisero che occorreva muovere contro Roberto e
preparate le truppe e si combattè l’ultima guerra di
un re della dinastia Carolingia, con il nuovo
aspirante al regno.
L’ULTIMA GUERRA
DI UN
CAROLINGIO
|
C |
arlo dispose le sue truppe per la guerra dirigendosi verso
la antica residenza reale di Attigny
(923).
La sua armata era formata da una
avanguardia di seimila uomini vigorosi il cui comando era stato assegnato
al conte Fulberto, di origine consolare; egli stesso si mise al comando di
quattromila uomini, in riserva nel caso di bisogno.
Roberto aveva il doppio degli uomini; i vescovi e gli
altri ecclesiastici che accompagnavano Carlo (in assetto di
guerra in quanto gli ecclesiastici erano prima di tutto
guerrieri con l’obbligo di portare la spada nda.), gli suggerirono di non prendere
parte al combattimento perché la razza reale non doveva estinguersi nel mezzo di
una mischia, per cui, sollecitato da varie parti, egli mise alla testa dei
quattromila uomini Agraldo, anch’egli di rango
consolare, che rimase in attesa su un poggio che dominava la pianura (dove vi
era una chiesa dedicata alla vergine Genoveffa).
L’armata procede a corpi serrati,
Roberto avanza con ugual coraggio con una truppa più numerosa. Quando le
due truppe si scontrano la terra si riempie di morti; non si sapeva dove fosse
il re (che contrariamente a quanto detto da alcuni cronisti, non combatteva), ma si vide un guerriero combattere con furore e
quando chiesero se fosse Roberto,
“egli scopre fieramente la sua barba e si
fa riconoscere”; in questo momento Fulberto lo colpisce con un vigoroso
colpo di spada ferendolo mortalmente e mentre Roberto, si riversa sul fianco destro, “gli infligge un colpo di lancia che per
difetto della sua corazza gli attraversa il fegato, il polmone e l’ipocondrio
sinistro”.
Fulberto, assalito dagli altri guerrieri da sette colpi di
lancia, spossato dalla perdita di sangue, cade senza vita ancora
combattendo.
Dopo la morte di Roberto, le due armate combatterono con
tale accanimento che, secondo il rapporto di Flodoardo, morirono, dalla parte di
Roberto, undicimila uomini, dalla parte di Carlo
settemila.
Carlo non si considerò
vincitore per la morte dell’usurpatore, “dunque”, scrive il cronista, “il vantaggio fu incerto e Carlo non ottenne
alcuna spoglia e né gli uni, né gli altri si
impossessarono del bottino: l’occasione (del bottino) non era mancata a Carlo, ma egli era estraneo alla cupidigia e non ne
approfittò”.
I Galli, persistendo nella difesa della
usurpazione chiamarono Raoul (Rodolfo), figlio di Riccardo di
Borgogna e lo
elessero re, malgrado il suo rifiuto.
Il conte Erberto di Vermandois,
che si trovava tra i cospiratori, mandò a dire al re “che lui si trovava in
quella posizione suo malgrado e invitava il re a un incontro in quanto
aveva trovato un eccellente rimedio al male, e poteva ricevere dagli stessi
inviati il giuramento di fedeltà”.
Il re si recò da Erberto e dopo averlo abbracciato, con i
pochi presenti, si misero a conversare con familiarità. Ma durante la
conversazione, Erberto fece intervenire una truppa di
armati che circondò il re il
quale, preso alla sprovvista, non
oppose nessuna resistenza; qualcuno dei suoi riuscì a fuggire mentre il re fu
portato a Peronne e lì tenuto prigioniero.
L’ECLISSI DI LUNA
PREANNUNCIA
MORTE DEL RE
|
U |
na eclissi di luna (*) preannuciava una discordia tra Raoul e Erberto: questo
infatti, aveva chiesto a Raoul la
contea di Laon che Raoul gli rifiutò in quanto l’aveva
accordata a Ruggero, figlio del conte
Ruggero, per cui Erberto incominciò a
cospirare contro Raoul.
Erberto scrisse al papa dicendo che “non aveva nulla da dividere con i complici
che avervano congiurato contro il re Carlo e che desiderava che gli fosse restituito il trono e che
il papa usando la sua autorità apostolica, ordinasse che questo gli fosse restituito al re detrionizzato, sotto pena dell’anatema e di una eterna
maledizione contro chiunque si fosse opposto alla sua sentenza”;
chiedeva inoltre che il papa “scrivesse ai principi di Gallia e
Germania inviando benedizioni per i buoni, maledizioni per gli
oppositori”.
Ma gli inviati giunti a Roma non
avevano potuto adempiere al loro compito perché il papa era stato imprigionato
dal marchese di Toscana (Guglielmo fratello di Ugo di Provenza, re d’Italia, v.
in Articoli: Storia sconosciuta dei primi re d’Italia) e se ne dovettero tornare
senza aver potuto consegnare la
lettera.
Erberto, a questo punto ritornò sui suoi passi e pensò di
allearsi con Ugo figlio del defunto duca Roberto, cosa
che ottenne con giuramento di fedeltà. Con l’aiuto di
Ugo, Erberto riprese i suoi rapporti con Raoul-Rodolfo.
In seguito alla riconciliazione, chiese e ottenne per il
figlio ancora fanciullo, l’episcopato di Reims. Non potendo il fanciullo
esercitare le funzioni vescovili, per la reggenza dell’episcopato fu nominato il
vescovo Olderico.
Nel frattempo Raoul si recò a trovare Carlo nella sua prigione
pregando lo sfortunato re e supplicandolo ripetutamente, di perdonarlo se
riteneva che gli avesse
arrrecato qualche offesa. Raoul gli
disse che non poteva restituire interamente il potere
di cui era stato rivestito, “ma gli
avrebbe restituito ciò che la ragione avrebbe consentito” (vale a dire la
residenza reale di Attigny e del Pouthion).
Dopo poco tempo Carlo, “per la tristezza aveva contratto una malattia di consunzione e morì dopo aver
languito lungamente” (929).
Il dissenso tra Erberto e il re Raoul riprese con furore in quanto essi fecero ricorso a saccheggi
e incendi. Il re si dichiarò contro Erberto,
che ben sapeva come fosse disposto al
tradimento, e si alleò con il duca Ugo, col quale andò a mettere sotto assedio
una piazzaforte di Erberto chiamata Doulens; mise sotto assedio e prese anche Arras dove si legò
agli abitanti con giuramento.
Se ne stava allontanando tranquillamente, quando Erberto
chiamò in suo soccorso i lorenesi che abitavano ai
bordi del Reno, e marciò contro di lui segnando il percorso di saccheggi e
incendi. Prese e saccheggiò una piazzaforte di Ugo,
chiamata Baine, posta presso il torrente Vesle.
Raoul decise quindi di distruggere la potenza di Erberto e si rivolse ai cittadini di Reims dov’era l’abbazia concessa al figlio, con l’ordine di
scegliersi un vescovo; i cittadini risposero “di aver eletto e ricevuto come vescovo il
figlio di Erberto, al quale avevano
prestato giuramentto di fedeltà, non potevano ora abbandonarlo senza
violare il giuramento”.
Il re, avendo capito che quei cittadini erano favorevoli
a Erberto e gli rifiutavano l’ingresso in città, la
mise sotto assedio, per far pressione su di essi; costoro resistettero, ma alla
fine della terza settimana, aprirono le porte,
supplicanti.
Il re, dopo un discorso col quale sottolineava “che essi
proteggevano il figlio di un tiranno e che
Presagi funesti preannunciavano altre sventure
(934): “si videro una moltitudione
di fuochi e fiamme di sangue che attraversavano il cielo come frecce o
serpenti. Sopravvenne una malattia
contagiosa che provocava bubboni di risipola (produceva infiammazione
della pelle, accompagnata da febbre nda.) che fece morire un numero rilevante di persone”.
Poco dopo seguì la morte del re (936) “colpito”, scrive un cronista, “da cachessia ossia da cattiva disposizione
del corpo”; altri fanno riferimento alla “ pedicolosi”,
malattia della pelle provocata dai pidocchi, non
dignitosa per un re, ma a quei tempi la pulizia del corpo, contrariamente ai
romani e ai bizantini, in occidente era completamente
sconosciuta.
*)
Il cronista racconta che “in quei
giorni” (927) “avvenne una eclissi di luna, portatrice di mali: la luna,
per l’interposizione della Terra, si era
completamente oscurata alla vista degli uomini; a Reims, si videro in cielo una moltitudine di fuochi. Questi
presagi furono seguiti da un insieme di febbri e tosse; alcuni ne furno mortalmente colpiti,
soccombendo”.
Dai tempi dei testi sacri indiani e della
Bibbia e per tutto il medioevo vi sono sempre stati
avvistamenti di vario genere che hanno dato luogo ai fenomeni degli UFO, così
classsificati gli oggetti non identificati del terzo
tipo, da cui è sorta la improbabile teoria ”degli antichi astronauti” che avrebbero
dato vita all’essere umano, mentre è oramai certo che la vita, primordiale e
monocellulare, sia arrivata dallo spazio con i
meteoriti, trovando sulla Terra le condizioni per svilupparsi ed evolversi.
FINE