
Giacomo Borlone (1484-1485) La
Danza Macabra Particolare Clusone (BG)
LE GRANDI PESTILENZE
DELLA STORIA
SOMMARIO: PREFAZIONE OMIBUS SULLATTUALITA E CONSEGUENZER DEL C.VIRUS:
LA LEGGENDA DELLA PRIMA PESTE IN MESOPOTAMIA DEL DIO ERA; EPIMENIDE CHIAMATO PER PURIFICARE ATENE E LA PESTE RACCONTATA DA TICIDIDE: IL LUOGO DI PROVENIENZA E DIFFUSIONE; I SINTOMI; SI MORIVA CON LE CURE E SENZA CURE; LA PESTE DI BISANZIO DURANTE IL REGNO DI GIUSTINIANO: CHI NE ERA COLPITO VEDEVA I FANTASMI; NON VI ERA NESSUNA SPIEGAZIONE PER LA SCIENZA UMANA; ALCUNI APPESTATI SUPERAVANO LA MALATTIA; I PROVVEDIMENTI DELLIMPERATORE E LA NOMINA DEL REFERENDARIO; NON VI ERA POSTO PER SEPPELLIRE I MORTI LE STRADE ERANO DESERTE LE ATTIVITA MERCANTILI BLOCCATE; LA MORTE NERA DEL 1350; AI FLAGELLI SI AGGIUNSE LINVENZIONE DELLA BOMBARDA INAUGURATA ALLA BATTAGLIA DI CRECY; I SINTOMI DELLA PESTE MUTAVANO IN OGNI LUOGO E AMICI E PARENTI SI TENEVANO A DISTANZA; SI CREDEVA CHE GIOIA E PIACERI FOSSERO IL SICURO RIMEDIO CONTRO LA PESTE; I VICINI DI CASA ERANO AVVERTITI DALLA PUZZA DEI CADAVERI; ELOGIO DI GIOVANNI VILLANI LA LAURA DI PETRARCA MUORE DI PESTE; LA SIGNORIA DI FIRENZE SOSPENDEVA I PAGAMENTI PER PICCOLI DEBITI E LIBERAVA I CARCERATI PER LEGGERI REATI; SPARSA IN EUROPA SINTOMI MUTAVANO IN OGNI LUOGO AMICI E PARENTI SI TENEVANO A DISTANZA; RIAPPAIONO I FLAGELLANTI; LA DANZA MACABRA; LA PESTE NEL 1500 E GLI STUDI CHE NE ERAN SCATURITI (In Nota: BIBLIOGRAFIA DEI TESTI CINQUECENTESCHI VENEZIANI E PADOVANI); LA PESTE A VENEZIA E LA DIATRIBA TRA MEDICI PADOVANI E VENEZIANI; I DUE MEDICI SONO LICENZIATI; LA PESTE MANZONIANA PORTATA DAI LANZICHENECCHI (in Nota: Il passo del Manzoni su Cecilia); IL TUMULTO DI SAN MARTINO DURANTE LA CARESTIA; I MONATTI E GLI UNTORI DURANTE LA PESTE; LA PESTE DI LONDRA DEL 1665 NEL RACCONTO DI DANIEL DE FOE.
PREFAZIONE
OMNIBUS
SULLATTUALITA
E
CONSEGUENZE DEL
C. VIRUS
|
O |
r sono
già moltissimi anni che questo articolo è stato pensato e preparato nelle
ricerche, non saprei dire se per il macabro fascino suscitato dalla peste con il
suo strascico di morte (v. sotto La danza macabra), ed era lì in attesa solo di
essere scritto.
Con
larrivo del C.virus, trovandomi nella
debole fascia dei classificati ad alto
rischio, tra i quali sta avvenendo la falcidie (si è calcolato che per ogni
ventun morti, venti hanno superato i settantanni!) nelle case di riposo (anche
se per mia fortuna vivo nella mia casa, in perfetta solitudine e senza
assistenza), forse limpellente pericolo mi ha dato la carica per scriverlo, liberandomi anche dalla
depressione che mi accompagna da anni; ...
ora, che lho scritto, mi auguro di
vederlo pubblicato!
Anche
se questo nuovo tipo di pestilenza ha avuto un nome scientifico (Covid 19.2) adeguato ai tempi, essa,
come si vedrà, segue più o meno le stesse orme delle pesti del passato, seppur in
forma più attuale e, dal presente excursus
(limitato alla peste e non alle altre pandemie di altro genere come il colera, vaiolo,
febbre petecchiale, spagnola ecc.), vediamo che le pestilenze hanno sempre
accompagnato dallorigine lumanità, facendo sorgere spontanea la domanda: Perché?
Mi
guarderei bene dal voler dare spiegazioni scientifiche che lascio alla scienza;
la mia risposta viene dal sentimento, dal profondo amore per
A Oriente
invece è lIndonesia a farne le spese, deforestata dai giapponesi, che fanno
grande uso del legname, i quali, unitamente ai canadesi, stanno distruggendo
anche le balene, con limpari lotta, allapertura annuale della caccia, di Green
Peace che con le sue barchette cerca di fermare le grandi baleniere!
Una
cosa si potrà dare per certa: che la società con questa sferzata del C.virus, subirà dei cambiamenti radicali, non è possibile
prevedere in che modo, ma tutto cambierà!
IL MAGGIOR NUMERO DI MORTI IN LOMBARDIA
Il
maggior numero di morti causati dal C.virus (in totale in
Italia a maggio 2020 hanno superato i trentamila) tra i quali un grande
contributo è stato pagato da medici e infermieri, meritevoli di una medaglia
doro al valor civile, per aver dato la loro vita compiendo il loro dovere.
Le
maggiori perdite si sono riscontrati in
Lombardia e a Milano; alcuni hanno ritenuto che la causa sia da attribuire alla
globalizzazione, altri alle antenne 5G, altri alla elettricità o allinquinamento.
Per lelettricità, abbiamo lesempio di Nicolas Tesla (1856-1943) che in mezzo
alla elettricità, con tutti gli esperimenti che faceva, aveva passato lintera
la sua vita, morendo alletà di ottantre anni!
Sullinquinamento,
è da dire che nel passato non cera,e per la
globalizzazione è da dire che nellantichità, nel mondo chiuso in se stesso in
cui si viveva, essa non esisteva e la peste arrivava ugualmente dappertutto!
Forse sarebbe
da prendere in considerazione la incidenza della popolazione, avendo
Le pandemie
che si sono succedute nella storia, nella generalità dei casi hanno presentato
gli stessi problemi, primo fra tutti il blocco delle attività economiche e commerciali,
col conseguente impoverimento di tutte le categorie sociali (*) tra le quali i
più danneggiati sono i bisognosi:- Un esempio è dato dalla concentrazione dei
contadini che si trasferivano in città ad Atene come a Milano - che
attualmente si è ripetuto in maniera massiccia in India (già afflitta dalla
tubercolosi!), dove i contadini che si sono recati nelle città per guadagnare
di più (quattro o cinque dollari al giorno!), con il C.virus non solo si sono trovati senza lavoro, ma con il blocco dei
mezzi di trasporto non hanno potuto tornarsene a casa, e senza denaro non hanno
neanche dove andare a dormire ... e la situazione è veramente tragica dal
momento che si tratta di milioni di esseri umani!
LAfrica
da cui si attendevano risultati catastrofici. sta risultando indenne in quanto la sua popolazione
è giovane, anzi giovanissima avendo il 43% della popolazione con meno di quindici anni e solo il 5% ne ha circa
60.
IL
DECRETO RILANCIO E I FAMIGERATI DECRETI ATTUATIVI
*) La situazione italiana tra industria e commercio, le cui
attività sono sospese, è gravissima in quanto comporta la perdita di 10 Mld. alla settimana mentre la girandola dei miliardi
promessi dal Presidente del Consiglio sono risultati solo fumo negli occhi, dal
momento che cominciando dal prestito garantito dallo Stato di 25.000 . per le
aziende, le operazioni risultano ancora bloccate (le Banche richiedono ben
diciannove documenti per erogare il prestito!) e le aziende lamentano di non aver
visto ancora un euro!
Anche la promessa del pagamento di una parte dei 40 Mld. dovuti dallo
Stato alle aziende fornitrici, che avrebbe dovuto essere il primo versamento da
fare alle aziende, da anni in attesa, e, molte, nel frattempo, fallite!
Il nuovo decreto (meglio maxi-decreto,
comunque decreto-rilancio**), che da come è stato presentato sembrerebbe il decreto delle meraviglie di oltre quattrocentocinquanta pagine e duecentocinquantotto articoli, incomprensibili per gli esperti (è stato
detto), pieno di pastoie burocratiche...con periodi lunghi venti righe ... da
apparire come vessillo della burocrazia
a carattere fortemente assistenziale: tutto
ciò che è dato è messo a debito!); dovremo comunque attendere la sua
applicazione pratica ... che non sarà semplice perché dovrà essere seguita da
una cascata di decreti di attuazione
che costituiranno una specie di mare
magnum in cui ci sarà da perdersi: tutto dipenderà dal Capitano che sta
conducendo la nave e vedremo se la spinta al rilancio della economia ci sarà (nulla è stato detto per la ricostruzione rimandata a un altro
faldone!) o si ridurrà tutto a un grande
bluff!
Quantomeno sarà immediatamente esecutivo e non abbisogna di
seguire il percorso dei famigerati decreti
attuativi, che denunciamo pur con la nostra flebile voce.
Questi decreti attuativi
sono stati un vittorioso escamotage della burocrazia per impedire la
realizzazione di quelle piccole riforme date come specchietto per le allodole a
noi cittadini. Ecco come funziona il sistema; si promette su un determinato
settore una legge di riforma e si vara regolarmente la legge, approvata dal
Parlamento e firmata dal Presidente della Repubblica; la legge però si limita a
indicare le linee generali della riforma
in modo che chi lha presentata possa vantarsi della riforma in essa contenuta,
ma nella sua realizzazione pratica la riforma è demandata al decreto attuativo per il quale non viene
fissato alcun termine!
Non solo: ma il decreto
attuativo è materialmente eseguito (scritto) dallo stesso ministero che è
interessato dalla riforma! Ciò significa che il ministero può prendersi tutto il
tempo che vuole per scrivere il decreto e realizzare la riforma ... o non
realizzarla!
Il risultato è che vi sono ben novantotto decreti attuativi da
realizzare, molti dei quali risalgono al Governo Monti ... nel silenzio dei
politici che evidentemente fiancheggiano la burocrazia e della stampa che non
denuncia la stortura!
Ecco come si fanno le riforme in Italia, mentre assistiamo
allibiti alle leggi fatte negli altri paesi come la Germania dove la legge è
fatta e realizzata (es. i pagamenti alle industrie; appena varata la legge gli
industriali sono stati immediatamente pagati), in Italia pur dando
limpressione di aver fatto la legge, quanto alla sua realizzazione ... si
vedrà!
In
Italia,
Vi è
poi linquinamento del mare con tutta la plastica (Great Pacific Garbage Patch) che arriva da dieci fiumi (Yangtze, Xi e Huanpu (Cina), Gange (India), Oyono (Nigeria), Brantas e
Solo (Indonesia), Rio delle Amazzoni (Brasile), Pasig
(Filippine) e Irrawaddy (Birmania),
cloache a cielo aperto; trasportata dalle correnti, aveva formato, nel bel
mezzo del Pacifico unisola grande quanto
Vi è
poi linquinamento atmosferico che porta al surriscaldamento terrestre, che sta
facendo sciogliere i ghiacci dellArtico e, in un futuro molto prossimo, farà
alzare il livello del mare e sommergere le coste, mandando sottacqua le città
costiere tra le quali la città di Venezia, inestimabile città darte, che tra
laltro sta anche sprofondando ... e non sarà il costosissimo Mose, con il
quale si sono arricchiti politici e faccendieri, a salvarla!
*) Negli anni sessanta vi era stato chi
aveva suggerito di aprire un varco nella montagna di Genova in modo che
passando laria, avrebbe ripulito tutta la pianura; lidea non sembra essere
stata balzana, ma nessuno laveva presa in considerazione!
MANCA LO SPIRITO EUROPEO
Nel contesto europeo,
Non è
questo lo spirito dellEuropa che volevamo quando eravamo giovani (v. in questa
Rivista, Unione Europea Storia e Istituzioni), che ci aveva spinti a desiderare
una Europa Unita e coesa, pronta a sacrificare gli interessi nazionali e
particolari, per gli interessi generali!
Aver
fatto entrare nellU.E. i Paesi dellEst è stata una jattura che hanno portato
uno scollamento in quanto questi paesi provenienti dal ferreo regime sovietico
avrebbero avuto bisogno di un periodo di assestamento della loro democrazia;
essi in effetti, non hanno avuto il tempo di maturare uno spirito inteso come europeo,
che comporta quello di accettare disposizioni comunitarie (un esempio è dato
dal rifiuto di recepire le disposizioni sulle quote degli immigrati, come ha
fatto lUngheria, che ha chiuso i confini con muri e filo spinato!); è evidente
che la loro entrata nellUnione ha avuto solo fini utilitaristici, preordinata
solo in funzione dei finanziamenti distribuiti dallU.E., e, quanto al resto
oppongono il più vieto nazionalismo!
Purtroppo
ciò a cui non si era pensato (e non si poteva pensare!), sarebbe stata la
previsione della espulsione per i
paesi che non avessero aderito allo spirito unitario e di solidarietà (peraltro,
di recente opposta, nellimpellenza del C.virus, dai paesi del Nord Europa,
primi fra tutti Olanda e Germania, nei confronti dei paesi del Sud Europa,come
lItalia, Francia e Spagna per la richiesta di finanziamenti!); per di più una
bordata è da ultimo partita con una sentenza della Corte Costituzionale della
Germania contro loperato della BCE, sentenza inaudita e prevaricatrice che
costituisce un attacco al potere della U.E. e alla sua indipendenza e autonomia
nei confronti dei suoi singoli componenti, in quanto unico organo giudicante è
la Corte di Giustizia della Unione Europea.
Nello
stesso tempo, la burocrazia di Bruxelles si dà un gran daffare per fare entrare
due dei paesi balcanici occidentali (*), come lAlbania e
Anche
Lingresso
di altri paesi nellU.E. in questo periodo di crisi, non farebbe che aumentare
il carico già gravoso di una Unione elefantiaca, completamente bloccata da una
burocrazia asfittica che non prende decisioni in campo interno e si mostra completamente
assente nel contesto internazionale.
Abbiamo
grande fiducia nella nomina della due nuove presidenti Christine Lagard della BCE e Ursula von der
Leyen della Commissione, ma occorrerà del tempo per
valutare le loro realizzazioni.
*) Gli altri quattro sono Serbia, Kosovo, Bosnia Erzegovina e
Montenegro
UN PARLAMENTO EUROPEO INUTILE
Peraltro,
lUnione Europea avrebbe bisogno di una bella cura di ringiovanimento e di
riforme (v. in Schede LIdea di Solimano il Magnifico ecc. LUnione Europea impaludata),
primo fra tutti del Parlamento privato della funzione prioritaria Legislativa,
che hanno tutti i Parlamenti del mondo, che con la sua sola funzione di
proporre le leggi, risulta una Istituzione del tutto inutile, che comporta solo
una enorme
spesa per il mantenimento di settecentocinque (erano settecento cinquanta con
E, a
nessun Presidente (ne sono stati eletti consecutivamente due italiani dai quali
non è venuta nessuna idea innovativa. come per es. quella di convincere tutti i
deputati di farsi carico presso i propri rispettivi governi, a rendere quel
Parlamento finalmente autonomo con pienezza dei suo
potere Legislativo
I burocrati
di Bruxelles, invece di pensare di far entrare altri Paesi, potrebbero, oramai dopo
ben settantanni, decidersi a forzare la mano ai Governi, di rendere finalmente autonoma lIstituzione, con un
proprio Governo, con Parlamento, Ministeri
ed Esercito indipendenti, prevedendo, per quei paesi che per motivi
nazionalistici si dovessero opporre, la possibilità di rimanere come associati
esterni alla unione, ovviamente, senza diritto di voto sulle decisioni che
fossero prese dai membri della unione.
Sarebbe
poi opportuno fissare la sede del Parlamento nella stessa sede del Governo in
quanto una sede separata come quella di Strasburgo è un controsenso, voluto
allepoca, dalla Francia, per morivi patriottici, che ha comportato e comporta
un enorme spreco di danaro in quanto, ogni sessione prevede il trasferimento di
casse di documenti da e per Bruxelles!
COINVOLTA
Il C.virus ha posto in evidenza il problema
del sovraffollamento delle carceri 189 carceri italiane: E noto che le carceri
italiane sono da terzo mondo, in una situazione igienico-sanitaria drammatica oltre
ad essere sovraffollate: i quarantamila posti disponibili sono occupati da
cinquantasettemila detenuti con una spaventosa promiscuità (126 detenuti e 148
guardie carcerarie sono risultati positivi al virus con un alto numero di
suicidi tra detenuti e guardie carcerarie): in una cella per quattro sono
ammassati nove detenuti, con la disponibilità di un bugnolo a vista e una doccia senza acqua calda ... e la distanza di sicurezza tra detenuti dovrebbe
essere di mt. 1,80!
Mentre
altri paesi stanno provvedendo ad alleggerire le carceri, in Italia nonostante
vi sia un centinaio di detenuti e centocinquantotto guardie carcerarie positivi
al virus e nonostante vi sia stata
una rivolta che ha avuto alcuni morti, invece di liberare (tenendoli agli
arresti domiciliari) i detenuti di reati non gravi e con solo alcuni mesi da
scontare o in attesa di giudizio (liberando così un diecimila posti): è stato
fatto tutto il contrario: sono stati mandati a casa trecentosessantasei boss mafiosi, per motivi di salute!
Pur
essendo dubbio che tutti costoro avessero bisogno di particolare assistenza
medica, trattandosi di detenuti che
hanno commesso reati gravi (e più avanti si vedrà che durante la peste a
Firenze erano stati liberati solo coloro che avevano commesso reati leggeri!), tenendo sempre presente
la salvaguardia della persona umana, per costoro, che avevano bisogno di particolari
cure mediche, non disponibili nelle
carceri dove erano detenuti, si poteva provvedere a metterli in un unico ospedale
(ve ne sono di liberi!) per poterli assistere in maniera adeguata.
Improvvido
e inopportuno è stato il provvedimento al quale il ministro, subissato di
critiche e polemiche, con giravolta il ministro ritiene di farli ritornare in
carcere ... con altro pasticcio davvero inestricabile!
Riprendendo
largomento, il vanto giuridico dellItalia è stata la previsione della funzione educativa della pena, sostenuta
da Cesare Beccaria fin dal 1764 e prevista nella nostra Costituzione; nella
pratica i detenuti, salvo alcune eccezioni che offrono risultati positivi, passano
le loro giornate nella più assoluta inedia, senza che siano impegnati in alcuna
attività, sì che quando hanno finito di scontare la pena, uscendo dalle carceri
tornano a delinquere.
Da
tempo è stata predisposta la riforma carceraria; ma il precedente ministro
Orlando laveva rinviata fino allultimo momento e quando è stato sostituito,
la riforma è rimasta nel cassetto, dove la tiene anche lattuale ministro Bonafede.
Purtroppo,
con tutti i gravi problemi che assillano la Giustizia, ambedue i ministri (ma anche
gli altri che li hanno preceduti!) hanno completamente dimenticato la corposa
materia della riforma che prevede la sostituzione
dei quattro codici (civile e penale e le due procedure), causa anche della
lentezza dei processi e dello spaventoso arretrato ai quali si aggiungono ora i
processi sospesi a causa del C.virus: e siamo al blocco totale ...e la magistratura, a
parte le polemiche interne, tace!
Tra tante
polemiche, i due ministri si sono limitati ad apportare modifiche alla sola prescrizione in materia penale ... facendola
passare per riforma della giustizia!
Il Manzoni
proprio relativamente alla materia giudiziaria (con particolare riferimento
alle grida) aveva scritto che le riforme umane, si fanno per gradi (precisando): parlo delle vere riforme, non di tutte le
cose che ne hanno preso il nome!
Ci
chiediamo come mai dei ministri che dimostrano di non avere specifiche capacità
innovative, rimangano imperterriti a occupare la poltrona solo perché la
politica glielo consente, arrecando un danno alla comunità!
LItalia
ha bisogno di essere interamente riformata e ricostruita, come se fosse uscita
da una guerra, ma occorrono anche uomini capaci di provvedervi ... con i tempi (*) del ponte di
Genova (onore a Renzo Piano).
Se con
la fine del C.virus
lItalia non dovesse partire, sarà definitivamente condannata a rimanere un
paese da terzo mondo ... come è stato fino ad ora!
*) Per lItalia un ponte di quel genere (il ponte è bello ma quel
contesto sottostante di condomini non lo é, sarebbe meglio un bel bosco!) tirato
su in venti mesi sembra un miracolo (ora si deve procedere solo allasfalto); è
stato possibile perché è stata messa da parte la burocrazia che dovrebbe essere tenuta da parte da tutti gli appalti
oppure prevedendo larresto per i funzionari che, anche per loro salvaguardia,
ritardino la esecuzione dei progetti come sta avvenendo nelle zone terremotate
dove su 2.6oo progetti ne sono stati portati a esecuzione 260. Naturalmente
facendo grande attenzione a possibili infiltrazioni criminali che negli appalti
trovano la porta aperta attraverso i subappalti
che dovrebbero essere assolutamente vietati, ma di questa possibilità,
stranamente, nessuno ne parla!
DELLA PRIMA
PESTE
IN MESOPOTAMIA
DEL DIO ERA
|
L |
a peste
da sempre ha accompagnato luomo durante tutta la sua storia e quelle di cui si
ha notizia ne sono state tante, da poterne fare un lunghissimo e interminabile
elenco; di queste solo alcune sono state descritte da valenti scrittori che riportiamo
cominciando da quella avvenuta in Mesopotamia, di cui si ha notizia con la Leggenda di Era (*).
In
questo mito babilonese e assiro (ricordiamo che la civiltà mesopotamica dal
3000 al 500 - si sviluppa in tre fasi: sumera, babilonese e assira fino alla invasione di Babel
(
I
sette dèmoni incitano il dio a compiere le sue opere nefaste; il cattivo dèmone
Ishum, spargitore della pestilenza, ricorda al dio
tutto il male già compiuto, specialmente quello contro la città di Babele, il
suo re e i suoi abitanti, ma anche le distruzioni di altre città importanti
della Babilonia, come Nippur e Uruk, Dûrilu e qualche altra.
Il dio
Era, approva quanto gli dice Ishum e si sente
incoraggiato a compiere distruzioni ancora maggiori; egli si augura che le
varie parti della Babilonia si distruggano vicendevolmente e che infine si
sollevi Akkad e getti tutti a terra; dà perciò a Ishum l'incarico di eseguire tutto ciò che desidera, e Ishum fa come Era gli aveva ordinato.
Gli
dèi ne sono spaventati, ma Ishum continua a eccitare
il dio a sempre nuove devastazioni, e infine a placarsi; così infatti avviene,
e s'inizia il periodo della prosperità che durò per parecchi anni.
Nella
forma a noi pervenuta il mito non è che l'introduzione di uno scongiuro, e
consta di vari estratti del mito completo che per ora non ancora si conosce.
Edizione: Ebeling, Der akkadische Mythus vom Pestgotte
Era (Berlino, 1925). Giuseppe Furlani in Disionario Bompiani dei Personaggi e
delle Opere, 1983.
*) Rileviamo che di questa divintà non se ne
fa menzione tra le divinità della Mesopotamia.
EPIMENIDE CHIAMATO PER
PURIFICARE
ATENE
E
RACCONTATA DA TUCIDIDE
|
L |
a prima
peste abbattutasi su Atene è quella alla quale accenna Plutarco nella vita di
Solone (VIII-VII sec.) quando parla del gran sacerdote Epimenide Festio di Creta (Candia), il quale, avendo gli dei mandato
i segni della loro ira sulla città, lo avevano chiamato per purificarla e lo
storico purtroppo, non parla né della calamità, né della purificazione, ma è
preso dalla descrizione del quasi leggendario personaggio.
Epimenide
era infatti considerato uno dei sette sapienti e stimato come uomo pio, caro
agli dei e dotto nelle cose divine, per sapienza infusa dal cielo e misteriosa;
egli aveva inoltre la sobrietà del sacerdote e la sua maniera di nutrirsi era
meravigliosa. Per questo gli uomini di quel secolo lo consideravano figlio
della ninfa Balte e lo chiamavano nuovo Curete.
Venuto ad Atene, aveva stretto amicizia con Solone e gli fu giovevole in molte
cose e gli preparò il sentiero delle sue leggi.
Rese
più semplici e ridusse le spese per le sacre cerimonie e introdusse maggior
moderazione per quanto riguarda i lutti, perché impose agli ateniesi di
semplificare i sacrifici alle esequie e abolito quanto di aspro e barbaro si
soleva in precedenza praticare nei pianti, dalla maggior parte delle donne.
Ma ciò
che maggiormente importa egli aveva con certi sacrifici propiziatori e
purificazioni e fondazione di templi rivolto la città alla religione e
devozione, rendendola più obbediente alla giustizia e più maneggiabile per
guidarla alla concordia.
Laltra
peste abbattutasi su Atene, è quella del racconto di Tucidide nelle Storie, del
Proveniente
dalla lontana Etiopia, dopo aver serpeggiato nei territori che le erano intorno, attraversando
il mare, come avverrà per altre epidemie, era sbarcata nel porto del Pireo e quindi
era giunta ad Atene. Tucidide ne era stato anchegli colpito e il suo racconto
(che riassumiamo*) è fatto per cognizione diretta; ed ecco il racconto.
Da
pochi giorni i Peloponnesi e i loro alleati avevano invaso lAttica (23.IV.431 a..C.), quando ad Atene cominciò a manifestarsi la pestilenza:
si diceva che in precedenza la peste fosse scoppiata a Lemno e a1trove,
ma non si ricordava che fosse stata mai tanto perniciosa e avesse ucciso tanti
uomini.
I
medici, che si trovavano per la prima volta a doverla curare, non vi riuscivano
per inesperienza, ed anzi, più degli altri essi stessi morivano, perché più
degli altri venivano a contatto col male; né serviva alcuna altra risorsa
umana; inutili erano anche tutte le suppliche ai templi (Ripamonti riferisce
della processione con la statua di Iside (v. in Schede F. Ermete Trismegisto e
il libro di Thot il Cap. Iside e Osiride), che non
abbiamo riscontrato nel testo consultato), il ricorso ad oracoli e a mezzi del
genere, tanto che finirono col rinunciare, vinti dal male.
IL LUOGO DI PROVENIENZA
E DI
DIFFUSIONE
|
A |
quanto si diceva era iniziata in Etiopia, a sud dellEgitto, dove
si era diffusa, passando quindi in Libia e in gran parte dei territori circostanti;
ad Atene si abbatté inaspettata, partendo dal Pireo (porto di Atene), mentre si era sparsa la voce che fossero
stati gli spartani ad aver gettato i veleni nelle cisterne (in quanto non vi erano
sorgenti); poi raggiunse la città alta, e i morti cominciarono a farsi ormai
più numerosi.
Io
stesso sono stato malato e ho visto con i miei occhi altri ammalati e su questo
malanno ciascuno, medico o profano, potrà esprimere la sua opinione sulla sua
probabile origine e sulle sue cause; io posso dire come esso fu, e indicherò tutti
i sintomi, dai quali si potrà meglio riconoscere il male e non sbagliare se mai
si dovesse presentare unaltra volta.
Quellanno
non vi erano state le altre malattie (di stagione), sembrava che tutti ne
fossero stati immuni, ma se qualcuno si fosse ammalato prima, la malattia si convertiva nella nuova.
I SINTOMI
|
G |
li
altri invece, allimprovviso, senza nessuna causa apparente, mentre erano in
piena salute, erano colti dapprima da violenti calori alla testa; gli occhi,
infiammati, si arrossavano; gli organi interni, come la faringe e la lingua,
erano subito gonfi di sangue e ne usciva un respiro irregolare e fetido;
seguivano poi starnuti e raucedine e in breve tempo il male scendeva nel petto
con forte tosse. Quando si fissava nello stomaco lo sconvolgeva:
sopravvenivano, tra grandi sofferenze, tutti quanti gli spurghi di bile ai
quali i medici hanno dato un nome.
I più
erano presi da conati di vomito a vuoto che provocavano spasimi violenti subito
dopo lattenuazione di quei sintomi o anche molto più tardi.
Al
tatto, il corpo esternamente, non si presentava troppo caldo, né pallido, ma
piuttosto rossastro, livido, disseminato di pustole e di ulcere; allinterno
invece, i malati ardevano al punto che non tolleravano il contatto delle vesti
più leggere né di lenzuoli, né di altro, ma volevano restar nudi e, come massimo
piacere, gettarsi nellacqua fredda; molti di coloro che non erano curati lo
fecero gettandosi nei pozzi, vinti da una sete inestinguibile; ma il bere molto
o poco portava allidentico risultato.
Li tormentava
continuamente limpossibilità di riposare e linsonnia; ma il corpo, durante lo
stadio acuto della malattia, non languiva, ma resisteva alle sofferenze in
maniera sorprendente, di modo che i più o morivano nel settimo o nel nono giorno
per larsura interna, quando ancora avevano un po di forze oppure, se
superavano questa fase, allora, poiché la malattia scendeva nel ventre a
produrvi forti ulcerazioni e una diarrea asciutta, generalmente morivano a
causa di questa, per debolezza.
Il
male infatti, passava per tutto il corpo, cominciando dallalto dove si era
localizzato nel capo; e se si sopravviveva ai suoi attacchi
più violenti, i suoi effetti si manifestavano alle estremità.
Colpiva
infatti il sesso o le dita delle mani e dei piedi, molti scamparono perdendo
queste membra, alcuni anche gli occhi; altri, appena guariti, erano presi da
amnesia completa e non riconoscevano più né se stessi, né i propri cari.
Questo
genere di malattia, superiore a ogni descrizione, colpiva ciascuno con una
violenza troppo grande perché la natura umana potesse resistergli e si dimostrò
diverso dagli altri mali comuni anche in questo: gli uccelli e i quadrupedi che
si nutrono di carne umana, benché i cadaveri insepolti fossero numerosi, non vi
si avvicinavano, oppure, se ne assaggiavano, morivano.
La
prova è che gli uccelli di questo tipo erano assolutamente scomparsi, e non se
ne vedevano né intorno ai cadaveri, né altrove; i cani invece
permettevano meglio di osservare
questi effetti perché convivono con luomo.
Tralasciando
molti altri particolari per cui la malattia delluno si distingueva da quella
dellaltro, dirò che in genere la malattia presentava questo aspetto che ho
descritto; in quel tempo non infierì nessunaltra delle solite malattie: se se
ne manifestava una, alla fine si trasformava in questa.
SI MORIVA CON LE CURE
E SENZA
CURE
|
A |
lcuni
morivano perché non curati, altri nonostante tutte le cure; si può dire che non
vi fosse proprio nessun rimedio la cui applicazione potesse giovare; quel che
era utile a uno era nocivo a un altro; nessun corpo, forte o debole che fosse si
rivelò capace di resistere al male, ma tutti ne erano colpiti, anche quelli
tenuti a regime con ogni cura.
Leffetto
più terribile di tutto questo male era lo scoraggiamento che colpiva chi
saccorgeva dessere malato (lasciandosi subito andare alla disperazione, si
abbattevano ancor di più e non opponevano resistenza) e il fatto che, curandosi
lun laltro, si contagiavano e morivano come bestie; questa era la principale
causa della moria.
Infatti,
se per timore (di prendere il male) non si avvicinavano luno allaltro,
morivano abbandonati e molte case rimasero vuote perché mancava chi prestasse
le sue cure; se invece si avvicinavano ai malati, morivano, specialmente coloro
che volendo dar prova di altruismo, senza riguardo per la propria salute, andavano
dagli amici; e perfino i parenti, vinti dallenormità della sciagura, avevano smesso il compianto
funebre dei defunti.
Ancora
di più, coloro che avevano superato il morbo e lo conoscevano per averlo
scampato e si sentivano al sicuro, compiangevano i moribondi e gli ammalati: esso
infatti non colpiva mai una seconda volta la stessa persona in maniera mortale
e quelli nutrivano per il futuro la fatua speranza di non dover mai più morire di
nessunaltra malattia.
Il
morbo infieriva anche per lammassamento in città di coloro che provenivano
dalle campagne in quanto abitavano in capanne che la calura rendeva soffocanti
e la moria si estendeva in piena confusione in quanto morendo i cadaveri
giacevano, oppure si rotolavano per le strade e intorno alle fonti per il
desiderio di dissetarsi, in cerca di acqua.
I
santuari erano pieni dei cadaveri di coloro che vi si erano attendati e lì
erano morti; le leggi umane e divine non erano più rispettate, né si seguivano
le consuetudini delle sepoltura, ma ciascuno seppelliva dove poteva e molti ricorrevano
a sepolture indecorose, perché ponevano i propri morti su pire altrui e accendevano
il fuoco; altri invece gettavano i propri morti su pire che stavano bruciando,
gettandoli sugli altri cadaveri e se ne andavano.
In città
gli uomini morivano e fuori il paese era devastato dai peloponnesi i quali
erano rimasti nellAttica quaranta giorni e andarono via perché, si diceva,
avevano saputo dai disertori che in città vi era la peste.
La peste era durata circa due anni, ma non era cessata definitivamente perché riprendeva (427-426) e durava da meno di un anno quando morirono quattromila quattrocento opliti dellesercito regolare e trecento cavalieri; per colmo di sventura vi furono anche diversi terremoti nelle stessa Atene, nellEubea e in Beozia e, in particolare, a Orcomeno di Beozia.
E vi erano stati ulteriori strascichi, se negli anni seguenti (428) il grande Pericle (495 c.ca-429) che aveva dato il suo nome al secolo in cui era vissuto (come lo chiama Voltaire, il secolo di Pericle ne Il secolo di Luigi XIV), aveva visto morire i suoi più cari amici, poi la sorella, poi il figlio Santippo e quando gli fu tolto il prediletto Parolo non poté frenarsi dal versare un torrente di lacrime; il morbo non lo risparmiò ma ne fu minato poco a poco; gli amici lo assistevano intorno al suo letto e parlavano delle sue virtù, della potenza che aveva avuto e dei trofei che egli aveva innalzato per la patria; ma Pericle aveva sentito e si era meravigliato che lo lodassero di cose alle quali egli doveva la sua fortuna e che tanti altri capitani avevano fatto prima di lui, mentre non avevano parlato della sua vittoria più bella: che nessun ateniese si fosse mai vestito di bruno per causa sua.
*)
Il testo è ripreso da Storie di Tucidide, Club del Libro, Novara, 1966.
DURANTE
IL REGNO
DELLIMPERATORE
GIUSTINIANO
Riportiamo quasi per
intero la descrizione
di Procopio di Cesarea,
meno conosciuta, sebbene pari nella descrizione
al racconto di Tucidide,
|
C |
irca novecento
anni dopo la peste di Atene, a Bisanzio, capitale dellimpero bizantino,
durante il regno dellimperatore Giustiniano ((v. in Articoli: I Mille anni
ecc. Cap. III)), vi fu unaltra ondata di peste che a dire di Procopio, poco era mancato che andasse distrutto lintero
genere umano.
Qualificata come variolas,
vaiolo, non era del genere che colpiva i bambini; era ben diversa e non
presentava gli stessi sintomi nei vari luoghi che ne fossero colpiti; partita anche
questa dallEtiopia, era passata allEgitto e invaso
Scoppiò
innanzi tutto in Egitto, tra gli abitanti della città di Pelusio (
Sembrava
infatti che si movesse secondo una regola fissa, sostando in ciascun paese per
un determinato periodo di tempo e colpendo tutti col suo contagio, non certo
alla leggera, per poi trasferirsi in unaltra zona, fino agli estremi confini
della terra, come se temesse che qualche angolo del mondo le potesse sfuggire.
Difatti
non lasciò indenni né una sola isola né una spelonca né la cima di un monte ove
si trovassero esseri viventi; e per caso saltò qualche villaggio senza
attaccare gli uomini che vi abitavano o sfiorandoli appena leggermente; più
tardi tornò di nuovo indietro e senza più toccare per nulla coloro che vivevano
nelle vicinanze e che aveva già duramente decimato in precedenza; non si
allontanò da quel villaggio finché non ebbe esattamente pareggiato il numero
dei morti a quello degli abitanti vicini morti prima.
Cominciando
sempre dalle regioni costiere questo contagio poi di là sintroduceva
nellentroterra; il secondo anno, a metà della primavera arrivò pure a
Bisanzio, dove anchio mi trovavo in quel periodo di tempo.
CHI NE ERA COLPITO
VEDEVA I
FANTASMI
|
M |
olti
cittadini cominciarono collavere delle apparizioni di fantasmi, del tutto
simili a uomini nellaspetto: e quando simbattevano in essi, sembrava loro di
venir colpiti in qualche parte del corpo dalluomo in cui si erano imbattuti;
subito dopo aver avuto tale apparizione, venivano colti dalla pestilenza.
Da
principio, chi vedeva i fantasmi cercava di cacciarli facendo scongiuri, come
meglio poteva, ma senza ottenere assolutamente alcun risultato, tantè vero che
molti morirono persino nelle chiese in cui si erano rifugiati; più tardi, per
lo più, rifiutava persino di ricevere gli amici che venivano a fargli visita e
si chiudeva nella propria stanza, fingendo di non sentire se qualcuno bussava
alla porta, evidentemente perché temeva che a chiamarlo fosse uno di quei
fantasmi.
Per
altri però, la peste non sopravveniva in questo modo, bensì avevano delle
visioni durante il sonno e sembrava loro di subire gli stessi colpi da parte
del fantasma sognato o di udire una voce che annunciava loro che erano già
iscritti nellelenco dei morti.
Ma
alla maggior parte delle persone accadeva di essere colte dalla pestilenza
senza essere preavvertite di ciò che sarebbe successo né da sveglie né in
sogno.
Si
ammalavano in questo modo: Erano
assalite allimprovviso dalla febbre, alcune appena si svegliavano dal sonno,
altre mentre passeggiavano, altre ancora mentre erano intente a fare qualsiasi
altra cosa; il corpo non cambiava il suo
precedente colore, né diveniva caldo, come avviene a chi è colto dalla febbre e
neppure appariva alcuna infiammazione, ma dal mattino fino alla sera la febbre
era così debole che né ai malati stessi
né al medico che tastava loro il polso sembrava preannunciare un indizio di
pericolo.
Quindi,
nessuno fra coloro che si erano ammalati credeva di dover morire per quel male;
ma qualcuno nella stessa giornata, qualcuno nella seguente, altri non molti
giorni dopo, vedevano formarsi un bubbone non soltanto in quella parte del
corpo sotto laddome chiamata inguine, ma anche sotto le ascelle e in qualche caso
anche dietro le orecchie o in un punto qualsiasi delle cosce.
Fino a questo stadio della malattia, più o meno i sintomi erano uguali
per chiunque ne fosse colpito; ma da quel momento cominciavano manifestazioni
differenti, non so dire se per la diversità delle costituzioni fisiche o perché
cosi fosse la volontà di Colui che aveva mandato lepidemia.
Alcuni
infatti cadevano in un profondo coma, altri erano presi da un violento delirio,
e tanto i primi che i secondi soffrivano esattamente tutti gli inconvenienti
caratteristici di queste due infermità.
Quelli
che erano sotto leffetto del coma, sembrava dormissero in continuazione; se
cera qualcuno che si prendeva cura di loro, di tanto in tanto assaggiavano un
po di cibo, ma se erano abbandonati a se stessi, per
mancanza di nutrimento in breve tempo morivano.
Invece
quelli che erano presi dal delirio soffrivano dinsonnia e di frequenti
allucinazioni e immaginando che qualcuno venisse ad ucciderli, erano scossi da una
terribile agitazione, per cui si precipitavano in fuga, gridando
disperatamente.
Cosi
coloro che li assistevano stavano in continua apprensione, affranti dalla pietà
e dal dolore, tanto che tutti avevano compassione di loro non meno che dei
malati; e non perché avrebbero potuto contrarre la pestilenza andando loro
vicino: infatti non accadde che alcun medico o altra persona venisse contagiata
dalla peste per aver toccato un malato o un morto, tantè che molti, i quali
erano sempre occupati a curare e a seppellire anche persone estranee, contrariamente
a quanto si potrebbe supporre, continuarono nella loro attività, mentre molti
altri furono subito colpiti inesorabilmente dalla malattia e morirono in breve
tempo.
Si
aveva invece compassione di costoro perché dovevano sopportare durissime pene: per
esempio, quando i malati cadevano dal letto e si rotolavano a terra, essi li
rimettevano a posto e quando tentavano di gettarsi giù dal tetto di casa,
dovevano afferrarli e strapparli via a viva forza; se per caso si trovavano
vicino a un po dacqua, volevano buttarsi dentro, non per desiderio di bere
(molti infatti si sarebbero buttati anche nel mare), ma la causa era da cercare
unicamente nella loro alterazione mentale; gli assistenti dovevano anche
faticare molto per far loro prendere cibo, perché non lo accettavano
voléntieri; tanto che molti, mancando qualcuno che li assistesse, morirono o
consunti dalla fame o per essersi gettati giù dallalto.
Coloro
che non cadevano in coma o non erano colti dal delirio, morivano invece perché
il bubbone andava in cancrena ed essi non riuscivano più a sopportare il
dolore.
Si può
forse supporre che ciò sia accaduto anche a tutti gli altri, ma che, non
essendo nelle loro piene facoltà mentali, non abbiano minimamente potuto
rendersi conto della sofferenza, perché lalienazione toglieva loro la
sensibilità al dolore.
NON VI ERA NESSUNA
SPIEGAZIONE
PER
|
O |
ra,
alcuni medici, trovandosi in imbarazzo perché non conoscevano tutti questi
sintomi, congetturarono che il focolaio della malattia consistesse nei bubboni
e perciò decisero di esaminare i cadaveri di coloro che erano morti; sezionato
un certo numero di bubboni, scoprirono che nel loro interno si era formata una
specie di carbonchio purulento.
Alcuni
morivano subito, altri molti giorni dopo, e in certi casi fiorivano su tutto il
corpo delle pustole nerastre grosse come lenticchie; costoro non rimanevano in
vita nemmeno un giorno, ma morivano immediatamente; molti altri, anzi, erano
colti allimprovviso da uno spontaneo sbocco di sangue che li faceva restare
soffocati sul colpo.
Sinceramente
posso affermare che medici assai rinomati diagnosticarono a molti che sarebbero
ben presto defunti mentre essi, viceversa, poco dopo si sentirono
inaspettatamente liberi da ogni male; a molti altri assicuravano che si
sarebbero salvati e invece erano già quasi sul punto di morire.
Cosi,
di questa malattia, non cera nessuna spiegazione possibile per la scienza
umana, perché in tutti i casi essa aveva un decorso imprevedibile; ad alcuni
era di giovamento lavarsi, altri anche cosi erano ugualmente stroncati dalla
morte; molti morivano per mancanza di cure, altri invece si salvavano; i metodi curativi avevano per ogni singolo
paziente effetti differenti; si può dire, insomma, che nessuno sapeva come fare
per salvarsi, sia che prendesse precauzioni per evitare il contagio, sia che
cercasse di superare la malattia una volta che ne era colto.
ALCUNI APPESTATI
SUPERAVANO
|
C |
i si
ammalava senza motivo e si guariva per puro caso; le donne incinte, se si
ammalavano, morivano sicuramente, alcune di aborto, altre durante il parto e la
morte le coglieva subito, insieme con i loro neonati.
Tuttavia si racconta di tre
donne che sopravvissero, mentre morirono i loro bambini e di unaltra che
invece mori proprio nel momento in cui partoriva, mentre il figlio nacque e
rimase in vita.
Nei
casi in cui il bubbone diventava molto grosso e maturava pus, poteva succedere
che gli appestati superassero la malattia, evidentemente perché la virulenza
del carbonchio trovava lì una via di sfogo e in genere questo era un indizio di
guarigione.
Ma se
al contrario il bubbone manteneva sempre la forma originaria, allora si
manifestavano le complicazioni di cui ho prima parlato. Avveniva anche che a
qualcuno di questi malati le gambe si rinsecchivano e perciò, se il bubbone si formava li, non poteva andare a suppurazione.
A
taluni avvenne di scampare alla morte, ma ne rimase offesa la lingua, nel senso
che per tutta la vita restarono balbuzienti o incapaci di articolare le parole
in modo intellegibile.
A
Bisanzio la pestilenza durò quattro mesi, e in tre di questi fu soprattutto violenta; da principio
la mortalità fu di poco superiore al consueto, lepidemia si diffuse sempre più
rapidamente e il numero dei morti raggiunse la media di cinquemila il giorno,
per arrivare persino a diecimila e anche di più.
I PROVVEDIMENTI
DELLIMPERATORE
E
REFERENDARIO
|
N |
ei
primi tempi ciascuno si preoccupava di dar sepoltura ai morti della propria
famiglia, magari deponendoli di nascosto e con la violenza nelle tombe di altre
persone; in seguito tutto finì in una grande confusione generale.
Vi
furono schiavi che rimasero senza padrone, uomini prima molto benestanti che si
trovarono privati del servizio dei loro domestici o perché malati o perché
defunti; alcune case restarono completamente deserte di persone; per
conseguenza accadde che in quel caos
anche qualche illustre personaggio rimase parecchi giorni insepolto.
Limperatore
naturalmente si preoccupò di prendere provvedimenti per tale situazione e diede
incarico di occuparsi di tutti questi problemi a Teodoro, assegnandogli guardie
di palazzo e una somma di denaro.
Costui
aveva la mansione di segretario relatore delle decisioni imperiali, nel senso
che segnalava allimperatore la richiesta dei postulanti e poi riferiva a
costoro, a loro volta, quali fossero le sue deliberazioni; i Romani chiamano
questa carica col nome latino di referendarius (v. I mille Anni dellimpero bizantino, in
Schede: Cariche di Corte e della Chiesa).
Così,
mentre coloro che non avevano ancora visto cadere in completa distruzione la
loro situazione familiare provvedevano personalmente alla sepoltura dei propri
congiunti, Teodoro, distribuendo il denaro avuto dallimperatore e attingendo
anche al suo patrimonio, faceva seppellire i cadaveri di coloro che erano
rimasti senza assistenza.
Quando
alla fine si giunse al punto che tutte le tombe esistenti furono piene di
cadaveri, la gente se la sbrigava scavando delle fosse nelle campagne intorno
alla città, una dopo laltra, deponendovi i morti, ciascuno come meglio poteva.
Ma in
ultimo, coloro che scavavano le fosse, non potendo più far fronte al numero dei
defunti, salivano sulle torri che sorgono lungo le mura di Sica, e,
scoperchiati i tetti, vi gettavano dentro i cadaveri in gran disordine; così
praticamente riempirono tutte le torri di cadaveri, accatastandoli alla
rinfusa, secondo come cadevano e poi le coprirono di nuovo coi tetti.
Perciò
da esse cominciò a diffondersi fino alla città un puzzo nauseabondo, che
diveniva sempre più insopportabile per gli abitanti, specialmente se soffiava
il vento provenendo da quella parte.
NON VI ERA POSTO
PER
SEPPELLIRE I MORTI
LE STRADE
ERANO DESERTE
LE
ATTIVITA MERCANTILI
ERANO
BLOCCATE
|
I |
n quei
giorni tutte le norme relative ai riti funebri erano trascurate; i morti non
venivano scortati da processioni, comè consuetudine, né accompagnati con i
soliti canti, ma era già abbastanza se si trovava qualcuno che portasse a
spalle uno dei morti fino alla spiaggia della città e qui giunto lo gettasse a
terra, di dove i cadaveri sarebbero poi stati caricati su di una nave e
trasportati e buttati in acque più profonde.
In
quei momenti, però, i cittadini che prima erano stati divisi in fazioni,
deposto lodio reciproco, attendevano in comune agli uffici funebri, portando
via personalmente e seppellendo anche i cadaveri di gente a cui non erano uniti
da nessun legame.
Coloro
che prima si erano compiaciuti di condurre una vita dissipata e piena di vizi,
anchessi, abbandonate le loro riprovevoli abitudini, seguivano con scrupolo le
norme della religione, non perché avessero imparato ad essere saggi e fossero
diventati improvvisamente amanti della virtù, ma perché allora erano tutti
quanti, si può dire, terrificati da ciò che succedeva, e, temendo di dover
anchessi prima o poi morire, erano logicamente costretti dalla necessità delle
cose a imparar momentaneamente la morigeratezza.
Tanto
è vero che, appena guarivano dalla peste di cui si fossero contagiati, ritenendo
di essere ormai al sicuro, perché lepidemia era passata ad altre persone,
cambiavano di nuovo idea e tornavano ai loro vizi, dando più ancora di prima
dimostrazione della loro sconveniente condotta e anzi superando se stessi in dissolutezza e in ogni altro genere di
malefatte.
Si
potrebbe addirittura sostenere paradossalmente, ma senza dire una bugia, che
quella pestilenza, o per caso, o per un disegno divino, fece una scelta diligentissima,
lasciando indenni proprio gli uomini peggiori.
Ma questo si poté constatare solo qualche tempo più tardi.
Per il
momento, a Bisanzio, non era facile veder girare qualcuno per le strade, perché
tutti coloro che avevano 1a fortuna di essere in salute rimanevano chiusi in
casa o a curare i malati o a piangere i morti.
Se
capitava dincontrare una persona che passava per via, era perché stava
portando un cadavere; ogni attività era ferma, tutti gli artigiani avevano
abbandonato la loro arte, e così accadeva di ogni altra specie di lavoro che
ciascuno avesse per le mani.
Di
conseguenza, in quella città chera stata veramente sovrabbondante di ogni
genere di beni, si era diffusa una spaventosa carestia; trovare un po di pane
o qualunque altra cosa in misura appena sufficiente, appariva senza dubbio
unimpresa molto difficile e degna di nota, cosicché si può dire che per
diversi malati la morte sopravvenne prima del tempo per mancanza del
necessario.
Insomma,
a Bisanzio non era più assolutamente possibile vedere qualcuno che indossasse
la clamide, specialmente quando avvenne che si ammalò anche limperatore; a lui
pure, infatti, si sviluppò un bubbone; ma nella città chera la capitale dellimpero romano tutti i cittadini se ne stavano ritirati,
indossando gli abiti normalmente usati in casa.
Questo
fu dunque landamento della pestilenza in tutto limpero
romano e particolarmente a Bisanzio; ma essa si abbatté anche
sullimpero persiano e fra tutti gli altri barbari.
DEL 1350
|
S |
viluppatosi
nei topi (Rattus-Rattus) portatori di pulci, tra le
dune di sabbia del deserto del Gobi e trasportata dalle carovane o dai soldati o
dal rapido servizio postale degli imperatori mongoli, un male misterioso si era diffuso in Cina (1331) e lanno
seguente (1332) aveva colpito il ventottenne Gran Khan Jiiagatu
Toq-Temur con i suoi figli; era avanzato (1346) nelle Indie orientali,
dove non aveva fatto molte vittime; a Tabriz (Iran), si era fermato per sei
mesi e poi aveva proseguito la sua corsa; il flusso in Europa seguì invece la
strada della Crimea con le navi di mercanti che attraversarono il Mar Nero..
A
Cipro dove era vivo il commercio portato dai mercanti, i musulmani, temendo che
gli schiavi si ribellassero, avevano pensato di metterli a morte, ma furono
distratti da un improvviso terremoto; chi fuggiva dal morbo era inghiottito
dalle voragini, mentre in mare i vascelli erano inghiottiti come fuscelli; a
queste sventure, si aggiunse una invasione di cavallette e un nebbione aveva ricoperto per lungo
tempo tutta
Questa
peste fu particolarmente virulenta perché la popolazione era indebolita dalla
precedente carestia e vi avevano contribuito anche le scarse condizioni
igieniche personali e generali; la gente infatti conviveva con gli animali
domestici e dove vi erano animali domestici vi era anche un numero maggiore di
topi; la malattia non era uguale dappertutto; era caratterizzata da 1. infiammazione
della gola e polmoni; 2. violenti dolori al petto; 3. vomito e tosse con vomito
sanguinolento; 4. fetore emanato dal corpo e dallalito; su una popolazione
totale di cento milioni si ebbero dai 25 ai 30 milioni di morti.
AI FLAGELLI SI AGGIUNSE
LINVENZIONE DELLE BOMBARDE
INAUGURATE
NELLA BATTAGLIA DI CRECY
|
L |
Italia era travagliata da tanti disordini e da tanti mali, quando
fu colpita allimprovviso dai più terribili flagelli che il cielo avesse potuto
riservare per castigo della terra: una crudele carestia e la più mortifera
pestilenza di cui le storie abbiano serbato memoria; a questi si potrebbe
aggiungere, un terzo flagello: linvenzione della bombarda, che avvenne in questepoca
sventurata.
Con questo ritrovato (scrive Sismondi) il soldato fu ridotto ad essere semplice macchina, il potere dei
despoti accresciuto, indebolito quello delle nazioni, private le città della sicurezza che
davano loro le mura; ma i durevoli effetti dì così funesta invenzione non si
manifestarono che lungo tempo dopo.
Le bombarde, di cui parlano per la prima volta gli storici, furono
adoperate il 26 agosto del 1326 nella battaglia di Crecy,
tra Inglesi e Francesi; non parvero ai
principi che macchine atte a scagliar delle palle per spaventare i cavalli col
fragore e col fuoco.
Il re dInghilterra, tra bombardieri che aveva egli solo nel suo
esercito, e le saette darco che nellaria sembravano una nuvola e non cadevano
senza ferire persone o cavalli; con i colpi delle bombarde che facevano si grande tremuoto e romore , che pareva
che Iddio tonasse; con grande uccisione di gente e sfondamento di cavalli, Edoardo III sconfisse i francesi.
Lo stesso anno lItalia fu afflitta dalla carestia e le intemperie delle stagioni ne furono la principale cagione; piogge
a dirotto dellautunno (1345), non permisero le seminagioni in ottobre e
novembre e fecero infracidire il frumento che cominciava a germogliare.
Nella seguente primavera imperversarono di nuovo le piogge con
eguale ostinazione; nei successivi mesi di aprile, maggio e giugno la terra fu
sempre o inondata o talmente ammollita, che le sementi delle biade marzuole e
del miglio, non riuscirono meglio di quelle dellautunno.
Né questa sciagura si ristrinse a una sola provincia, ma si
estese a tutta I Italia, alla Francia e ad altri paesi, sicché in gran parte
dEuropa non si era mai fatto un così scarso raccolto come nel 1346; il vino,
1olio ed ogni altro frutto della terra venne ugualmente a mancare.
SOSPENDEVA LE PROCEDURE
PER MINUTI DEBITI
E LIBERAVA I CARCERATI
PER DELITTI LEGGERI
|
Q |
uesta carestia era stata universale in Italia, e non tutte le città avevano provveduto ai
bisogni del popolo, con saggi o generosi regolamenti; ne conseguiva laffievolimento
dei corpi che viziavano gli umori e le malattie epidemiche non tardarono a
manifestarsi.
Frattanto, affinché i poveri non fossero tormentati dalla
carestia, dalle malattie e dai creditori,
Nella estate del 1347 la mortalità fu in Firenze grandissima,
specialmente tra i poveri, le donne e i fanciulli; si calcolava che la carestia
avesse fatto morire quattromila persone.
Ma nello stesso tempo un più terribile flagello si andava
preparando in Oriente; nel regno di Casan (Scizia), si erano aperte voragini
che vomitavano fiamme (si trattava certamente di fuoriuscita di magma ndr.), divampando fra le aride erbe, si
stesero da ogni parte, per molte e molte miglia intorno.
Coloro che si sottrassero a questo disastro, portarono una
malattia contagiosa, che sparsero sulle rive del Tanai (antico nome del Don) e
in Trabisonda: malattia funesta che in quelle
contrade, di cinque persone il morbo ne uccideva quattro.
A Sebastia (Palestina) cadde colla
pioggia unimmensa quantità dinsetti neri che avevano otto gambe e la coda, in
parte morti e in parte vivi; questi avvelenavano col morso; quelli morti si
decomponevano e infettavano laria.
La peste si sparse in tutto il Levante e corse per
Alcune
navi cristiane partite dal Levante la portarono (1347) in Sicilia, e poi a Pisa, dove vi
furono sette morti ogni dieci abitanti; a Siena i morti furono ottantamila in quattro
mesi; a Genova altrettanti in due mesi; sparsa in tutta Italia (1348) ne soffrì
non solo il commercio ma anche lagricoltura con la perdita delle messi di
grano e delluva che marciva incolta.
A Roma
vi furono centosettantamila morti, quanti ve ne furono a Napoli, esclusa
Trapani nel sud; a Milano e nei paesi vicini alle Alpi ai confini con
SPARSA IN EUROPA
I SINTOMI MUTAVANO
IN OGNI
LUOGO
AMICI E
PARENTI
SI
TENEVANO A DISTANZA
|
N |
el
1348 la peste valicò le montagne, e si estese alla Provenza, alla Savoia, nel
Delfinato e nella Borgogna e da Aigues-morts, penetrava
in Catalogna, Granata e
Nel
susseguente anno si sparse per tutte le altre terre occidentali fino alle rive
del mare At1antico,
Lanno
successivo (1349) raggiunse lInghilterra dove si alternò per nove anni mietendo cinquantamila
persone allanno,
Nel
1350 il contagio avanzò verso il Settentrione, spargendosi tra i Frisoni,
Tedeschi, Ungari, Danesi e Svizzeri.
Per
questa calamità la repubblica dIslanda fu allora distrutta; la mortalità fu sì
grande in quellisola agghiacciata che, rimasti soltanto in vita pochi e
dispersi abitanti, il popolo
islandese si spense completamente.
Quando
giunse in Germania (1350) fu preceduta da terremoto e tempeste di pioggia dove
fece, tra i soli frati francescani 124.434 morti e vi furono eccessi contrari
di devozione, pazzia e libertinaggio e fanatici flagellanti (v. sotto); dopo
aver raggiunto lUngheria, si rivolse (1361) a desolare Milano e Venezia dove
colpì il doge Giovanni Dolfin e molti cardinali e vi
furono centomila morti; quindi si rivolse verso Avignone.
Ritornò
a Firenze (1363) dove morì Giovanni Villani che laveva descritta e vi furono
centomila morti.
Era
cessata, ma riapparve verso fine secolo (1393), quando un infetto la portò a
Bologna e via mare giunse a Venezia e Genova e altri la portò a Brescia e
Verona; per ciascuna delle città più piccole era durata circa da cinque a sei
mesi nelle altre dodici mesi.
Il
male si manifestava con una febbre altissima che portava al delirio e
stordimento (stupore) e insensibilità; la lingua e il palato illividivano,
fetidissimo il fiato; a molti sopraggiungeva la peripneumonia (infiammazione dei polmoni)
con emorragie; macchie nere indicavano la cancrena accompagnata da ascessi
esterni; la maggior parte periva il primo giorno: non si conoscevano rimedi.
I
sintomi del morbo non furono in ogni luogo gli stessi: nellOriente unemorragia dal naso era certo
presagio della sopraggiunta malattia e della morte; in Firenze, in principio la
malattia si manifestava o allinguine o sotto le ascelle con una enfiatura della grandezza di un uovo ed
anche maggiore; più tardi questenfiatura, detta gavocciolo si manifestava indistintamente in qualsiasi parte del
corpo; la malattia mutava nuovamente i sintomi, che si manifestava di norma con
macchie nere o livide, in alcuni larghe e rade, in altri piccole e fitte.
Si
vedeva allinizio apparire sulle braccia o sulle cosce poi su tutto il corpo e
come il gavocciolo, erano presagio di
vicina morte; nessuna
arte medica poteva resistere al morbo, sebbene quando incominciò Iepidemia,
oltre ai professori di medicina, un consistente numero di ciurmatori vendessero molti rimedi che non guarivano un solo
ammalato; i più morivano il terzo giorno e quasi tutti senza febbre o alcuna
nuova manifestazione.
Nelle
contrade colpite dalla pestilenza, altissimo e universale fu il terrore nel vedere
con quale prodigiosa rapidità si dilatava il contagio; linfezione si contraeva
solamente conversando
con gli ammalati, non solo toccandoli, ma toccando le cose da loro toccate.
Si
videro animali cadere morti per aver toccato gli abiti degli appestati gettati
nelle strade e per questo non si riteneva una vergogna mostrarsi vili e senza
pietà; infatti, i cittadini non solo si
schivavano lun 1altro, ma i vicini abbandonavano i vicini e i congiunti, se
pur qualche volta si scambiavano visite, si mantenevano a tanta distanza
dallammalato, da mostrare il proprio terrore: e allinfuriare della malattia
fu visto il fratello abbandonare il fratello, lo zio il nipote, la sposa, il
marito e perfino alcuni genitori i propri figli.
E per
tal modo, allinfinito numero degli ammalati non rimase altro sussidio che l affetto eroico di un piccolo numero di amici o lavida
brama dei servi, che per una grossissima somma di danaro mettevano in pericolo
la loro vita per servire il signore.
SI CREDEVA CHE GIOIA
E PIACERI FOSSERO
IL SICURO
RIMEDIO
CONTRO
|
Q |
uesti
ultimi erano per la maggior parte rozzi contadini rozzi, poco avvezzi alla cura
deglinfermi, onde tutti i loro servigi si riducevano per 1ordinario ad
eseguire i comandi che loro davano gli appestati ed a portare alle famiglie la
notizia della loro morte.
Da
tale misero abbandono e dal terrore che colpiva gli ammalati, nacque unusanza
affatto contraria agli antichi costumi, che una donna giovane, bella e modesta
non disdegnava di farsi servire, inferma, da un uomo, comunque giovane e dallo
svestirsi in sua presenza, ogni qualvolta lo richiedesse la cura della
malattia, come se si fosse trovata con una donna.
Era
costume antico in Firenze che le congiunte e le vicine di un estinto di buon
casato, si adunassero nella casa di lui per piangerlo insieme alle più strette
parenti, intanto che i vicini e gli amici si riunivano coi preti innanzi alla
casa.
In appresso il cadavere del
defunto era portato alla chiesa indicata da lui medesimo prima di morire, da
uomini della sua condizione; precedevano il feretro i preti che cantavano,
portando i ceri accesi e chiudevano la pompa funebre i cittadini che si erano
adunati innanzi alla porta.
Ma
queste costumanze cessarono allinfierir della peste, e furono sostituite da
pratiche opposte; non solo gli ammalati morivano senza essere assistiti da
pietose donne, ma non rimaneva più neppure chi li servisse negli estremi
istanti della vita.
Era
invalsa lopinione che la tristezza disponesse i corpi a contrarre più
facilmente la malattia; si credeva per certo che la gioia e i piaceri fossero
il più sicuro rimedio contro la peste e le stesse donne tentavano di distrarre
lanimo dal lugubre apparecchio dei funerali, col riso, coi giuochi, coi
motteggi.
Pochi
cadaveri erano recati al sepolcro accompagnati da più di dieci o dodici vicini,
ed i portatori non erano già onorati cittadini della stessa condizione del defunto, ma persone
della più abbietta plebe, che si facevano chiamare becchini.
Per
grossa mercede costoro trasportavano precipitosamente il feretro non già alla
chiesa destinata dal morto, ma a quella più vicina, spesso quattro o sei preti
precedevano i becchini con pochi
ceri; ma talvolta ancora andavano costoro senza preti; e i preti poi, per non
affaticarsi con troppo lunghi o troppo solenni uffici, riponevano il cadavere,
con l aiuto dei becchini,
nella prima fossa che trovavano aperta.
La
condizione dei poveri ed anche dei cittadini di mezzo era ancora più misera;
chiusi a causa della povertà in case malsane e vicinissimi gli uni agli altri,
cadevano infermi a migliaia e siccome non vera chi li curasse o porgesse loro
alcun refrigerio, morivano quasi tutti.
I VICINI DI CASA
ERANO
AVVERTITI
DAL PUZZO
DEI
CADAVERI
|
E |
rano moltissimi,
sia di giorno sia di notte, quelli che cadevano miseramente moribondi o morti
nelle strade; degli altri abbandonati nelle case, non si conosceva dai vicini
la morte, se non per Il puzzo chesalava dai loro cadaveri.
Per
timore che non sinfettasse laria piuttosto che per carità, si recavano questi
a visitare le camere e far trarre i cadaveri dalle case ed a collocarli davanti
alle porte. Ed ogni mattina se ne vedevano ammassati nelle strade e portavano
le bare o se non ve nerano, il cadavere si metteva sopra una tavola e si
portava alla fossa.
Ben
più duna bara conteneva il marito e la moglie, il padre e i figli o due o tre
fratelli ad un tempo; allorché si scorgevano due preti con una croce
accompagnare un feretro e dire Iufficio de morti, da ogni porta uscivano
altri feretri che si associavano al convoglio ed i preti convenuti per 1a
esequie di un solo defunto, ne trovavano sette od otto da seppellire.
Il
terreno sacro non bastava più a tanti cadaveri, onde si cominciò a scavare nei
cimiteri grandissime fosse nelle quali si collocavano i corpi a strati, di mano
in mano che vi si portavano, poi si ricoprivano con poca terra.
Frattanto
i vivi, persuasi che i diletti, i giuochi, i canti. lallegria potevano solo
scamparli dalla morte, non pensavano più ad altro che darsi bel tempo, non solo
nelle proprie, ma nelle case
altrui, ogni qualvolta credevano trovarvi cosa da dilettarsene.
Tutto
era in balìa di tutti, per cui ognuno, non pensando più alla vita, aveva
abbandonato ogni cura di sé stesso e delle sue sostanze; la maggior parte delle
case erano diventate comuni e chiunque vi entrasse, ne usava come in casa
propria.
Era smarrito
ogni rispetto delle leggi divine ed umane in quanto i loro ministri e chi altro
dovesse provvedere alla loro esecuzione, erano morti o infermi o privi di
guardie e di fanti, che non potevano incutere alcun timore, onde ognuno si
riteneva libero di fare tutto quello che gli tornava a grado,
Le
campagne non erano meno desolate dal contagio, che le città; e i castelli e le
terre erano limmagine
delle metropoli; gli sventurati agricoltori che abitavano le case sparse nei
campi e non potevano sperare né nei consigli di medici, né nellassistenza di
servi, morivano sulle pubbliche strade, nei campi o nelle case, non da uomini
ma da bestie.
In tal
modo non si curavano più delle cose di questo mondo, come se fosse loro
prefissato il giorno della morte, non pensavano più né ai frutti della terra né
al premio delle loro fatiche e invece si sforzavano di consumare al più presto
ciò che avevano già raccolto in precedenza.
Gli
armenti erravano derelitti per i campi abbandonati tra le messi non raccolte e per lo più
rientravano senza guida la sera nelle stalle, benché non vi fossero padroni o
pastori per custodirli.
La
pestilenza non aveva mai in nessun altro tempo disertata a questo modo
lItalia; in Firenze
e nel territorio, di cinque persone ne morirono tre e il Boccaccio è del parere
che la sola città perdesse più di centomila persone.
In
Pisa, di dieci persone ne morirono sette; ma sebbene in questa città, come
altrove, si fosse conosciuto per prova che chiunque toccasse un morto o le sue
vesti o anche soltanto il danaro, era preso dal contagio, sebbene non si
trovasse alcuno che per mercede volesse rendere ai defunti gli estremi uffici,
pure nessun cadavere restò nelle case senza sepoltura.
I
cittadini si chiamavano lun laltro, in nome della carità cristiana, aiutiamoci, dicevano, a portare questo morto alla fossa affinché altri ci portino quando
morremo.
A Siena,
nei quattro mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la peste rapi ottantamila
persone; la città di Trapani in Sicilia (precedentemente risparmiata ndr.) rimase deserta essendo morti fino
allultimo tutti gli abitanti; Genova ne perdette quarantamila, Napoli
sessantamila,
ELOGIO DI
DI GIOVANNI
VILLANI
MUORE DI PESTE
|
O |
sserva
uno storico che in Europa morirono personaggi dalle qualità illustri, mentre la
peste lasciò in vita tutti coloro per i quali la morte sarebbe stata
desiderabile; chi merita di essere da noi più compianto (scrive Sismondi), è Giovanni Villani, lo storico più fedele, più
veritiero, più leggiadro e più animato che avesse fin allora prodotto lItalia.
Abbiamo
fatto non interrotto uso della sua storia, pel corso di un mezzo secolo,
ponendo in lui quella fede chè dovuta ad un autore contemporaneo e giudizioso
che fu parte egli stesso delle cose.
Villani,
come egli stesso racconta, era andato a Roma nel giubileo del 1300 (*); e quivi
appunto, paragonando la decadenza di quellantica capitale del mondo colla
crescente grandezza della sua patria, fermò il disegno di scrivere la storia di
Firenze.
Il
Villani socio di una compagnia di mercanti, aveva pure viaggiato in Francia e
nei Paesi Bassi; fu più volte dei priori della repubblica ed ottenne altri
pubblici uffici, come di direttore della zecca e delle fortificazioni e dell ufficio dell abbondanza delle biade, dimostrando di
poter occupare qualsiasi carriera pubblica e privata.
Verso
la fine della sua vita fu rovinato dal fallimento dei Bonaccorsi dei quali era
socio; e qualcuno scrisse che era stato imprigionato per debiti.
Gli
ultimi libri della sua storia pare diano segno di queste private disavventure,
ed indicano che lautore era diventato dumor tetro e lento; quando morì di
peste nel 1348, doveva essere giunto a matura vecchiaia (1280-1348).
Altre
cronache italiane terminano nella stessa epoca; il che dà luogo a credere che i
loro autori cadessero vittime della pestilenza. Giovanni dÀndrea,
il più illustre giurisperito dIalia e
In
tempo della carestia e della peste, i popoli d Italia, oppressi da tante calamità rimasero per
la maggior parte in una forzata inazione.
*) Era stato il primo Anno Santo (Giubileo) istituito da
Bonifacio VIII e doveva essere centenario, ma Clemente VI, che si trovava in
Avignone, lo rese cinquantenario; Roma nel 1350 era una città in piena
decadenza per di più danneggiata dal precedente terremoto; la peste quellanno
laveva risparmiata e quei pellegrini che vi si erano recati, come Petrarca, ne
rimasero indenni: arriverà infatti sei anni dopo (1356) da giugno fino al marzo
dellanno seguente, riprendendo poi fino a luglio.
RIAPPAIONO I
FLAGELLANTI
|
A |
pparsi
nel 1260, uomini e donne cominciarono numerosi (migliaia!) a vagare per
lItalia flagellandosi a sangue, invocando la pace e inducendo gli usurai a
restituire; trentamila bolognesi si recarono a Modena cantando laudi; poi andarono
a san Gimignano, si flagellarono e ottennero ospitalità, distribuendosi in quelle
case.
Molti
signori come Oberto Pelavicino (Lombardia), Obizzo
dEste (Ferrara), Torriani a Milano, Manfredi in Sicilia piantarono le forche per coloro che
fossero entrati nelle loro città; e, confraternite con vessilli e divise si
recarono altrove.
Nel
1334 fra Venturino da Bergamo seguito da diecimila (e oltre!) uomini che portavano una
gonnella bianca fino a mezza gamba, di sopra una tabarella di biado corto fino al
ginocchio; calze bianche e stivali a mezza gamba, in petto una colomba bianca
collulivo in bocca, nella mano destra il bordone, nella sinistra il rosario,
si recarono a Roma; al papa non piacque e fra Venturino fu messo nelle carceri.
Durante
la peste in Germania i flagellanti si recarono a Spira e in cerchio intorno
alla chiesa, a torso nudo, con le braccia in croce, ognuno riceveva le sferzate
dal vicino dandosi poi il cambio; accompagnavano le sferzate con adorazioni e
canti in tedesco.
Terminata
questa cerimonia, uno di loro leggeva una lettera presentata da un angelo alla chiesa di
san Pietro in Gerusalemme, che annunziava che Cristo era irritato per i peccati
commessi nel mondo, che potevano essere rimessi con lintercessione di Maria,
purché si rimanesse trentaquattro giorni fuori casa e ci si flagellasse (non si
hanno notizie sul loro rapporto con la diffusione della peste).
In
ogni caso erano ben accolti e ricevevano donazioni, il giorno lo passavano in
pubblico; la notte la passavano in chiesa, esclusa la domenica.
Il
loro vestito era nero con croci rosse davanti e dietro e sui berretti, con gli
staffili alla cintura; erano in molti quelli che li seguivano e ricevevano
donazioni; dovevano avere da spendere quattro denari al giorno, essere confessati
e comunicati, aver perdonato i nemici e ottenuto lassenso delle mogli.
Passarono
nei Paesi Bassi, in Francia, in Italia; non fu possibile evitare i disordini
quando vollero imitarli le donne; ritenevano di scacciare i diavoli e si
confessavano e assolvevano lun laltro.
Il
papa Clemente VI (1342-1352) li disapprovò ordinando di denunziarli; il re
Filippo VI di Francia li minacciò di morte se fossero entrati in Francia.
Altra
ondata apparve nel 1399.
Giravano
così per nove giorni, facendo almeno tre chiese al giorno; entrando in un paese
cantavano orazioni
e Stabat Mater recitando tre miserere entrando
in chiesa; durante i nove giorni facevano vita quaresimale, non dormendo in
letto, non svestendosi, molti andavano scalzi; preannunciavano il loro arrivo
nelle città nel nome di Maria vergine chiedendo di accoglierli con devozione.
DallIrlanda
andarono in Inghilterra, in Francia, poi a Genova, in Lombardia, in Toscana e
nel resto dItalia, annunciando la pace, la concordia, facendo prediche e
miracoli.
A
questi eccessi di devozione si contrapponevano eccessi di libertinaggio da
parte di coloro che ritenevano di godersi gli ultimi sprazzi della vita; non
potevano mancare le accuse agli ebrei di avvelenare i pozzi e ne furono
trucidati a centinaia, nonostante il papa Clemente VI avesse cercato di frenare
quel furore.

|
I |
l continuo ritorno della peste nel
medioevo e la paura che ossessionava nella vita di tutti i giorni ricchi e
poveri, aveva fatto sorgere il gusto macabro per la morte, rappresentato, nel
campo artistico dalla danza della morte o danza
macabra, che
costituiva la allegoria tra una vita fugace,
vissuta nel contrasto dello splendore delle corti e della nobiltà e quella dei
numerosissimi poveri e il pensiero della morte che portava al disfacimento e alla
putrefazione del corpo umano.
Nel
campo letterario troviamo The Dance of
the Sevin Deidly Synnis o The
Dance of the Seven Deadly Sins (La danza dei
sette peccati mortali),
del poeta scozzese William
Dunbar (1450?-1520?), e un poemetto satirico
grottesco Danza de
Composto
probabilmente al principio del XV sec.,
Ciascuno
confessa le colpe della sua vita mortale e le compiacenze che ha riposto nei
beni evanescenti, dimentico dell'eterno bene; e ascolta i pungenti rimproveri pronunciati
dalla Morte.
Nellarte
pittorica la rappresentazione della Morte si sviluppò in tutta Europa e
particolarmente in Italia dove la rappresentazione più antica del 1485, è a Clusone
sopra riprodotta); al Cimitero di Pisa abbiamo invece il Trionfo della Morte.
Il
tema della Danza fu ripreso in
Germania nel Todten-Tanz
di Matthaeus Merian nel
1625 con quarantacinque riproduzioni dei rappresentanti delle categorie sociali
che danzano con la morte, accompagnate da versetti rimati in tedesco e latino
di cui riportiamo la chiamata al
risveglio, vale a dire
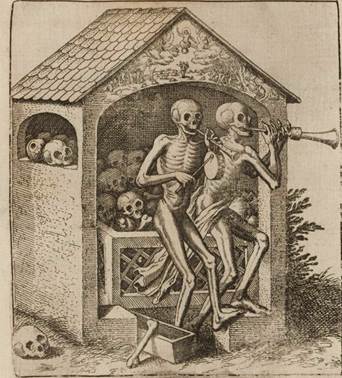
Da Todten-Tanz
- Matthaeus Merian - 1625
LA
PESTE
STRISCIANTE DEL 1500
E GLI
STUDI CHE NE
ERANO
SCATURITI
|
N |
el
mondo scientifico oramai avanzato, si facevano tutte le ipotesi possibili e con
Girolamo Fracastoro (1476/78-1553); pur essendosi accreditata lidea del
contagio tra due persone, si riteneva ciò avvenisse attraverso il calore umano:
Fracastoro sosteneva che il contagio non necessita di
ricorso alle astrologiche qualità occulte:
il contagio è una consimilis infectio
che si trasferisce fra due corpi diversi attraverso particelle minime e
impercettibili. Allorigine si pone la putrefazione del corpo dovuta al calore e umidità
innati che evaporano da esso; le particelle disgregate dalla putrefazione si
uniscono in movimenti composti che vengono esalati dai corpi infetti e che
costituiscono la diffusione dellinfezione.
Nessuno
aveva pensato ai ratti e alle pulci, animaletti con i quali si conviveva perché
considerati domestici e la pulizia personale (le pulci prediligevano le ascelle
e linguine, dove poi si formavano i bubboni!), mentre la religione la
considerava peccaminosa, con il primato (tra i tanti!) di santa Caterina da
Siena che non si era mai lavata (ma si diceva che anche per diversi mesi il suo
intestino fosse rimasto fermo ... e questo non voleva dire che magari odorasse di santità!), ma ciò riguardava
anche i concorrenti dei cattolici, rappresentati da Martin Lutero con il suo
odore pestifero.
Ma non
erano solo i religiosi a non lavarsi; vi erano i re, come Luigi XIV, il grande re
Sole, riprodotto in tutta la sua maestà (Art. Veleni, filtri damore ecc. P.I) con
le scarpette col tacco rosso e le calze di seta ... ma gli puzzavano
maledettamente i piedi, perché non si lavava (laveva fatto solo due volte in
tutta la sua vita; bagnava solo le mani nella bacinella con acqua e alcol!) ... e vi era anche Carlo II di Spagna, suo
pronipote che oltre ad avere accentuate le deformità degli Asburgo puzzava
perché non gli piaceva lavarsi: Ma erano sempre i re!
NellAtene
pagana, si riteneva che fosse Apollo a
scagliare le frecce della peste; nella evoluzione del cristianesimo, le frecce erano
scoccate da Dio; e san Sebastiano, che era un militare, sotto limperatore Diocleziano
(nato a Narbona e morto a Roma tra il 286/7 e 304), era sopravvissuto alle
frecce della peste divina e fu considerato protettore delle pestilenze e i
milanesi avevano messo la città sotto la sua protezione; le ferite che egli
mostra nelle sue riproduzioni artistiche, tenendo il braccio sollevato, per mostrare
lascella con la sua guarigione, corrispondevano ai bubboni della peste.
San
Sebastiano, collegato alle teorie
miasmatiche, fu affiancato da san Rocco nel XV sec. a sua volta collegato alle
teorie innovative che vedevano la peste come una malattia del corpo, piuttosto
che proveniente dallaria.
Le
frecce, secondo la tradizione biblica, erano considerate lo strumento del
castigo divino e le periodiche epidemie, metafore del castigo, costituivano le punizioni
inflitte da Dio per i peccati commessi dagli uomini.
Considerata
malaria determinata dal castigo di Dio e dalle congiunzioni astrali. si
riteneva derivasse dalla putrefazione dellaria che causava la putrefazione
degli umori dei corpi, determinando febbri e bubboni; collegata quindi a luoghi
in cui acqua e aria erano inquinati e stagnanti e alle condizioni
meteorologiche con alta umidità, nebbia e piogge.
Era
stata personificata in un mostro o un drago e la moltiplicazione di pulci, cimici,
ratti era considerato preannuncio di peste; la prevenzione, diffusamente
considerata da tutti, cristiani e profani, era la preghiera!
Gli
elementi essenziali collegati alla gestione della epidemia erano loro, il
fuoco e la forca: Con loro la città doveva disporre di danaro per far fronte
ai mancati guadagni derivanti dalla
interruzione dei flussi commerciali e traffici e disponibilità per la
costruzione di lazzaretti; la forca serviva per controllare il movimento delle
persone, in quanto responsabili per la diffusione del morbo erano considerati i
poveri, o i vagabondi e le meretrici che circolavano liberamente; il fuoco
infine serviva per la purificazione dellaria.
Il
cinquecento è lepoca di maggior interesse per gli studi sulla peste e numerosi
furono i testi scritti sullargomento, in particolare tra Padova e Venezia,
come risulta dalla
bibliografia riportata in nota (*).
Questa
peste, definita per il periodo in cui si era verificata, del rinascimento, sarebbe iniziata già nel
1526 (ma anche prima se Giorgione era morto di peste nel 1511), diffondendosi
nelle grandi città quali Venezia, dove secondo Sanudo
(1527) vi erano stati più di dodicimila morti, con i corpi disseminati per le
strade; Milano e Napoli, continuando negli anni successivi 28, 29 e nel
Giunse
a Modena a luglio, cessando a novembre; la peste padovana (1556) iniziata a giugno era
terminata a settembre: si sa che la prima vittima che aveva diffuso il morbo
aveva un tumore alla gola; di tutte quelle che le avevano precedute, le più
terribili furono quelle del 1575 e 1577.
BIBLIOGRAFIA DEI TESTI CINQUECENTESCHI VENEZIANI E PADOVANI.
☻ Fasciculus Medicinae con
argomenti di carattere medico attribuito a Johannes de Katham
illustrata da 10 tavole destinate allinsegnamento che
segna linizio di questi studi nelletà moderna e raccoglie una sintesi delle
principali patologie di interesse medico-chirurgico: Urologia, astrologia
medica, flebotomia, ostetricia e ginecologia. Consiglio sulla peste di Pietro
da Tassignano. Le proprietà dei farmaci di origine vegetale e lAnathomia secondo le indicazioni di Mondino de Liuzzi.
Pubblicato a VE nel 1491 da Giovanni e
Gregorio De Gregori
☻ Consiglio sopra la peste di Vinetia
(1556) di Bernardino Termitano (1517-1576.
☻ Informazioni del pestifero e contagioso
morbo della città di Palermo (1576) di Gianni Filippo Ingrassia (1510): Introdusse un rigido
isolamento e si ebbero 3.ooo morti, mentre a Venezia dove non si procedette
allisolamento ve ne furono 60mila.
☻Il
poemetto: Canzone fatta intorno allo
stato calamitoso dellinclita città di Venezia nel colmo dei suoi maggiori
passati travagli per la peste (1576-77) di Benedetto Leoni, Vescovo di
Arcadia: E una specie di preghiera, senza riferimenti
storici o medici.
☻ De Peste libri duo (1579) di Alessandro
Masseria (1510-1598): Si incentrava sulla purificazione dellaria corrotta,
ritenuta veicolo di trasmissione tenuissimas particulus putrida et maligna, da purificare con
suffumigi, lavaggi di stanze e oggetti con aceto e acque profumate. Eseguì la
prima autopsia di cadavere morto di peste. La peste a Vicenza colpì 3omila
persone.
☻ De Simpathya et Antipathya rerum liber unus e De Contagiosis Morbis et Curatione Libri Ter VE
1546 di Girolamo Fracastoro (1476-1553).
☻ Ragionamento dellecc.mo N. M. sopra le
infermità che vengono dallaere pestilenziale del presente anno 1555, in Venetia, 1556, di Niccolò Massa (1489-1569) e Liber de
Febre pestilentiale
pubblicato il
Secondo Massa lepidemia era causata dallaria perché la malattia
colpiva tutti indistintamente, giovani, vecchi, uomini e donne. Oltre alla purificazione
dellaria con suffumigi e lavaggi degli ambienti egli sosteneva un regime
specifico per ristabilire il regime degli umori; insisteva sulla necessità di
pulire costantemente strade, canali, fiumi ed evitare il ristagno di acque.
☻ Consiglio sopra la pestilentia
quì di Padova nellanno MDLV dellecc.mo M.F.F. fatto
a richiesta di questi illustri signori di questa città di Francesco Figimelica
(n.a PD il 1490): Pur basandosi sulle distinzioni
classiche fra malattie epidemiche ed endemiche e pur ammettendo le epidemiche
causate dai miasmi dellaria, egli mostrava aderire alla teoria del contagio di
Fracastoro, per cui la peste si poteva trasmettere solo attraverso il contatto
tra due persone o attraverso la mediazione di un fomite; il modo per non ammalarsi era quello di fuggire e stare
lontano dalle persone infette.
☻ Historia della peste di Padoa dellanno MDLV
di Cristoforo Baravalle: E un trattatello in versi in cui descrive la peste che ha
colpito Padova, causando oltre 400 morti. Con i versi riesce a trasmettere il
ritmo incalzante della peste che si espande a macchia dolio spargendo il
terrore tra la cittadinanza che fugge per le campagne, dalla chiusura della
città di VE, dallisteria che porta ad appiccare fuochi agli angoli delle
strade e impiccare
individui sospetti di propagare il male intenzionalmente e non.
☻ De Pestilentia
Patavina Anno MDLV, di Ludovico Pasini medico docente allUniversità di PD.
Tratta della causalità della peste, delle forme di contagio, di misure
preventive. Anche lui sostiene la teoria miasmica,
unita a quella contagiosa, propendendo però per questa. Negava quella della
causalità astrologica, sottolineando che a PD non vi era stata alcuna
congiunzione planetaria che avesse potuto giustificare lepidemia del 1555. Il
testo manca di informazioni storiche.
- De pestis pestiferarum omnium affectum causis signis, precautione & curatione libri IV; Apologia pro Galeno tum in logica tum in philosophia tum etiam in medicina libri III.
☻ De coene et prandij portione libri II, di Oddo degli Oddi (1478-1558); dopo
aver insegnato lettere classiche a PD si laureava in medicina. Fra i massimi
esponenti del galenismo fu soprannominato lanima di Galeno; nel De Pestis
considerava la peste come una corruzione dellaria provocata da cause
ambientali, mentre il contagio poteva contribuire alla sua diffusione. La
preservazione e la cura si concentravano sulla purificazione degli umori
attraverso purghe e salassi e una dieta adeguata.
☻ Il successo della peste occorsa a
Padova lanno MDLXXVI- VE- Appresso Paolo Magiatti 1576 di Alessandro Canobbio.
Niccolò Ornameto suo concittadino
divenuto vescovo di Padova
nel 1570 lo chiamò come segretario della città e nel 1576 in occasione della peste la descrive rendendo
il testo suggestivo in quanto non si limita a riportare gli eventi, ma propone
personali interpretazioni sulle cause e natura della pestilenza e al termine
del trattato fornisce indicazioni profilattiche e terapeutiche.
☻ De Pestilentia Hieronymum Mercurialis Foro Iuvensis Medici Praeclarissimi Letiones Habitae Patavi 1577 Mense Ianuarii Quibus De Peste Universum Praesertim
Vero De Veneta et Patavina Singulari Quidam Eruditionem Tractatur di
Girolamo Mercuriale. Venetia a Paulum
Maietum 1577.
Girolamo Mercuriale (nato a Forlì nel 1530) aveva studiato
medicina a Bologna; nel 1576 fu chiamato a Venezia, con Girolamo Capodivacca
(v. sotto, La diatriba ecc.), per consulto sulla peste che si stava
diffondendo. Ritenne
che non si trattasse di peste
in quanto la mortalità era troppo bassa e la malattia stava colpendo
principalmente i poveri e proibì le misure di isolamento messe abitualmente in atto a Venezia, con
leffetto di far progredire lepidemia che alla fine uccise 50mila veneziani. Tornato
a PD scrisse De pestilentia
con cui tentava di discolparsi scrivendo che la malattia era divenuta
peste vera e propria solo a partire dal luglio 1576 dopo il suo
intervento.
☻ Elegia De Horribili
Patavini Civitatis Pestilentia
MDLXXVI - Patavi 1557 di Olivierus
Tolenellus: letterato, il poema ha lo scopo di
mostrare le miserie della terribile pestilenza del 1576 per suscitare un senso
di pietà religiosa e il desiderio di redenzione. La peste è considerata come
segno dellira celeste di fronte alla quale larte medica nulla può.
Questi testi si trovano per la maggior parte presso
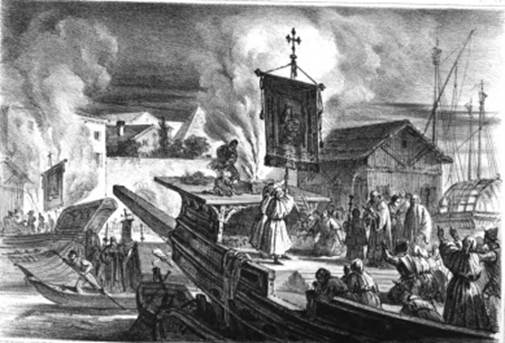
Trasporto a Venezia di
appestati e sospetti al Lazzaretto
E
PADOVANI E
VENEZIANI
|
A |
Venezia
la peste era giunta da Trento (il 25.VI.1575), portata dal mercante Vincenzo de Franceschi, dove costui si era recato
per acquistare della mercanzia; egli abitava nella contrada san Marziale con la
moglie, figli e fantesche; nel frattempo aveva venduto la merce acquistata e
dopo sette giorni dal suo arrivo, moriva, senza che si sospettasse che fosse morto di peste; solo dopo
la morte di tre donne intervennero i procuratori della Sanità che trasferirono le
due donne rimaste vive ritenute infette, con roba e masserizie, trasportandole
di notte al lazzaretto dove roba e masserizie furono bruciate.
Lintervento,
pur tempestivo, dei procuratori che avevano disposto la separazione delle
persone sane dalle malate, avevano proibito ai venditori ambulanti di vendere la
loro merce per le strade e avevano disposto luccisione di tutti i cani e gatti
affinché non andassero da un luogo a un altro seminando il morbo, non impedì il
suo propagarsi.
Il Senato
provvedeva a chiamare due medici dell'Università di Padova, Girolamo Mercuriale
da Forlì e Girolamo Capodivacca, i quali pur pronunziandosi per la gravità del
morbo, lo ritennero privo di ogni infezione; al contrario i medici veneziani
sostenevano che il morbo si trasmetteva, come dimostrato dal de Franceschi,
che essendosi infettato a Trento, l'aveva
trasmessa nella propria contrada, per passare poco a poco, alle altre;
inoltre negli infermi si erano riscontrati gli stessi segni, febbre acuta, vale a dire ardore, vigilie (insonnia), sete, frenesia, pustole, lividore e
altri indizi di pestilenza; e gli stessi sintomi si erano osservati nei
cadaveri; quindi occorreva togliere gli infermi con i loro assistenti, dalla
vicinanza con i sani.
Concludevano
i veneziani non esservi altri rimedi che quelli opportuni contro la peste e ove
non si fossero usati, il mortifero veleno avrebbe in pochi giorni rapito grandissima massa di
gente.
I due
Girolami invece, sostenevano che avendo il male già fatto immensa strage nella
più minuta e trascurata plebe, verosimilmente non si sarebbe sparsa
ulteriormente e non avrebbe contaminato la città: si ponessero quindi dei limiti alle case povere e abiette, alle
taverne, a coloro che travagliati dai bisogni non avevano con che ripararsi,
lasciando libere le abitazioni ampie ed aperte e risparmiando i cittadini e i
patrizi.
I due
medici padovani si dichiararono anche disposti a visitare gli ammalati, senza paventare
di correre rischi per la loro vita che era a loro cara e che avrebbero, con la
loro esperienza, usato gli opportuni mezzi per la guarigione degli infermi.
In
questa discrepanza di opinioni in Senato si erano formate due correnti: una sosteneva
a bocca baciata (senza difficoltà) i
medici padovani, i quali ritenevano che era inutile
suscitare allarmi di terrore in ogni ordine di persone e allontanando dalla
città i forestieri e i trafficanti sarebbero derivati danni alla circolazione
del danaro e una diminuzione di introiti di gabelle, dando ai nemici della
repubblica un incentivo per procurare noiose novità.
Laltra
sosteneva, dei medici veneziani che se si fosse temporeggiato e tirato innanzi,
sarebbero aumentate le disgrazie che già si provavano e che si volevano
evitare; ma prevaleva lautorità dei professori di Padova i quali chiedevano
che a tutti fosse permesso di circolare liberamente; che non venisse vietata la
libertà dei cittadini e per rimuovere dallanimo della impaurita plebe ogni
timore, ritirare le barche che erano state imbiancate per trasportare dalla
città i cadaveri con i loro indumenti.
Aspre e perigliose sembravano tali misure, tuttavia in Senato era
prevalsa tale sciocca opinione dei medici padovani; fatto il decreto, se ne rallegrava tutta la città e linfelice e
ingannato popolo che senza saperlo stava già sullorlo di un più profondo e spaventoso
abisso (*).
Intanto
a Mercuriale e Capodivacca erano stati affiancati quattro medicastri veneziani vili e
svergognati cortigiani, i quali ad onta di qualsiasi evidenza li
sostenevano e due sacerdoti gesuiti incaricati di somministrare ai moribondi
gli estremi soccorsi religiosi.
I DUE MEDICI
PADOVANI
SONO
LICENZIATI
|
T |
utti
si accorsero che la forza del male si avviava al peggio e si diffondeva anche
in quelle parti della città che non erano mai state contaminate; per di più uno dei chirurghi padovani moriva
e moriva anche uno dei due sacerdoti gesuiti.
Cessata
quindi la causa della diatriba in quanto con queste evidenze i due medici
Mercuriale e Capodivacca non avevano più nulla da opporre, dopo aver dichiarato di mettere a disposizione della repubblica il loro
ardente zelo e offerto alla facoltà la loro vita, furono licenziati, non
senza che vi fosse stato chi avesse voluto fossero processati coloro che
avevano suggerito fossero chiamati per la loro conclamata celebrità.
Mercuriale
(v. bibliografia sopra), tornato a PD scrisse De pestilentia con cui tentava di
discolparsi scrivendo che la malattia era divenuta peste vera e propria solo a
partire dal luglio 1576 dopo il suo intervento.
Il Senato
quindi decretava: Che in ognuno dei sei
sestieri in cui la città era divisa, fossero elette tre persone, tra quelle che
avevano cura del proprio sestiere e altre tre fra le settantadue parrocchie esistenti,
una patrizia, una cittadina e una plebea,
per provvedere ai bisogni degli infermi, che vigilassero che non fossero
portati all'esterno e a non far uscire di casa coloro che fissero sospettati di
essere malati, riferendo a quelli che sovrintendevano al sestiere e costoro ai
procuratori alla Sanità
Decretava
inoltre, con minaccia di finire sulle galee, di tortura, di multe,
in prigione, alla gogna o frusta o di morte, che nessuno potesse portare in
giro alcunché; che i fornai non dovessero entrare nelle case per la consegna
del pane, ma stando sulla porta della strada; che i guardiani alla sanità dovessero
vigilare le case affidate alla loro sorveglianza e da esse non
dovessero allontanarsi se non dopo l'arrivo del loro sostituto; le scuole per ragazzi e ragazze erano
sospese; che nessuno potesse andare in giro per vendere cenci, ferro e canapi
vecchi; che non fossero buttate le immondizie in strada e ognuno dovesse tener
pulita la parte antistante alla propria casa; che prima dell'alba fossero giornalmente
purificati gli smaltitoi (raccoglitori del contento di padelle e pappagalli
degli ospedali) e che i facchini dei campi"
(le piazzette veneziane), dovessero mantener pulite le cisterne; che non si
facesse entrare o uscire dalla città qualsiasi cosa se non attraverso i
cancelli e palafitte ordinarie; che nessuna chiesa o scuola venisse adornata da
tappezzerie diverse da quelle normalmente usate per il loro ornamento; che
nessuno potesse accostarsi o appoggiarsi alle mura di una casa infetta o sequestrata; che fosse proibita la
vendita della cattive e putrefatte grascie (alimenti); nelle bische e taverne non dovesse darsi
da mangiare, bere e giocare; che monache e frati questuanti non potessero
entrare nelle case altrui ma fermarsi al limitare della casa.
Ma tutti questi accorgimenti furono vani!
Il
doge e i padri della repubblica, vedendo che tutti gli accorgimenti e i rimedi
utilizzati erano risultati vani, non videro altra possibilità che rivolgersi
all'assistenza del Cielo; ma anche il ricorso alla fede non fece che aumentare
il numero dei morti (che furono cinquantamila v, nota*) a causa degli assembramenti
dovuti alle processioni e di coloro che deboli, fievoli e magri avevano affollato la basilica per
pregare ... e il mancato ascolto di Dio fu giustificato con il suo sdegno per i
peccati del popolo!
*) Da agosto e fino al successivo mese di febbraio (1576) vi
furono tremila seicentonovantun morti,
ma nel corso dellanno incrudelì, facendo cinquantamila morti; quando cessò il
Senato fece costruire dal Palladio alla Giudecca una chiesa dedicata al Redentore ... che lavrebbe fatta
cessare; e la festa del Redentore è magnificamente celebrata ogni anno ad
agosto; per di più si era incendiato il palazzo ducale; per fortuna non tutto
il palazzo andò distrutto, ma centinaia di capolavori andarono ugualmente
perduti.
PORTATA
DAI
LANZICHENECCHI
|
I |
l 1600
considerato il secolo pomposo e
sciagurato, alle guerre, rivolte e
rivoluzioni, si ritrovava anche con la peste (1630), preceduta per di
più dalla carestia, ambedue funeste per
Il
popolo era stato colpito dalla fame, non allimprovviso, ma per gradi: si
cominciò col chiudere le botteghe (scrive Ripamonti), da cui il popolo traeva
la sussistenza; la plebe, priva di lavoro con cui guadagnava il pane, cominciò
a stentare, quindi a languire di fame e in ultimo a morire.
La
moltitudine era divenuta mendica; sfiniti per mancanza di cibo, quei poveracci vagolavano con faccia cadaverica e poi
cadevano morti per le strade; più ne rapiva la morte, tanto più ingrossavano
quelli rimasti che ogni giorno piombavano nellultima miseria; e quasi non
bastasse la folla di mendichi, ne accorrevano dalle campagne e altri giungevano
dalle città vicine e dallestero, come ad un asilo sicuro dove non sarebbe mancato
alimento, illusi dal nome di Milano e ignorando la triste condizione in cui era
caduta la città.
Vidio (prosegue
Ripamonti) passeggiando lungo le mura, una donna con un fardelletto sul dorso e un bambino in fasce, indotta a uscire dalla
città con il bimbo e gli oggetti più cari; sopraggiunta dalla morte, cadde
estinta appena al di fuori delle porte; le usciva di bocca un pugno derba
mezzo masticato, il cui sugo verde le imbrattava le labbra, prova della
rabbiosa fame, il bambino vagiva sul cadavere della madre; alcune persone
compassionevoli raccolto il bambino se ne presero cura allontanandosi dal
cadavere; si raccontava di parecchi casi simili, alcuni più atroci per i quali
la morte era il più lieve dei mali; alcuni per mancanza di cibo e per fame,
ponevano termine alla loro vita gettandosi dallalto delle mura.
Poi
giunse la peste portata dai luridi
lanzichenecchi, che nella loro marcia (1629) disseminarono la peste, di cui
sempre uno spruzzolo rimane negli
eserciti; sulla loro via cominciarono a scoprirsi cadaveri di sozzi bubboni;
ma i focolai prima del loro arrivo erano nei Grigioni e Canton Ticino da dove erano
passati ventiduemila fanti e tremilacinquecento cavalieri.
Da
costoro, Pietro Antonio Locato, un soldato che si trovava in Valtellina, aveva
acquistato o rubato abiti dai lanzichenecchi; aveva avuto la licenza, recandosi
presso una sua zia, Elisabetta, dove né
visitato, né custodito sinfermò; era andato allHospital grande con un tumore al braccio nonché con un bubbone
sotto lascella sinistra; allospedale erano stati in tre ad averlo toccato.
Il 3
agosto erano morti di peste due di Comino a tre miglia dalla città, il male raggiunse
Milano e si diffuse nel borgo degli Ortolani; in questanno si celebrava a
Milano il Giubileo voluto da Carlo Borromeo e concesso dal papa (Gregorio III),
che aveva richiamato schiere di popolo e non è da meravigliarsi (prosegue
Ripamonti) che alcuni, provenendo da zone infette, portarono la peste.
Mentre
il Tribunale della Sanità prendeva gli opportuni provvedimenti per non farla
diffondere (memori della precedente del 1524) furono alzate colonne con le
croci ai quadrivi per invocare la clemenza di Dio e si pensò al Chiodo che si trovava nel Duomo (ritenuto
infisso nel corpo del Redentore quando fu crocifisso!), posto in una croce,
portata dallarcivescovo Carlo Borromeo (1538-1584) in processione.
I
magistrati del Tribunale erano contrari per timore che la peste si dilatasse,
ma per le insistenze dellarcivescovo, spinto eccessivo da zelo, di processioni
ne fece tre (3, 5, 6 ottobre) andando a visitare le chiese di sanAmbrogio, san
Lorenzo e san Carlo, portando il santissimo
Chiodo, con grande partecipazione di
popolo e clero la peste con funi al
collo e piedi nudi.
La
peste non si fermò e raggiunse il pavese, il lodigiano, e altri luoghi e
nellanno seguente aveva raggiunto picchi altissimi incrementata da processioni
e i raduni nelle chiese ce nessun santo avrebbe potuto fermare.
Larcivescovo
Carlo, santificato per la sua carità cristiana, piuttosto che per aver fermato
la peste, era dedito allassistenza ai poveri (per precauzione andava in
giro in una portantina di vetro), che circolavano quasi ignudi per mancanza di
indumenti; poiché stava per arrivare il freddo, per non farli patire, spogliò
tutto il guardaroba e tutto il palazzo dei drappi, mettendoli in vendita, o
fece tagliare le tappezzerie, i drappi, gli arazzi dellarcivescovato e li fece
fare in diverse forme, con il cappuccio che sostituiva il cappello; erano state
utilizzato anche ottocento braccia di panno rosso e settecento di pavonazzo (il
viola mammola ecclesiastico), oltre ai drappi verdi e di altri colori; il
risultato fu che si videro in giro e nel lazzaretto i plebei abbigliati sfarzosamente di seta, di porpora e di altre stoffe
preziose come se fossero stati soldati di un esercito con diverse livree e
insegne.
*) Stranamente la peste che aveva circondato tutta la città di
Treviso, aveva lasciato la città indenne; anche Ferrara si preservò in linea di
massima avendo avuto solo qualche caso; la città di Faenza si mantenne indenne
e bloccò la peste proveniente da Bbologna, altrimenti
si sarebbe estesa per tutta
Le città di Napoli (dove era giunta dalla Sardegna) da dove
passando per Civitavecchia e Nettuno raggiunse di Roma e Genova, furono colpite
negli anni successivi (1656).
Questo passo di Manzoni
su Cecilia,
il più bello dei Promessi Sposi,
gli studenti dovrebbero riportarlo
sul proprio smart e impararlo
a memoria per perfezionare la loro scrittura.
|
S |
cendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il
convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non
trascorsa e vi traspariva una bellezza
velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor
mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestoso, che brilla nel sangue lombardo.
La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno daverne sparse tante;
cera in quel dolore un non so che di pacato e di profondo. che attestava
unanima tutta consapevole e presente a sentirlo.
Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la
indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento
ormai stracco e ammortito ne cuori.
Portava essa in collo una bambina di forse novanni,
morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito
bianchissimo, come se quelle mani lavessero adornata per una festa promessa da
tanto tempo, e data per premio. Nè la teneva a giacere,
ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se
fosse stata viva: se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da
una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull omero della
madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, chè,
se anche la somiglianza de volti non avesse fatto fede, Iavrebbe detto
chiaramente quello de due eh esprimeva ancora un sentimento.
Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con
una specie però d insolito rispetto, con unesitazione involontaria. Ma
quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno nè
disprezzo, « no! « disse: non
me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete e così dicendo, aprì una mano, fece vedere
una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: promettetemi
di non 1evarIe un filo d intorno, nè di lasciar che
altri ardisca di farlo, e di metterla sotto terra
così.
Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e
quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che
per linaspettata ricompensa, saffaccendò a far un po di posto sui carro per la morticina.
La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise li come sur
un letto, ce I accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse I ultime
parole: addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar
sempre insieme. Prega intanto per noi; ch io pregherò per te e per gli altri.
Poi voltatasi di nuovo al monatto, voi,
disse, passando di qui verso sera,
salirete a prendere anche me. e non me sola.
Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, saffacciò alla
finestra, tenendo in collo unaltra bambina più piccola, viva, ma coi segni
della morte in volto.
Stette a contemplare quelle cosi indegne esequie della prima,
finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve.
E che altro potè fare, se non posar sul
letto lunica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? come il
fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia,
al passar della falce che pareggia tutte Ierbe del prato.
IL TUMULTO DI SAN MARTINO
DURANTE
|
N |
el
periodo di carestia che aveva preceduto la peste (1628) a Milano, il Municipio
e il Governo avevano utilizzato il Lazzaretto, (costruito per la peste dal
Bramante), per raccogliere tutti i poveri che si trovavano in città, quelli
venuti dalle campagne e quanti vagavano e giacevano per le strade ignudi e
famelici, e scordando le proprie ristrettezze provvidero ai loro bisogni.
Di
costoro in città se ne contarono 3. 534, con quelli giunti dalle campagne e
città vicine raggiunsero il numero di 9.715 (ma vi fu chi riteneva che il loro
numero fosse 14.000), furono alimentati di pane con dentro il riso; ma si
scoprì che i fornai, per guadagnare, lo adulteravano con sostanze nocive;
inoltre lacqua da bere era corrotta, la paglia dei locali era fetida
(ricordiamo che allepoca vi era ancora luso medievale dei pavimenti
sostituiti da paglia o fogliame) e non cambiata mai; il caldo eccessivo di
quellestate (1529) durante la quale non era piovuto per tre messi,
svilupparono le febbri nel Lazzaretto con un puzzo insopportabile che aveva
fatto svenire il senatore Arconato che si era recato
in visita e questa sospesa e il senatore portato via.
A
causa della scarsezza di frumento, il giorno di san Martino si ebbe un tumulto;
nel passato ciò era avvenuto di rado perché lagro milanese forniva grano in
gran quantità, non solo a popolazioni vicine ma anche alle lontane; il tumulto
era stato causato dalle misure adottate per calmierare il prezzo del grano.
Governatore
era Consalvo da Cordova, il Gran capitano, assente per essere occupato
allassedio di Casale, sostituito dal Gran Cancelliere Antonio Ferrer che era
stato la causa del tumulto.
Il
Ferrer infatti, a causa della penuria di grano, aveva adottato un provvedimento che era servito
solo a protrarre il tumulto, in quanto i mercanti del frumento e i fornai, che occorreva tener buoni, minacciavano di
sospendere la vendita del grano e del pane; il prezzo minimo del grano andava
dalle quaranta alle cinquanta lire; ma i ricchi incettatori e gli usurai e gli stessi possidenti, in segreto, avevano
fissato il prezzo in maniera esorbitante, fino a cento lire al moggio, e non
ancora contenti chiusero il grano nei granai, ignorando le grida che richiedevano che ognuno dichiarasse di quanto grano
disponesse.
Il Gran
Cancelliere aveva pensato a una via di mezzo e far sopportare ai fornai una
parte dellaumento del prezzo e aveva stabilito che il pane fosse venduto al
prezzo fissato per il grano, di trentatre lire al moggio, prezzo valevole sia
per i venditori che per i compratori.
Ferrer
riteneva che questo prezzo andasse a compensare i precedenti guadagni dei
fornai e quanto avrebbero guadagnato in seguito (probabilmente li aveva
lusingati promettendo di compensarli in seguito, a spese dellerario!).
Ma i
fornai se ne lamentarono, minacciando di chiudere i forni, ma il Cancelliere
emise ugualmente il decreto; il popolo, atteso il buon prezzo del pane, si era
recato in massa ai forni, tanto da mettere i fornai in condizione di non poter
soddisfare tutti.
Le
continue lamentele portarono Consalvo a nominare un presidente del Senato, due
magistrati e due questori che rifissarono il prezzo del grano, aumentandolo di
dieci soldi il moggio e questo scatenò la rabbia e il furore del popolo in
quanto questo aumento accontentava i fornai, ma non la plebe che si aspettava
un ribasso del prezzo invece dellaumento.
La mattina del giorno di san Martino,
allalba, quando i garzoni dei fornai uscivano con gerle e canestri pieni di
pane per portarlo ai monasteri e alle case dei signori e per venderlo altrove
al minuto, gruppi di ragazzi, giovani, donne e vecchi, spinti dalla fame
assaltarono i garzoni, prendendo il pane che trasportavano: fu così che ebbe
inizio la rivolta.
La
moltitudine si era armata di bastoni, sassi e quanto capitava nelle loro mani;
furono scassinate porte, dandovi fuoco; si fece man bassa di farina e grano,
spargendone per terra e gettandoli per strada per disprezzo; altri riempivano i
sacchi rubati, di farina e li portavano via; altri arrivavano con carri e
tornavano più volte senza che nessuno li potesse fermare; le contrade da dove
andavano e venivano i saccheggiatori erano bianche di farina come se fosse
nevicato, preda dei poveri e dellinfima plebe che si affaccendava a
raccoglierla.
I
caporioni avendo trovato dai fornai danaro di molti giorni di incassi, lo
rubarono; sfogata così la rabbia e non restando altro da rubare, sfogarono il
loro furore prendendo tavole, canestri e utensili, facendone un mucchio al
quale diedero fuoco e vi avrebbero buttato dentro anche i fornai e i garzoni se
questi non si fossero salvati fuggendo a tempo.
Il
capitano di giustizia fu colto da una sassata mentre fuggiva e andò a
rifugiarsi in una casa andando a nascondersi in una soffitta dove rimase finché
la folla non fu dispersa.
Il
merito andava al Gran Cancelliere Ferrer, venerabile per vecchiaia, che si era
guadagnato la simpatia del popolo perché non temeva di esporsi in mezzo a quel parapiglia;
nella carrozza che avanzava tra la folla (Ricordate quello che nel romanzo,
diceva al cocchiere? adelante Pedro, con
judicio), con la mano chiedeva silenzio,
supplicando che lo ascoltassero, ora alzando le spalle, ora piegando la testa,
mentre interrogava che cosa volessero e quando; cessato il fracasso, poteva
farsi sentire, mettendosi la mano al petto, prometteva pane in quantità,
sedando con la sua dolcezza il tumulto; ma più gli riuscì di dire ciò che il
popolo desiderava sentirsi dire: Che veniva per condurre il vicario al castello
dove, se fosse stato colpevole di
qualche ingiustizia nei confronti del popolo, sarebbe stato punito; e così con
questa promessa, riuscì a salvare il vicario
da morte sicura.
Ma la casa del vicario era stata maltrattata, avendole non solo fracassate le invetriate sotto
la porta et scrostata tutta la muraglia, ma mostrato risolutione
di ammazzare e bruciare: e se tantino tardava il soccorso del castello, era
fatto becco allocha.
I MONATTI E GLI UNTORI
DURANTE
|
P |
er non
fare propagare la peste, oltre alla chiusura delle porte cittadine, per
impedire lingresso ai forestieri, ai cittadini fu imposta la quarantena, con lobbligo di rimanere
nelle case e quando in alcuna di esse si manifestava qualche sintomo del morbo, si provvedeva allo
spurgo di tutte le suppellettili e di tutti gli oggetti di cui il malato aveva
fatto uso.
La
casa infetta era subito contrassegnata e il cadavere portato via dai monatti; se vi erano infermi erano
portati nelle capanne costruite fuori le mura; altri monatti profumavano la casa e le pareti con storace (resina
di albero indiano), incenso, pece;
lavavano ogni parte con calce e ranno (pasta di acqua bollita con la
cenere) e inoltre mescolando due libbre
di incenso e una di pece li gettavano sul fuoco in modo che il salutifero
vapore si spargeva per tutta la casa!
A
questi incombenti provvedevano, come detto, i monatti (così chiamati a Milano ma altrove erano beccamorti); seppur già attivi nelle
precedenti pestilenze, erano forniti di regolare licenza e indossavano un
camiciotto di tela incerata e indumenti stravaganti, con appesi dei campanelli
che avvertivano del loro arrivo; erano muniti di una lunga picca che serviva
per prestar soccorso mantenendo la distanza.
Sono
stati descritti come gente di poca o
nessuna carità, dallaspetto ripugnante, con facce orribili e voci spaventevoli;
dediti a ruberie; i morti venivano loro consegnati se non ignudi, quasi, e
certamente senza superfluità di cui si sarebbero serviti come spoglie per
appestar altre persone; invadevano le
case e trasportavano quanto vi si trovava; violentavano le figlie e le consorti
sotto gli occhi del padre o marito agonizzante, e strapazzi di donne morte; estorcevano denaro con la minaccia di
portare i figli o le spose, benché sani,
al Lazzaretto; non era raro vederli mangiare seduti sui mucchi di cadaveri che
erano sulle carrette; una grida del 1576 emessa a Milano, vietava alle persone,
specialmente alle donne e fanciulli, di avvicinarli quando li incontravano in
carretta o altrimenti, sotto pena di tre
squassi di corda.
● ●
●
Passiamo
ora agli untori, argomento che abbiamo riservato per ultimo perché strettamente legato allo squallido processo che ne era conseguito
con la truce e raccapricciante sentenza che aveva condannato, nel modo più atroce immaginabile,
degli innocenti, già sottoposti a crudele e ripetuta (non consntita!)
tortura, ad essere ulteriormente torturati prima di essere definitivamente
giustiziati; i condannati (indicati in Osservazioni
sulla Tortura di Verri) erano, con una prima sentenza, Gian-Stefano Baruello; e con successiva sentenza, Giangiacomo Mora, Guglielmo
Piazza, Gerolamo Migliavacca (Foresé), Francesco
Manzone e Caterina Rozzana, condotti su un carro,
strada facendo: attanagliati in più
parti, tagliata la mano (con cui avevano unto i muri), rotte le ossa delle
braccia e delle gambe, si intralciarono (furono avviluppati) vivi sulle ruote e lasciati agonizzanti
per sei ore, al termine delle quali furono (finalmente!) - dai carnefici scannati, poi bruciati e
infine le ceneri gettate nel fiume;
la sentenza aveva inoltre previsto la demolizione della casa di Giangiacomo
Mora, perché, a ricordo, sul posto fosse messa la Colonna Infame!
Questa
sentenza aveva fatto rivoltare la coscienza del Manzoni (ma anche la nostra!) che
aveva scritto la Storia della Colonna
infame (leggetela, si può scaricare
da Google libri, messa a disposizione non da una Biblioteca italiana, come sarebbe
stato logico .... trattandosi di unopera di autore italiano - come fanno i
francesi per tutte le opere dei loro autori - ma dalla Biblioteca dei Gesuiti
di Chantilly!!!), da cui poi era scaturito il celebre romanzo.
Manzoni
in riferimento alla tortura, cita il testo di Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura (il testo si
trova in aggiunta allindicata Storia della
Colonna infame e si trova anche in Google
libri ... messo a disposizione della Biblioteca Palatina di Vienna!); Verri
nel suo testo descrive anche minutamente il processo agli untori, con gli
interrogatori di quei poveracci sottoposti a tortura!
Ciò
che fa fremere di indignazione è che nonostante levidenza non solo delle prove
(il ranno fatto esaminare dalle lavandaie!) ma le confessioni che imputati e
testi fecero per le insopportabili torture subite, i giudici avevano mirato
deliberatamente alla condanna e
purtroppo storici come lo stesso Ripamonti, il veneto Batista Nani, il Muratori
e Pietro Giannone e perfino Benedetto Croce, avevano creduto agli untori inumani carnefici e Pietro Giannone
(accusato non solo da Manzoni ma anche da Voltaire, che secondo comincia
facendogli un elogio, per poi criticarlo, di aver copiato intere pagine della
sua storia dal poco conosciuto Antonio Domenico Parrino, senza citarlo!).
Questo
caso di mala giustizia che sembrava
dover rimanere unico nella storia, non lo è stato in quanto ne abbiamo avuto un
altro,nei tempi attuali, che lo pareggia; è il processo contro Enzo Tortora assolutamente
innocente e condannato nella prima sentenza, con la consolazione di una
successiva sentenza di assoluzione ma, il povero Tortora non si era potuto consolare,
perché nel frattempo (1988), era morto di cancro che gli era scoppiato quando
lo avevano arrestato e tenuto in carcere, perché considerato pericoloso
spacciatore di droga, nellattesa del giudizio!
DEL 1665
NEL RACCONTO
DI DANIEL DE FOE
|
N |
el 1722
vedeva la luce il libro A Journal of the Plague Year (Giornale
dell'annata della peste) di Daniel De Foe (1659-1731), pseudo-documentario come era nello stile dello scrittore (autore del
Robinson Crusoe); il libro aveva il
seguente sottotitolo-sommario, secondo l'uso del tempo: contenente osservazioni o testimonianze sugli avvenimenti più notevoli,
pubblici e privati, che ebbero luogo a Londra durante l'ultima grande epidemia
del 1665, scritto da un cittadino che
visse durante tutto quel tempo in Londra e finora inedito.
Daniel
De Foe, non era uno scrittore che cercasse limmortalità, ma lo faceva per sete
di guadagno; tra laltro era dotato di fiuto
mercantile e quindi aveva una qual certa sensibilità per gli argomenti che
potessero solleticare il pubblico e gli permettessero di guadagnare dalla
vendita dei suoi libri.
Loccasione
della peste diffusa in tutta Europa gli parve un soggetto che poteva rispondere
al suo scopo, e a Londra vi erano ancora superstiti anziani che erano vissuti
durante quella pestilenza di circa cinquantanni prima, mentre a quei tempi il
piccolo De Foe poteva avere cinque o sei anni.
Egli
scrisse il libro seguendo il suo sistema delle false memorie, basandosi su
testimonianze verbali raccolte da vecchi vissuti in quel periodo e ricercando documenti
dellepoca negli archivi cittadini e usando il suo talento di scrittore.
Peraltro,
il libro era in aperto contrasto con la letteratura galante del tempo, senza
romanticismi né propensioni allorrido, ebbe un grande successo; esso si presenta
come un lavoro giornalistico, in cui un sellaio racconta il flagello che si
abbatté sulla capitale inglese; il racconto, preso da documenti di prima mano dà
limpressione di essere stato scritto proprio nel periodo della peste o poco
dopo.
Purtroppo del libro non vi è
traduzione francese, sebbene i francesi, che hanno sempre avuto laccortezza di
tradurre i libri inglesi, questo di De Foe, non si sa perché, se lo sono
lasciato sfuggire, togliendoci il gusto di quella lettura!
FINE