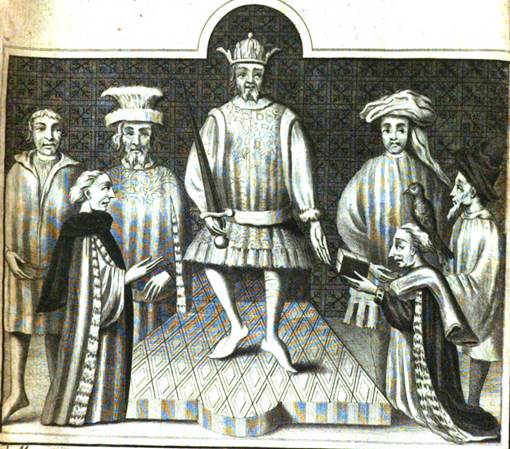
Minucci
porge il suo libro all’imperatore Sigismondo

Frontespizio
del De Feudis di Minucci
FEUDI
FEUDALITA’
E LIBRI
DEI FEUDI
MICHELE E.
PUGLIA
SOMMARIO:
FEUDI E FEUDALITA’; VERSO LA FORMAZIONE DEI “LIBRI FEUDORUM”; SFATATA LA
LEGGENDA DEI LIBRI MANDATI DAL
BARBAROSSA A BOLOGNA; L’IMPERATTORE SIGISMONDO INCARICA MINUCCI DEL RIORDINO DELLA
MATERIA; L’ALZATA DI SCUDI DEI COLLEGHI INVIDIOSI; SAVIGNY CRITICA IL TESTO DI
MINUCCI E NON RISPARMIA BARTOLO; MACCIONI MÉNTORE DI
MINUCCI SULLE TRACCE DEL “DE FEUDIS”;
CHI ERANO GLI AUTORI DEL LIBRI DEI FEUDI LOMBARDI; I LIBRI DEI FEUDI
LOMBARDI SONO ACCOLTI IN TUTTI I REGNI; I GIURECONSULTI DI NAPOLI ACCOLGONO I
LIBRI FEUDALI E SUPERANO I COLLEGHI DEGLI ALTRI REGNI; LA SISTEMAZIONE DEI
LIBRI FEUDALI DA PARTE DI CUJACIO E LA POSIZIONE DEL “DE FEUDIS” DI MINUCCI; LA NUOVA IMPOSTAZIONE DEI LIBRI FEUDALI DI CUJACIO; PREMESSA SULLA CAOTICA SITUAZIONE DEL PAPATO;
LA PARTECIPAZIONE DEL MINUCCI AI CONCILI DI PISA, COSTANZA E BASILEA.
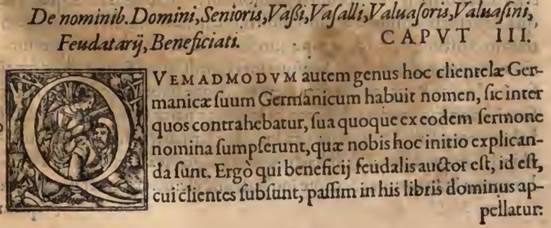
FEUDI
E
FEUDALITA’
|
L |
a
feudalità (*) di origine franco-germanica si potrebbe far risalire al diritto
romano in cui troviamo i “beneficia”
concessi ai milites
(soldati a cavallo) e ai veterani, come
stanziamenti militari per la difesa dei confini, ai quali erano annessi terreni
agricoli ad essi concessi per la loro coltivazione che ne godevano dei frutti,
con l’obbligo di rispondere alla chiamata in caso di necessità: essi erano
assegnati alla parrticolare magistratura militum in ciui erano iscritti questi beneficia era assegnata a un magistrato (Forneri & Conti, Commentatio de Feudis, Leovardiae,
1694).
Essa
era fondata su tre istituzioni: il vassallaggio
costituito dal godimento che inizialmente Carlo Magno (v. Articoli: Carlomagno
e l’idea dell’Europa), aveva concesso ai guerrieri che, a loro spese avevano
combattuto per lui ed era personale, vitalizio e inalienabile.
Il
beneficio con cui i beneficiati
divenivano legalmente vassalli del monarca e gli giuravano fedeltà,
riconoscendolo con l’omaggio proprio
signore e obbligandosi a prestare gratuitamente il servizio militare, pagare
tributi in natura o in danaro, concedergli ospitalità ed altro; successivamente
il termine beneficio. usato per i
veterani romani, fu sostituito (tra il 1025 e il 1078) da quello di feudum che equivale a “praedia civilia” fondo civile in libero possesso,
libero da servitù militari.
Occorre
tener presente che Carlo Magno con la personalità che lo contraddistingueva,
aveva ben tenuto a bada i suoi comandanti
da lui nominati duchi, marchesi e conti (non ancora vassalli o feudatari in
quanto il termine arriverà successivamente) ai quali aveva concesso parti dei territori
conquistati, per amministrarli per suo conto (v. Art, cit. e “I primi re d’Italia”) .
Tali
concessioni seppur potessero durare per tutta la vita, erano sempre nella
disponibilità del monarca, nel senso che dovevano
essere restituiti a sua semplice richiesta, ed erano quindi completamente
avulse da qualsiasi concetto di eredità, nel senso che alla morte
dell’assegnatario il territorio rientrava, senza alcuna formalità, immediatamente, nella disponibilità del
monarca.
Ciò
durò fino a quando a Carlo succedeva il debole Ludovico il Pio e anor più gli altri discendenti, che si troveranno di fronte
alle pressanti e prepotenti richieste degli assegnatari, che poco alla volta
otterranno concessioni che li porteranno ad essere più potenti dei loro re (v.
Il disfacimento dell’impero Carolingio e P. II, Gli ultimi Carolingi).
Dal beneficio, congiunto al feudo,
concessi con l‘investitura, il beneficiato diventava feudatario; con
l’investitura il feudatario godeva della immunità ossia diveniva titolare del proprio
feudo e in esso esercitava la giurisdizione che spettava al sovrano.
La
immunità era stata concessa da Carlo
il Calvo (823-877) con il Capitolare di Quiersy (v.
in Articoli: I Carolingi e la dissoluzione dell’impero), trasmissibile agli
eredi e il feudo diventava così perpetuo.
Carlo
il Calvo aveva fatto anche altre concessioni che rendevano il feudo sempre più
personale, come l’esonero del servizio militare, il diritto di battere moneta,
di imporre tasse e in questo modo il feudatario potette godere di diritti
sovrani; a questo modo, l’unico legame con il sovrano era costituito da un
vassallaggio solo nominale, che faceva del feudatario un principe autonomo.
Il
feudatario a sua volta concedeva benefici ai suoi fedeli, che invece legava a
sé, con l’obbligo di servirlo come soldati
a cavallo quando se ne fosse presentata la necessità, con altri obblighi:
costoro divenivano così vassalli (il
termine derivava dal celtico Gwas che denotava il ministro), del feudatario, vale a dire valvassori che a loro volta legavano a
sé, con gli stessi criteri, i valvassini.
Il
feudo poco a poco perse la sua principale funzione
voluta da Carlo Magno, che era quella di tenere legato il feudatario al sovrano
e con le autonomie concesse dai
sovrani alle piccole formazioni cittadine denominate Comuni, il feudo andò
verso il disfacimento, e, con il disfacimento dei feudi, sorsero i Comuni (v.
Articoli: Formazione dei Comuni e lotte con l’Impero).
Ai
capitolari e al diritto cnsuetudinario, seguì la
legiferazione delle diverse popolazioni europee (Longobardi,Burgundi, Bavari, Franchi, Angli, Goti) primo fra questi (in Italia), lo jus longobardicus, con la
redazione attribuita (ma contestata, come si vedrà più avanti) a Gerardo Nigro
e Odofredo de Orto, consoli mediolanensi
dell’imperatore Federico I Barbarossa (1125-1190).
Seguiva
il jus feudale francorum e jus germanicum antiquus (formato dai capitolari carolingi) e
successivamente (intorno al 1208) al jus Suervicum, Alemannicum e Francicum compilato da Bertoldo conte di Grimmestein, seguito dalla raccolta dell’anonimo feudista (v. sotto), seguita da quella disposta da Federico
II (1194-1250), aggiunta alle Novelle di Giustiniano (come scrive Schilter, Institutiones jus feudale, Lipsiae 1728)
accoppiandolo all’allodio, che, in senso stretto, designava il patrimonio
indisponibile della famiglia che poteva diventare proprietà individuale, quindi
“feudo”, in senso lato, come bene concesso in cambio della “fidelitas”.
*) Il feudalesimo si può definire come quel particolare
fenomeno di carattere economico,
politico e militare che aveva avuto inizio con il capitolare di Qiersy (877) in base al quale Carlo il Calvo concedeva ai vassalli l’immunità con cui i feudi maggiori divenivano
ereditari. Esso andò sviluppandosi con il disfacimento dell’Impero che si
frantumò completamente settant’anni dopo la morte di Carlomagno (814) con la deposizione alla dieta di Tribur (887) di
Carlo il Grosso (v Art. I carolingi e la dissoluzione dell’impero). Da
questo disfacimento
nacquero i nuovi Stati indipendenti (Germania, Francia, Provenza
e Borgogna, Italia, Spagna).
VERSO
LA FORMAZIONE
DEI LIBRI
FEUDORUM
|
I |
l primo accenno a un istituto
feudale, fu scritto da Filiberto, Vescovo di Cbartres all’inizio dell’ XI sec. sulla “Forma della fedeltà” ( documento di cui da lungo tempo si sono perse le
tracce).
Quando Oberto dall’ Orto e Gherardo Negro (XIII sec.), Consoli in Milano, compilarono (1216) il Liber Consuetudines
Mediolani vi inserirono quattro capitoli di
consuetudini feudali, che, comprendendo il solo diritto longobardo, avevano vigore soltanto
all’interno della Lombardia che affiancavano quelli del Gius
feudale dei Franchi e il Gius Alamannico.
Si ritiene
che questo testo accresciuto delle “Consuetudini”, con altre, riunite nei Libri feudorum (Libri dei Feudi *), da parte di un autore ignoto denominato “Feudista”, divennero il testo fondamentale
dello jus feudale.
Migliorotto Maccioni (di cui parleremo più avanti), riteneva che Oberto e
Gherardo, non fossero gli autori del testo emendato in quanto, “in alcuni casi, risultava che le loro opinioni fossero contrastanti, il
che si sarebbe ben poco conciliato con la loro paternità del testo, che invece
con maggiori probabilità era attribuita a Presbiteri (Ugo di Porta Ravennte †1178) che provvide alla sua
integrazione quando Federico I Barbarossa
ne aveva chiesto la integrazione alla Università di Bologna e Ugolino
vi aggiunse le Costituzioni di Corrado III e di Federico Barbarossa, con il titolo di “Decima Collazione” che fu aggiunta alle Novelle di Giustiniano.
Così questo Gius Longobardico versato nel Libri
feudorum, si diffuse in tutte le parti
dell’Europa, penetrato nei Fori e nelle Accademie di Germania ebbe il nome di Gius Feudale Comune.
Ma nelle mani di Bulgaro, Pileo
da Prata (XI-XII sec), Ugolino, Corradino Vincenzio, Goffredo (v. in Articoli: Il Corpus Juris ecc.: Note) ognuno di essi aveva inseritio glosse esprimendo proprie
interpretazioni e opinioni col risultato che non solo essi avevano complicato notevolmente la
materia, ma l’avevano resa eccessivamente astrusa.
Solo con
l’intervento di Colombino (anch’egli dello Studio di Bologna), con il
suo prestigio (come riferiva Giasone del Maino), si mise un freno mise un freno
all’imbarbarimento della materia e nessuno più osò aggiungere ai Libri dei
Feudi ulteriori glosse.
Dopo
la metà XIIImo sec., Jacopo di Ardizzone fece delle aggiunte alla
Glossa e aggiunse ai Libri Feudali una compilazione di cose giudicate (sentenze) che risultarono molto apprezzate dagli
studiosi.
Ma con
il sistema delle integrazioni si giunse, agli inizi del XVmo
sec., come era stato scritto, “fatta da persone non molto capaci” l’intero testo risultava poco
soddisfacente per la funzione che doveva svolgere e su di esso si erano levate
molte lamentele sulla pessima qualità e la poca fedeltà delle stesse parole
delle Costituzioni imperiali, ivi riportate.
A
questo punto la materia era così degradata che occorreva correre ai ripari,
tanto che Molineo (Charles Dumoulin
1500-1566) in seguito commenterà che: “in
ordine alla materia erano state inserite bestialità che creavano conflitti ed
erano state accumulate buone e cattive consuetudini e Oberto e Gerardo (ai
quali se ne attribuiva la responsabilità) erano due pecore” ( **).
Si
era giunti a questo punto, quando l’imperatore Sigismondo incaricava Minucci di riformare la
materia.
*) In questi
Libri dei Feudi fatti aggiornare da Federico II, non erano comprese nè le leggi feudali normanne nè
quelle di Federico II riversate nelle Costituzioni di Melfi (1231).
**)
Inventi... qui ordinem materiarum
in ius observatum, vel neglectum potius, carperent, imò quaedam bestialiter ibi conflituta , bonas, & malas consuetudines suissè cumulatas, Obertumque, & Gerardum fuisse duo pecora (in Schilter).
SFATATA
LA
LEGGENDA
DEI
LIBRI MANDATI
A BOLOGNA DAL
BARBAROSSA
|
P |
ietro
Giannone nella sua “Istoria Civile del
Regno di Napoli” aveva affrontato la materia dei Libri Feudali, con una completa esegesi in cui aveva distinto, i
testi che trattavano la materia in via generale (c.d lombardi), commentati dalla folla dei glossatori (alcuni noti, ma
molti altri sconosciuti), che avevano finito per rendere la materia astrusa e
incomprensibile; per di più, in essi era stato usato un linguaggio barbaro (come sarà definito da A. Pilati), che possiamo
considerare i precursori degli odierni burocrati; per questo motivo li
indicheremo... a memoria dei testi che erano stati utilizzati nel Regno di
Napoli, che lo storico riteneva
differenti dagli altri .
Su
queste Consuetudini dei regni di Sicilia e di Puglia, Giannone
insiste considerandole diverse dalle lombarde, in quanto egli sostiene, gli
abitanti avevano costumi differenti da quelli della Lombardia, ed erano state
denominate con termine corrotto, “Defetari” (come
riferiva Ugo Falcando in “Historia Siciliae”), con la conseguenza che in questi regni non si
avvertiva alcuna necessità di ricorrere ai libri lombardi.
Pare
che questa compilazione - precisava Giannone - si fosse resa nota ai
giureconsulti dei regni del sud dopo l’anno 1187, quando il re Guglielmo II per
la quiete dei suoi sudditi, aveva concluso le nozze della zia Costanza (tirata
fuori dal convento dove si trovava in non più giovane età! ndr.) dandola in moglie a Enrico re di Germania, per far cessare le occasioni
di discordie sugli imperatori d’Occidente.
Ma la discordia avvenne ugualmente tra i baroni in
quanto alla morte di Guglielmo, essi non
accettando Enrico come germanico, elessero loro re Tancredi, il quale ottenne
l’investitura del regno, anche da parte del romano pontefice.
I Libri
milanesi, cominciarono
ad avere vigore, secondo Giannone, nel sud dell’Italia nell’ anno 1194 quando
Enrico, dopo aver scacciati i normanni, essendo uscito vincitore, si era reso
padrone del regno acquisendo, con il matrimonio, i beni dotali della moglie Costanza
d’Altavilla.
Relativamente
a questi primi Libri Feudali,
Giannone risale proprio alla stesura di quei libri che ebbero origine in
Lombardia, (dove vigeva il jus romano-longobardico),
le cui consuetudini, egli dice, non ancora erano state raccolte in volume, alle quali erano state aggiunte le
Costituzioni di Corrado il Salico (990-1039) e di altri imperatori, fino a
quando, ai tempi di
Federico I Barbarossa, ad alcuni giureconsulti milanesi venne in mente di
raccogliere tutto il materiale tenuto così alla rinfusa.
Questi
Libri milanesi, sebbene conosciuti (come
decima collzione)
non acquistarono alcuna autorirà di legge e non
l’acquistarono nemmeno quando Federico Il, figlio di Enrico, promulgò le sue Costituzioni fatte compilare da Pier
delle Vigne; nè quando, sull’esempio delle altre città
d’Italia, avendo ristabilita in Napoli l’Università degli Studi, era stata
introdotta la lettura delle Pandette (v.
cit. Art. Il Corpus juris civilis:
L’abbaglio ecc.) e degli altri libri di Giustiniano.
Non
è infatti da considerare veritiera, precisa Giannone, la costante opinione secondo
la quale i libri della decima collazione,
con Federico I avessero acquistato forza ed autorità, e che, come detto, fossero
stati mandati allo Studio di
Bologna, aflinchè ivi, si leggessero e
si correggessero pubblicamente nelle scuole, e che ciò fosse stato fatto per
suggerimento di Ugolino, come è stato testimoniato da Odofredo
(citato da Panciroli fonte di Giannone).
Qual
bisogno, si chiede Giannone, vi fosse, mandar questi libri a Bologna, quando in
questa città essi, da
molti anni, eran conosciuti e pur letti dai bolognesi?
Anche
molto prima, prosegue Giannone, aveva scritto le sue glosse Bulgaro,
che per più anni aveva professato legge a Bologna, sin dai tempi di Federico I,
dal quale fu fatto anche prefetto di
quella città? (Panciroli).
Quando
era parimenti notissimo in tutte le altre città di Lombardia, come se vi fosse nato;
e molti scrittori d’Italia più antichi di Federico II aveano
già cominciato a commentarli con le glosse come, oltre a Bulgaro, aveva fatto Pileo ed altri indicati
da Arturo (Duck) e indicaati anche dal nostro Andrea
d’ Isernia ?
Odofredo
non aveva scritto altro, se non che Federico Il aveva mandato ai dottori
bolognesi, non già il Libro de’ Feudi,
ma le sue Costituzioni e quelle degli imperadori
d’Occidente, che seguirono quelle di Giustiniano, affinchè,
siccome Irnerio, dalle Novelle, avea inserito nel
Codice ciò che di quelle gli era parso essersi aggiunto di nuovo o corretto,
così essi potessero fare di quelle Costituzioni
aggiungendole al Codice (Corpus juris!), non già al Libro dei’ Feudi, sotto que’ titoli che pareva loro convenire;
ed essi, infatti, riuniti a S. Petronio, “da
quelle Costituzioni estrassero molte cose, che aggiunsero o adattarono alle
leggi del Codice sotto i convenienti titoli”.
L’’IMPERATORE
SIGISMONDO
INCARICA MINUCCI
DEL RIORDINO
DELLA MATERIA
|
I |
ntervenne l’imperatore Sigismondo
(1368-1437), che
dispose il riordino dei Libri feudali e l’inserimento e correzioni delle Costituzioni imperiali; per questo lavoro fu incaricato il giurista Antonio Minucci da Pratoveccbio (nel suo testo era indicato Mincuccius, tradotto Mincucci,
certamente refuso dell’editore al quale all’epoca non si potevano
addurre immediate correzioni).
Il testo portava
infatti il titolo, “Antonii Mincuccius de Pratovetere libri sex ex omni veteri
Feudorum jure nova ordinatione collecti”, ovvero “Ordinatio nova feudorum”.
Il giurista non solo provvide a riordinare
tutta la materia, dividendola in sei
parti, riportando le principali Costituzioni Imperiali (di Corrado, Lotario e Federico Barbarossa), secondo il loro ordine, le Consuetudini
e gli Usi dei Feudi, ma Minucci
adottava una nuova impostazione, eliminando tutto ciò che vi fosse di spurio, con un ordine che risultava più razionale e diverso dai precedenti testi, come riferisce Maccioni; Minucci inoltre ebbe
l’accortezza di evitare che comparissero glosse interpretative (geminazioni), “o testi contrari, nè altro che potesse
rendere imperfetto l' importante lavoro”.
Relativamente
alla parte
riguardante le disposizioni attinenti ai Feudi, la suddivise in XXVII Titoli, iniziando dalle Persone e Investiture e terminando con i Delitti
di lesa Maestà e
Giudizi Feudali (*) .
Inoltre, sotto i
vari Titoli inseriva i richiami alle “Costituzioni imperiali” riguardanti i Feudi e tutti gli Usi
e Consuetudini feudali che si riferivano alla precedente
Collezione; fu eliminato, infine, tutto ciò che potesse rendere imperfetto il mastodontico e certosino lavoro.
Avendo poi cambiato l'ordine del testo, Minucci riportava in apposita
sezione tutte le .Glosse, facendo in modo che non potessero
confondersi con il testo, come invece si era verificato in precedenza, per
altro contrassegnandole, per distinguerle dalle proprie annotazioni che aveva inserito nel testo.
Apriti cielo! Tutto questo enorme e paziente lavoro aveva creato un subbuglio nel
mondo accademico da parte dei malevoli e invidiosi colleghi da parte dei quali
vi era stata una unisona levata di scudi (come si è sempre verificato in Italia
quando si presenta qualche novità,sorgono
dieci voci contrarie, come aveva detto un manager italiano residente in
svizzera!).
*) I Titoli
erano i seguenti: Titolo I. Delle Persone e dei modi delle Investiture. II. Del modo di
acquistare i feudi. III.. Dello stesso argomento. IV. Dei sommi Imperanti, e degli altri che possono concedere
i Feudi. V. Dei modi particolari con cui si danno le Investiture. VI. Del Giuramento e delle forme della fedeltà.
VII. Delle
successioni Feudali riguardo ai Discendenti in via diretta. VIII. Delle successioni dei Discendenti in via collaterale
(Trasversali). IX. De Feudi in linea femminile. X. Della vera natura della successione feudale in genere. XI. Delle cose particolari sulle quali si costituiscono i Feudi. XII. Dei Vassalli e loro
possessi e diritti. XIII.
Dell' alienazione dei feudi. XIV. Dell' evizione Feudale. XV. Dell' ammissione dei Feudi e come questa
possa intervenire senza colpa. XVI. Delle cause e delle colpe per le quali i Feudi si perdano.
XVII. A chi si devolva il
Feudo quando il vassallo ne viene privato. XVIII. Come possa essere privato ancora della
proprietà. XIX. Dell'
agnazione del Feudo. XX. Del Giudice competente. XXI. Dell' ordine del Giudizio Feudale. XXII. Delle prove nei Giudizj Feudali, Testimoni e Giuramento. XXIII. Della necessità di conservare la pace. XXIV. Della pace reclamata col giuramento. XXV.
Delle consuetudini
per conservare la libertà ecclesiastica e del togliere quelle che la distruggano. XXVI. Della pace di
Costanza. XXVII. Dei Giudizi di lesa maestà.
L’ALZATA DI SCUDI
DEI COLLEGHI
INVIDIOSI
|
L |
’opera era stata scritta per l'Università di
Bologna e
nel Proemio Minucci, si rivolgeva ai colleghi di Giurisprudenza dell’Ateneo,
pregandoli di presentarla con i suoi scritti all'Imperatore Sigismondo,
al quale la dedicava, perchè con l’autorità imperiale
se ne potesse
fare oggetto di pubblico dibattito.
Ma vi era stata una levata di scudi da
parte di tutti i colleghi i quali non solo si scahgliarono
contro lo stesso Minucci operando una forma di “stalkimg” nei suoi confronti con tutte le
tribolazioni che gli facevano subire nell’ambiente universitario e purtroppo dalle generiche accuse non
siamo riusciti a distillare le modalità dei loro comportamenti.
Quando
Minucci aveva scritto (1481) il “Lessico”
che costituiva un vero e proprio repertorio
in cui aveva inserito tutto il
corpo civile, con tutti i commenti primari degli interpreti, come si erano
sviluppati nei secoli precedenti, lavoro del tutto nuovo che agevolava la ricerca dei riferimenti giurisprudenziali, l’opera, che per l’epoca
era originale, non solo aveva suscitato l’invidia degli insegnanti, ma un
docente dell’Università di Siena gli aveva contestato il riferimento a un
argomento trattato nelle Pandette, affermando che non esisteva in nessuna parte
del Digesto nuovo (*); il Minucci per
dimostrare di aver ragione, fece ricorso
al famoso “Codice pisano” (**) che si
trovava a Firenze, dimostrando la esattezza di ciò che aveva scritto.
L’ostinazione degli oppositori giunse fino
all’imperatore Sigismondo, che non concedeva l’autorità (in seguito concessa, come vedremo, da Federíco III) e Minucci a causa
degli interventi di questi suoi avversari, che screditavano il suo nome e la sua
professionalità, decise di lasciare
Bologna e trasferirsi a Padova (1429),
Essi sostenevano che l’opera fosse del
tutto inopportuna, perché “già l'ordine dei Libri Feudali era generalmente riconosciuto e lo attestava il fatto che essa
si era così consolidata nel corso di numerosissimi anni e tutti i dottori avevano accettato quella impostazione data ai
commenti delle glosse e alle citazioni ivi riportate, per cui un tale
capovolgimento avrebbe turbato ogni suo ordine che avrebbe finito per alterare tutta la giurisprudenza feudale”. In
effetti essi avendo fissato nellae loro menti la
precedente impostazione non volevano sottoporsi allo sforzo mentale di seguire
la nuova impostazione, peraltro più razionale!
Ciononostante a Firenze e presso altre università
l’opera ottenne ugualmente un risultato lusinghiero e numerosi consensi (1432).
Non si può negare,
in ogni caso in Minucci, una sua naturale insofferenza a fermarsi in un posto,
essendo portato a cambiare spesso sia la sede, sia la materia d’insegnamento.
Invitato a tornare a Bologna, preferì
recarsi a Siena a insegnare giurisprudenza (1432) da dove ritornò a Padova (1443)
per insegnarvi Giurisprudenza, tenuta in auge in questo periodo
dall’insegnamento di molti
maestri (***); da Padova, ritornò ancora a Bologna (1456) dove, questa volta rimase fino alla morte (****) .
Nel frattempo aveva rimaneggiato ulteriormente il suo testo numerando i titoli con
richiami ai capitoli della antica compilazione,
in modo da ovviare alle critiche che venivano continuamente mosse al suo nuovo sistema e aggingendo le
sue glosse a quelle del Colombino, avendo cura di contrassegnarle col nome
dell’autore.
Venutone a
conoscenza l’imperatore Federico
III d’Asburgo (IV come imperatore 1415-1493), succeduto a Sigismondo, richiedeva
al Minucci di
correggere e riordinare ulteriormente l’opera, per poter concedere quella autorità che le avrebbe consentito di esser letta nelle Accademie.
Minucci aveva gà
apportato delle correzioni e provvide a riordinare la glossa del Colombino e le
altre glosse, avendo l’accortezza di contrassegnare ogni parte della glossa
col nome del glossatore come già aveva fatto in precedenza, seguitando sempre a
farvi nuove aggiunte per renderla ancora più razionale e di più facile
consultazione.
Inviò quindi l’opera (avendo imoparato la lezione dai colleghi invidiosi), questa volta
direttamente a Federico III accompagnata da una “epistola” in cui faceva presente di non volere che l’opera fosse
pubblicata se prima non avesse ottenuto il suo riconoscimento, dopo l’esame e
approvazione da parte di un collegio accademico.
L’imperatore nominava il cardinale
Bessarione e Angelo Reatino perché la esaminaessro
ed esprimessero il loro parere, e l’opera ebbe finalmente l’approvazione dell’’autorità Imperiale (come riferiva Giovanni Cuspiniano in “Vita
Federici”), stampata da Schilter a Lipsia, nel
1695 (*****) in modo da poter essere letta, secondo i
desideri del Minucci, in Bologna e in altre
Università (in particolare in Germania dove ebbe ampia diffusione), come
affermato da Erm. Giovach.
de Westfalen (così riportato da Maccioni op. cit.).
Ma, neanche dopo morto Minucci doveva esser lasciato in pace!
Uno strascico di “antipatia”, così ci
è sembrato, doveva emergere oltre un secolo dopo la sua pubblicazione, per
merito di Savigny che dall’alto della sua celebrità, (che certamente non si può disconoscere...
ma questi grandi personaggi a volte sono
turbati dalle loro strane idiosincrasie) aveva considerato il lavoro di Minucci inutile
in quanto annullato dalle tavole di
Bartolo!
*)
Per “digestum vetus” si
intendeva il primo dei cinque volumi di cui era formato il digesto; gli altri
saranno trovati successivamentee e formeranno il “digestum novum”; il vetus era formasto dai libri 1-24.2;, completo, aveva
l’infortiatum 24.3-38; e il movum 39.50,
Codex 1.9; Volumen parvum; Institutiones, Tres libri del Codex e le Novelle.
**) Il Codice Pisano era quasi leggendario e la
circostanza che fosse conservato a Firenze invece che a Pisa era fondata sul
disprezzo che i pisani avevano per lo studio delle Pandette, come Benckmann aveva scritto nella “Storia delle Pandette”,
contestato dal Maccioni; Benckmann infatti sosteneva
che i pisani detestavamo le Pandette in quanto san Bernardo aveva scritto al papa Eugenio III, disprezzando la legge
romana; che i pisani le detestavano, per la stima che avevano per san Bernardo
e infine il disprezzo per le Pandette era dimostrato da alcune pessime
correzioni apportate dai pisani; Maccioni contestava queste affermazioni, dando
ragione della stima che i pisani avevano per le Pantette:
in ogni caso quel codice si trovava a Firenze!
***) Vi insegnavano Raffaello Fulgosio, sebbene da poco deceduto, era dato per suo concorrente nella materia feudale, tra gli altri giuristi Giovanni Imolense e Paolo o Angelo di Castro, Francesco Capilistio, Benedetto Sala, Bartolommeo Cepolla e Giovanni da Pratoveccbio fratello del Minucci.
****) Di Minucci non si conosce con esattezza
neanche la sua data di nascita, indicata
da Maccioni intorno al 1380; lo stesso
Maccioni non aveva saputo indicare quella di morte, escludendo in ogni caso
quella che gli era stata attribuita del 1524 in quanto a questa data, egli
aveva scritto, avrebbe raggiunto centoquarantaquattro anni; il Savigny la indica invece a poco dopo il 1468 data in cui
Minucci, con i figli che avevano commesso un omicidio, era stato bandito da Pratovetere (particolare che Maccioni evita di riportare).
*****) Un bellissimo
esemplare ne ho visto nella biblioteca di Felino Samdeo.
scrive Maccioni, che si conserva nella
nel Capitolo dei Canonici di Lucca; in questo Codice (e attualmente non
sappiamo dove questo prezioso codice sia finito) vi è una bellissma
miniatura rappresentante l’Imperatore seduto insieme al cardinale Bessarione
(evidentemente diversa dalla riproduzione che presentiamo) che ricevevano dal Minucci
il
Libro de Fendi (su Bessarione v. in Schede F.: Polemiche
Umanistiche tra platonici e Aristotelici e, La polemica umanistica sulle
differenze tra Platone e Arisotele continua)
SAVIGNY
CRITICA
IL
TESTO DI MINUCCI
E
NON RISPARMIA
BARTOLO
|
N |
el
Trattato di Storia del Diritto Romano nel Medio Evo (Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter), Friedrich Karl
von Savigny (1779-1861), nel IV volume (abbiamo
consultato l’edizione francese Histoire de
droit romaine au moyen age,
par Charles Guenoux, Paris 1839 messo a
disposizione dalla BNF.), l’illustre
storico riporta meticolosamente, tutti
i giuristi (anche minori) italiani del XIV e XV sec.: tra costoro manca il Mincuccius!
Andando
a cercarlo nell’Indice, al nome Mincuccius si rimanda a Pratovetere, e quivi, con
sorpresa senza alcuna altro riferimento, si trovano direttamente riportati i
dati biografici che lo riguardano, le città in cui aveva insegnato, insomma
tutta la biografia, frutto delle
ricerche del Savigny, c0mpreso il particolare che Mimicci era stato bandito dalla città con i suoi due figli,
che nel 1468 avevano commesso un omicidio; e a questo punto si precisa che egli
era morto poco dopo; e l’aver riportatoquesta biografica nell’indice
è già una cosa strana!
Passando
alla attività giuridica del Minucci, Savigny tende a sminuirla e riferisce:
“Hanno detto a torto, che Mincucci
si era mostrato superiore ai giureconsulti del suo tempo. La sua opera
intitolata De Feudis, libri sex, che ha avuto due edizioni è la sola che ha
conservato il nome di Mincucci fino a noi. E’ una ricomposizione sistematica del testo dei Libri Feudorum. Repertorio aureum dom ant. de Prato veteri in toto juris scripti opere coadjuvantibus
Bartolo nec non in titulus Nicolaus del Neapoli et Dyno in regulis juris libri VI cum aliis additionibus;
alla fine si legge Repertorium...super operibus Bartoli de Saxoferrato etc”.
In pratica Savigny
definiva il testo di Minucci una ricomposizione dei Libri Feudorum
inutile in qunto superato dalle tavole apprestate da
Bartolo!
Savigny
prosegue: Ques’opera ha avuto due edizioni e
Maccioni, ha scritto due opere differenti (una sul testo e una sulla biografia ndr.); e
aggiunge. “Le tavole messe in opera da Bartolo, hanno reso inutile il
repertorio di Mincucci”. Seguono indicazioni relative
al testo, consultato dal Savigny, presso la
Biblioteca di Francoforte.
Alla
fin fine .... il lapidario giudizio di Savigny è
stato di “aver considerato il lavoro del Mincucci ... del tutto inutile,
in quanto Bartolo nel suo libro aveva predisposto delle tavole riassuntive” !
Rimane
innanzitutto inspiegabile la circostanza che Savigny,
cime già abbiamo detto, avesse scritto la biografia di Mincucci
nell’Indice, che poteva benissimo occupare una delle pagine dedicate agli altri
autori italiani, invece di relegarlo sprezzantemente nell’indice, perr di più commentando che le tavole di Bartolo rendevano
inutile il testo del Minucci, che aveva fatto un minuzioso lavoro di risistemazione della materia e non aveva
niente a che vedere con le tavole eiassuntive apprestate da Bartolo in quanto la impostazione data dal Minucci al suo testo era da r e p e r t o r i o, come attesta lo stesso Savigny, che consentiva la rapida ricerca di un argomento; purtroppo
il testo di Bartolo è introvabile come
in genere i testi di Diritto feudale,
nelle librerie antiquarie, salvo le rare copie che si trovano nelle biblioteche
di Bologna Minucci e Schilter a Bologna, Firenze e
Trieste.
Dsponiamo
del testo del Minucci, scaricato qualche anno fa gratuitamente - da Google, (seppur
con diverse pagine mal riprodotte); attualmente Google ha cambiato orientamento
e non consente più di scaricare gratuitamente i libri, come avevamo entusuasticamente riferito nell’articolo: La grande biblioteca virtuale di Google,
pubblicato nella Rubrica “Recensioni “ di questa
Rivista.
Ci era sembrato troppo bello ... e, purtroppo le
cose belle finiscono presto:
è così che va il mondo!
Abbiamo
esposto come era stata distibuita la materia del
testo del Minucci e non vi è alcun dubbio che questo testo, attesti la
razionalità della materia, fosse meglio impostato per la ricerca degli
argomenti di quello di Bartolo: come abbiamo detto, a volte questi grandi
personaggi presi dalle loro bizze, soffrono di idiosincrasie ed evidentemente Savigny aveva così pensato di liquidare il testo di Minucci
che non gli era riuscito digeribile!
Alle
volte i grandi personaggi sembra che mangino vipere, accumulando veleno che poi
han bisogno di sputare ... ma ciò avviene anche con piccoli uomini che si compiaccioni
di se stessi per autogratificazione e si comportano come abbiamo riferito
nell’articolo “I primordi dell’averroismo
e la scuola aristotelico-averroistica di Padova” che avevamo mandato a
quella Università ma era stato rifiutato da un docente compiaciuto di se stesso
che si era sentito di ritenere Rénan, superato (!):
e questo è un esempio del corporativismo
in cui sono chiuse le nostre Università!.
Tornando
al Savigny, è da dire che non aveva trattato male
solo di Minucci ... ma aveva avuto anche da ridire su Bartolo
da Sassoferrato (1314—1357) e sulla
sua fama!
Dopo
aver riportato i suoi dati biografici, egli incomincia col mettere in dubbio
che Bartolo fosse stato incaricato – senza prove – della redazione della bolla
d’oro e delle leggi della Boemia, come era stato riferito; poi passa all’esame
della sua reputazione!
“La sua reputazione” egli scrive, “ha superato tutti i giureconsulti del
medioevo, cosa rimarchevole, dal momento che era morto nell’età in cui molti
giureconsulti celebri cominciavano appena a farsi un nome.
La maggior parte degli autori – prosegue Savigmy – ne parla con ammirazione, Alciato lo
considera il primo dei giureconsulti e rimanda ai suoi commentari, dei cui
testi egli non dà alcuna spiegazione. Ciò nonostante
non sono mancate le critiche severe essendo stato accusato di plagio.
A Padova - scive
Savigny - era
stata creata una cattedra per spiegare il testo e la glossa di Bartolo; la grande reputazione di Bartolo lo ha fatto
considerare come il capo di una nuova scuola ed è stato detto che per primo egli aveva applicato la dialettica alla
scienza del diritto: è un errore già rifiutato in questa opera.
Bartolo, al contrario non ha abusato
delle forme della dialettica e qualche volta lo stesso egli se ne è servito con
vantaggio. Altri hnno sostenuto che prima di Bartolo
non esistevano commentari propriamente detti sulle fonti del diritto.
Questa opinione è completamente
erronea. In effetti esisteva dopo duecento anni, un’abbondanza di commentari su
tutte le fonti del diritto. Si dirà che questi commentari non erano che
semplici glosse? Io risponderei che i commentari di Odofredo
sono molto più estesi di quelli di Bartolo.
Si dirà che Bartolo è stato il primo
a commporre dei commentari scritti, tanto che prima
di lui non abbiamo che lezioni orali? Ma la maggior parte delle opere di
Bartolo non sono che lezioni orali, raccolte dai suoi allievi e da lui stesso
ricompensati.
Aggiungerei che Cino, lo stesso anno
in cui era nato Bartolo (1314), aveva pubblicato un commentario scritto sul
Codice, tale che non ne esiste alcuno nelle opere di Bartolo.
Pertanto, se Bartolo non è
l'inventore del nuovo metodo,
la sua reputazione non è altro che il risultato di un capriccio o
del caso; egli non ha fatto altro diversamente dai suoi predecessori, ma lo ha
fatto solo molto meglio.
Dopo Accursio l'esegesi del diritto
non era che "routine" priva d'intelligenza. Bartolo, come il suo
maestro Cino, gli
aveva dato una nuova strada; e senza dubbio
egli deve una gran parte del suo merito alla pratica giudiziaria dei
primi anni.
L’entusiasmo dei suoi primi allievi
dovette contribuire a estendere la sua reputazione e l’interesse che
l’ispirazione del momento aveva dato alle sue lezioni orali e alle sue
controversie risportate nelle sue opere.
Bartolo, malgrado la sua superiorità
sui suoi contemporanei non è esente dalle manchevolezze del suo secolo. Così, i
vantaggi che gli antichi glossatori avevano trovato nello studio immediato
delle fonti, gli
sono venute a mancare. Una massa enorme di commentari dal merito disparato, si
elevava come una barriera messa davanti ai testi ed egli non aveva saputo
resistere a questa funesta influenza.
Ciò nonostante, le opere di Bartolo sono
importanti da studiare esse stesse a causa
dell’influenza che hanno potuto
esercitare fino ai tempi moderni.
Così
Savigny chiude l’argomento: Come si vede...dando un
colpo al cerchio e uno alla botte!
MACCIONI MÈNTORE
DI
MINUCCI
SULLE TRACCE DEL
“DE FEUDIS”
|
M |
igliorotto Maccioni (1732-1811), nel suo libro dedicato a Minucci (*), riconosce che seppur non fosse intellettualmente
all’altezza di Cujacio o dell’Othmann
né avesse la loro cultura, ma riteneva fosse in grado di dare alle leggi romane
la giusta interpretazione e avere l’acutezza di osservare cose che erano
sfuggite ai tempi dell’olandese Cornelis Bynkersboeck (1673-1743) che si opponeva a Ugo Grozio (e dell’olandese Gerard Noodt
1647-1725).
E in ogni caso Minucci “si era inserito
nel percorso delle scuole di Bartolo e Cujacio come
si evince dal Commentario del Digesto vecchio, in cui riuniva in sé la solidità
della scuola di ambedue i giuristi”.
E, aggiunge, ambedue le scuole del Cujacio e del Bartolo avevano i loro pregi ma anche i loro
difetti, e se la scuola di Cujacio aveva portato
all’intelligenza della Legge romana, aveva
caricato l’interpretazione dei testi “con
l’immensa farragine di erudizione inconcludente ed affettata, che altro non
serve che all’impostura con i difetti che sono quelli dei glossatori e degrado
di interpreti barbari”(difetti che, come vedremo, saranno
presi di mira da Antonio Pilati).
E sull’opera di Minucci non mancarono i
detrattori.
Tremenda era stata la filippica di Zaccaria Nibusio che nella Prefazione della sua opera “Institutiones Juris Feudalis quibus Longobardica
& Germanica Jura enucleantur”
- Lipsiae 1720, si era così espresso (*) (in libera
traduzione): “L’italiano di Bologna detto
Antonio da Pratovetere aveva tentato di riformare il
malato diritto feudale presentando la sua compilazione all’imperatore Federico
perché fosse approvata e fu acetttata, non per
questo, ma perché era abietta e derisa, che feriva i compilatori e commemntatori barbari con insolenza e petulanza e,
riformare il diritto feudale non era né il tempo né il luogo”.
Di queste “Istituzioni di diritto
feudale” in cui sono enucleati il
diritto Longobardico e Germanaico”, di 220 pagine (**),
Maccioni ne spulcia il testo per metterne in evidenza gli errori; ma a noi preme riportare la sua architettura,
in quanto, del libro e dello stesso autore non si hanno motizie!
Esso è diviso in tre libri e questi in capitoli in cui fin dalla Prefazione, Maccioni riscontra molti
errori di carattere storico come per es. relativamente alla parola “feudum” fatta risalire al tempo dell’imperatore Carlo IV (1316-1378),
quando invece risaliva intorno all’anno mille; o dei termini “ambactus”, che presso gli antichi francesi significava “servus”, quando invece fin del tempo di Giulio Cesare il suo significato era di “cliens” (cliente); oppure, passando all’autore del “De Beneficiis”, lo
attribuiva al Tommasio nel 1709, quando invece era stato stampato a Colonia
fin dal 1569, e relativamente al “Commentario
dei Feudi” (Summa feudorum) attribuito a Francesco Duaren
(1509-1559), posteriore al Minucci e al
Barattieri (mentre autore era stato Jacopo di Ardizzone (vissuto dopo il
1244), quando (Duaren) fioriva più di un secolo e mezzo oltre (***).
Relativamente ai termini anticamente usati in Germania “Das-Mann-Recht” che denotavano i “giudizi feudali” che si svolgevano davanti al Signore del Feudo, con soggetti
dello stesso Feudo, quando quelle parole denotano ciò che si dice ancora
Mann-Lebnrecht, cioè il giudizio-
feudale che si svolgeva con i “Pari della Curia” per
esaminare le controversie fra il padrone diretto ed il vassallo
(vasso significa basso, Schilter), e tanti altri.
Johannes
Schilter (oltre che giurista, era editore in Lipsia)
aveva intenzione di stampare l’opera del Minucci e si era rivolto a Ericio (Erik) Maurizio, professore presso l’Università di
Tubinga, il quale possedeva una copia, arricchita da elegantissimi ornamenti, avuta
in omaggio da uno studente, ma ricevette un rifiuto e la cercò altrove (alla
morte del Maurizio la copia fu trovata tra i suoi libri).
Recatosi
a Parigi incontrò Cristiano Guglielmo di Eyben
consigliere del duca di Lussemburgo col quale si recò presso la Biblioteca
Reale per esaminare dei manoscritti, e vi trovò il prezioso Codice che stava cercando.
La
scoperta fu comunicata a Tevenot, Bibliotecario
Regio, perché la copia del Codice ritrovata fosse prestata a Schmidio (Giovanni Filippo Schmit)
che in quel periodo da Strasburgo si era recato a Parigi: ma al rifiuto di
darla in prestito a chicchesia, con grande pazienza, egli
non solo copiò, ma descrisse tutto ciò che si trovava nel libro.
Questo
Codice di Parigi (***). riposto al n. 5115 dei Manoscritti Giuridici, è in folio (di quarta), elegantemente
scritto, con molte miniature (del XVmo secolo non troppo inoltrato). Contiene non solo l' Opera
feudale, ma altre piccole operette.
Vi è nella prima pagina. un'elegante miniatura, con l’imperatore. seduto sul trono, circondato da alcuni "togati” tra quali si vede Antonio da Pratovecchio che reverentemente
gli porge il suo libro.
Lo
Schilter ne fece intagliare una simile in rame apposta
al principio dell'Opera nell' Edizione di Strasburgo dove la fece imprimere
nel 1695 con il Codice che stampò del Gius
Feudale Alemannico, aggiungendovi una “Prefazione” in cui riportava una buona
storia delle Collezioni Feudali,
seguita da molte testimonianze di autori illustri.
*)
“Osservazioni e Dissertazioni sopra il Diritto Feudale l’Istoria e le Opinioni di Antonio
Minucci di Pratovecchio”, Livorno
MDCCLXIV.
**) Tentavit invalide Feudalia
Jura reformare quidam Italus Bononiae dictus Antonius de Pratoveteri. Voluit
Compilationem suam Friderico Imperatori consignare
ut approbaretur sed recepta non
tantum non fuit, sed abjecta,
& derisa, ut ferebat Compilatoris, & Commentatoris Barbari insolentia
& petulantia. Reformare
Jura Feudorum non erat illius temporis & illius Loci.
***) Tralasciando gli errori
riscontrati dal Maccioni e le sue critiche, il contenuto del testo ci sembra
interessante (il diritto feudale lo troviamo affascinante e questo articolo lo
abbiamo maturato da tantissimi anni e dentro gli abbiamo messo amche l’anima,come
d’altronde facciamo per gli altri articoli!), come detto del testo e dell’autore, dalle ricerche effettuate
presso le biblioteche italiane, del Vaticano. e statunitensi non abbiamo
trovato notizie.
Ecco
il giudizio del Maccioni sul libro del Nibusio.
L’ordine
del libro è adattato in modo da oscurare tutta la materia. Nel Libro I tratta
dei modi di costituire e di acquistare i Feudi e riserva poi al Cap. III. del
secondo Libro la trattazione dell'Essenza e della Natura de' Feudi, e qui si
trovano tutte le Definizioni che possono chiarire l'argomento.
Nei
Capitoli IX, X, XI, del Libro II, tratta insieme i Debiti Feudali, e i Modi in
cui cessano i Feudi e si perdono. Nel Libro III tratta dell'autorità del Gius Feudale e vi osserva diverse
questioni sopra la Convenzione Feudale.
Il
cattivo metodo, commenta Maccioni, è seguito da una turba d' infiniti errori
di giudizio e di fatto e non dice che poche parole dello stile della Curia
Feudale nel Libro terzo Cap. IV., e poi impiega molti Capitoli nel Lib. terzo per osservare la coerenza del Gius Comune col Feudale
, e in altri luoghi, come nel Libro primo, Cap. VIII va dietro alle Etimologie di vari nomi, e in così poco
spazio si prolunga tanto.
Tralasciando
molti altri simili errori, mi soffermo su quelli più importanti con i quali si confonde
tutta la materia feudale, seguendo
opinioni false o non comunemente approvate.
Nel
Libro primo, Cap. III, dice che l’Oblazione dell'Enumerazione delle cose
Feudali si deve fare dopo l’investitura, quando in effetti si deve seguire il
contrario. Nel Libro primo, Cap. IV. scrive che l’Investitura simultanea
regolarmente non si rinuova, perché non è del genere
delle Investiture che si devono rinnovare; e pure noi
vediamo che tutti i Dottori sostengono l'opposto (cit. Cocceio).
Nel
Lib. secondo Cap. X, afferma che la Donna quando ha
perduto la Dote non può chiedere la porzione Statutaria (e questo è un massìccio errore). Inoltre nel Libro secondo, Cap. XII, sostiene provenire
dal
quasi delitto la necessaria conseguenza della privazione del Feudo, poiché,
stante l’equità, d’ordinario non si perde il Feduo. Nel
Libro terzo Cap. II asserisce che con l’invesitura
non si trasmette altro che il Gius ad rem. Nel Libro terzo Cap. IV, osserva che per patto aggiunto non si può
ottenere la personale immunità. Nel Libro terzo Cap. V, afferma che non possono
succedere nei Feudi assolutamente coloro che sono ascritti all’Ordine
Ecclesiastico. Nel Libro terzo del Cap. IX assume per vero che essendo sede
vacante un Capitolo, non possa rimuovere i Feudi sottoposti, prendendo esso
equivoco dal non potere il Capitolo concedere un Feudo Nuovo. Nel luogo
medesimo crede che i Vicari dell’impero non possano concedere i Feudi dei Conti e dei Baroni.
Infiniti
altri errori di questo Autore potrei qui riferire ; ma
da quelli che fin'ora si fono notati , si può arguir
che parla a caso, quando non inciampi in qualche scoglio. Eviterò pure di notare
che quel testo
è ripieno di solecismi e barbarismi e di tutto ciò che può far degna l’opera
del del suo
Autore, meritando questo impugnatore del Minucci , che ai suoi scritti si renda
dal pubblico quell' onore che il Mureto (Marc’Antoine Muret 1526-1585) voleva
compartire con i Poeti di Brescia.
****)
Il libro porta il seguente titolo: Antonii Mincucci de Pratoveteri De Feudis
libri sex omni veteri Feudorumjure nova ordinatione collecti. Ad Sacratissimum Principem Sigisundum Romanornm Imperatori nunc prinum
ex MS. Codice Bibliothecae Regiae
Parisiensis editi dudun. vero
ab eruditis desiderati. Argentorati
per Fridericum Spoor
CHI ERANO
GLI AUTORI DEI
I
LIBRI DEI FEUDI
LOMBARDI
|
G |
iannone riferisce che il nome di coloro che avevano
scritto i libri milanesi non è molto chiaro; prima di Cujacio,
egli dice, alcuni ricercatori avevano ritenuto che autore della compilazione
fosse stato Oberto de Orto, avvocato del senato e console milanese, il quale
aveva realizzato l’opera con l’aiuto di Gherardo del Negro altrimenti detto Cacapisto, anch’egli console di Milano e
giureconsulto .
Poi aggiunge, cominciarono ad
illustrare questi libri, con semplici glosse, Bulgaro (1085-1166), Pileo da
Prata, Ugolino de’ Presbiteri (1233), Corradino, Vincenzo, Goffredo ed altri (indicati
da Guido Panciroli 1523-1591) fino all’intervento di Giovanni Colombini (1304-1367) che nel sapere aveva superato
tutti - come aveva scritto Giasone – “dopo di lui niun altro ebbe ardimento di scriver glosse su quei libri”.
Cessate le
glosse si incominciò a scivere le “Summae” opere più
concentrate che contenevano il compendio
della materia, e poi si passò ai “Trattati
de’Feudi” che affrontavano l’intera materia; tra i primi furono Pileo,
Giovanni Fasoli, Odofredo, Rolandino, i due Giovanni Blanasco e Blanco, Goffredo, Giovanni Lettore, Martino Sillimano, Giacomo d’Arena, Giacomo de Ravanis,
Ostiense, Pietro Quessueal e Iacopoo
Ardizzone (Giannone cita come fonte per tutti, Panciroli in Thesaurus e De claris legum interpretibus, di queste
opere non si trovano esemplari e eanche notizie
dell’autore), seguiti poscia da Zasio, Rebuffo,
Anettone, Rosental seguiti
da infiniti altri libri moderni.
Il
primo fra questi giureconsulti secondo
Giannone, fu Giacomo di Belviso ma fu oscurato da Andrea d’Isernia il quale (durante
il periodo di Carlo II che morì nel 1309), scrisse così copiosi commentari sui
feudi (Commentaria in usum Feudum),
che oscurò quanti mai prima di lui si erano accinti in questa impresa.
E,
ancora, dopo aver professato quarantasette anni la legge civile, Baldo degli Ubaldi, detto da Perugia (1319/27-1400),
discepolo di Bartolo, scrisse i “Commentarii sopra i
Feudi” (Panciroli), oltre ad esseere autore del Corpus juris civilis e delle Decretali
di Gregorio IX (e gli sono attribuita altre opere non sue), e poco dopo, Jacopo
Alvarotti da Padova (1385-1453), con “Commentario
ai Libri Feudorum” e Giacobino di Giorgio e Francesco Curzio junior.
Ma sopra tutti, precisa Giannone, emerse il nostro Matteo d’Afflitto (1447/59-1523), il quale oscurava
la fama di costoro (Panciroli). Egli insegnava all’Università di Napoli (sotto
Ferdinando I 1751-1825) con stipendio (gli insegnanti all’epoca erano pagati
dagli studenti ndr.) dove commentava gli interi Libri Feudali di
Isernia, ciò che nessuno aveva mai avuto l’ardire di fare né prima, né dopo di
lui, e per questo criticato dal Camerario (Bartolomeo Camerario detto il Temerario 1497-1564), che riteneva che a
causa della vecchiaia d’Afflitto non avesse ben penetrato la mente di Andrea
d’Isernia.
Su questa critica
insorgeva Giannone che sosteneva che ciò non fosse esatto e “niente vi sarebbe stato da riprendere, in
quanto d’Afflitto avrebbe potuto scrivere anche se avesse avuto l’età di
ottant’anni, l’età che aveva quando morì”.
Aveva iniziato a
scrivere i suoi Commentari nell’anno 1475, come egli stesso aveva confermato,
quando aveva trentadue anni, in quanto erano stati sollevati dubbi da parte del
Camerario, il quale sosteneva che d’Afflitto avesse scritto questi commentarii quando era già vecchissimo e che
perciò (per mancanza di lucidità mentale) non
avesse ben penetrato la mente d’Isernia.
“Taccia” - scrive Giannone - “ingiustamente
attribuita a quell’insigne giureconsulto, in quanto oltre ad aver scritto nella
più verde e florida età, non vi sarebbe stato nulla da riprendere, se avesse scritto all’età di 80
anni nella quale morì”.
D’Afflitto era
morto nel 1523 e fu sepolto ìn Napoli nella Chiesa di
Monte Vergine, ove si legge che carico di anni, in età senìle
era ancora vigoroso di mente da poter sostenere gli studi fino all’ultima vecchiaia;
ciò che i suoi familiari avevano voluto fosse scolpito a causa del livore dei
suoi nemici, i quali avevano convinto il re Carlo (l’imperatore Carlo V) della sua debolezza
senile e l’imperatore (che non aveva molta predisposizione al mecenatismo, come
si vedrà in Art. Carlo V tra Rinascimento, Riforma ecc.), lo aveva privato
della carica di consigliere di Santa Chiara; e, quanto al giudizio sul suo Commentario lo aveva dato Francesco D’Andrea
che aveva scritto che erano pochi coloro che
si potevano paragonare a lui, ma nessuno potesse superarlo.
Sorsero, conclude Giannone,
dopo questi lumi della giurisprudenza feudale, fra noi e gli altri autori, Camerario, Sigismondo
Lofflredo, Pietro Giordan Ursino, Bammacario,
Revertero, Pisananello,
Montano e tanti altri, dei quali a volerli indicare tutti, l’elenco sarebbe lungo
e nessuna menzione potrebbe vantare tanti scrittori in materia feudale, quanto
il regno di Napoli (ieri come oggi in cui ve ne sono quanti in tutta
la Francia! ndr.).
I
LIBRI DEI FEUDI
LOMBARDI
SONO
ACCOLTI
IN TUTTI I REGNI
|
N |
e
conseguìva che nel Codice,
oltre alle Autentiche d’Irnerio, erano stati aggiunti estratti di Statuti e
Costituzioni di Federico I (ivi indicati); e questa, scrive Giannone, fu
l’incombenza data da Federico ai professori di Bologna, e non altro.
Ma,
Odofredo aveva precisato che successivamente Ugolino,
di suo capriccio, al corpo delle Novelle di Giustiniano - già diviso in nove collazioni, dal che chiamato “nona collazione” - aggiunse il “Libro feudale” e, raccolte insieme tutte quelle Costituzioni degli imperatori che riguardavano i feudi, li inserì in quel libro, secondo
l’ordine in cui li troviamo oggi, e i nostri chiamarono sin dai tempi di Odofredo, “decima
collazione”; ciò che testifica che ai
suoi tempi, pochi erano coloro che aveano quelle
Costituzioni così ordinate, come le aveva disposte Ugolino (Schilter,
in Prefatio
al Mincuccius).
Così
erroneamente i più eruditi scrittori hanno
creduto che Federico II avesse dato autorità e forza di legge al Libro
de’ Feudi, e che sin dai suoi tempi, esso
avesse acquistato tal vigore nel nostro e negli altri reami.
Non
altrimenti avvenne dei libri di Giustiniano, in modo che il Corpus juris, ora
comprendeva anhe il Libro dei Feudi - per l’uso e consuetudine
dei popoli e per connivenza dei principi,
i quali permisero che nelle Accademie pubblicamente si insegnasase
e s’illustrasse con commentari, dai loro giureconsulti; e si allegasse nelle conroversie forensi nei loro tribunali, come ben aveva
provato il Molineo
(Charles Dumoulin, 1500-1566, Ad Consuet.), reputato il Papiniano della
Francia.
Molineo,
a torto, scrive Giannone, riprende Odofredo, quasi eh’egli avesse data occasione agli altri d’errare, quando
questo autore non mai disse che Federico avesse dato forza di legge a quel
libro, nè che quella compilazione di Ugolino si fosse
fatta per suo ordine, siccome ancora a torto riprende Bartolo, quasi ch’egli
fosse stato il primo a dare alla raccolta di Ugolino il nome di decima collazione.
Questo
nome è purtroppo antico e più di cento anni prima di Bartolo, era così chiamato
nell’uso comune, come testimoniato dallo stesso Odofredo
e come lo chiamarono tutti gli scrittori prima di Bartolo.
E
così questa “decima collazione” aveva
raggiunto gli altri regni – con i Libri
feudali milanesi –
e per il suo uso e consuetudine aveva acquistato vigore nei regni
dei principi cristiani e aveva raggiunto una tale autorità da superare e
derogare le proprie leggi, quando non erano in contrasto con le proprie leggi e i propri costumi.
Così
avvenne, come attesta Cujacio, nel regno di Francia, che
ricevè quelle leggi feudali, delle quali si avvale
l’Italia, ciò che non ripugnava alle leggi e costumi di quel regno, come per altro ovunque “in cose nautiche” si faceva ricorso alla
romana lex Rodia.
Come
aveva detto il Presidente Charles Giraud, nel suo “Eloge de Schilter”
(in cui sono indicati tutti i suoi scritti, Strasbourg,
1845) il diritto lombardo superando i
monti si era propagato in occidente ed
era divenuto diritto comune dei feudi in Alemagna come in Francia.
Schilter aveva
dimostrato dalle fonti del diritto germanico che vi era un diritto feudale alemannico, un diritto feudale sassone o un diritto feudale
franco, tutto comune al diritto feudale lombardo, ciascuno con un carattere
proprio; e ciascuna famiglia germanica aveva liberamente incontrato nella sua
marcia verso la civilizzazione moderna, una forma analoga al proprio
particolare genio.
Il
Codex juris feudalis alemannici, germaniae et latine di Schilter
(*) scrive Maccioni, è ancora un libro prezioso della cui autorità le
pubblicazioni moderne
non possono fare a meno,
*)
Titolo completo: Codex juris feudalis alemannici, germaniae et latine,
cum commentario ad singula capitula, ac dissertationibus huc pertinentibus et praefatione de ejusdem juris origine, usu auctoritate. Accedunt Antonii Mincuccii de Prato Veteri libri VI de feudis, a biblioth, parisiensi nunc primunm editi; Bartholomaei Baraterii libellus feudorum reformatus, et Antonii D. Alteserrae de origine
et statu feudorum pro moribus
Galliae liber singularis. Argentorati
(Strasburgo) 1697 in 4°, 3 part. en 1 vol, in 4°; reimprimé plus correctement en
1728 à Sttrasbourg in–fol.,
par les soins de Schertz, qui ajouta une préface et quelques disserations dejà imprimé, entre autres celle De jure emponematum (Del diritto
di miglioria fondiario), al quale è da aggiungere Ad jus feudale utrumque germanicum et longobarducum introductio. Strasbug 1695, in 8°; it avec des corrections inédites 1721 ibid. in 8°, 1727 in 8°, it, cum adnot.G .Chr. Gebauer, Lipsiae, 1728 in 8°; it.cum observat. J.G. Heineccii. Berol. 1742, in 8°; it ead. accedunt Schilteri
comment. de natura success. feudalis,
atque ad eamdem mantissa (tirée du traité
De Paragio etc. infra n.36°)
Berol.1750 in 8°. Ce livre classique a de plus eté l’objet de plusieurs commentaires fort étendus, ecrits en langue allemande.
Oltre
a questo testo Schilter aveva riassunto la materia
nelle Institutiones Juris Feudalis
Germanici et Longobardici; Accedunt De Exoeditione Romana etc.Lipsiae, Ioh.
Frid. Gleditschii B. Fil.
1728.
I
GIURECONSULTI
DI
NAPOLI ACCOLGONO
I LIBRI
FEUDALI
E SUPERANO
I
COLLEGHI DEGLI
ALTRI
REGNI
|
L |
a
compilazione di questi libri fatta dai giureconsulti milanesi, scrive Giannone,
non ebbe nelle nostre provincie nessuna autorità di legge, come non l’ebbe nelle
altre parti d’Europa; ma dopo il corso di molti anni, piuttosto per uso e
consuetudine, che per costituzione del principe, acquistarono autorità, ma essa
non fu assoluta, accolta solamente per quelle parti che ripugnavano alle leggi
e in particolare ai costumi di ciascun
regno
Certamente
non l’acquiostarono da noi quando regnava Guglielmo, e i suoi
successori normanni. Quivi si ebbe infatti la compilazione del 1170, come aveva
provato l’accuratissimo
Francesco d’Andrea e non dall’anno 1152, che fu il primo di regno di Federico I, come aveva scritto
Arturo Duck, quando tra il re Guglielmo e Federico ardeva crudele ed ostinata
guerra, e quando tra noi ed i Lombardi era interdetto ogni commmercio
per le guerre intestine che sin dai tempi di Lotario ebbero sempre i nostri
principi con gli imperadori d’Alemagna .
La
tregua tra Guglielmo e Federico non si concluse prima dell’anno 1177 ed avendo
questi regni proprie o particolari consuetudini, come abbiamo visto con i libri
Defetarii,
non vi era la necessità di ricorrere alle leggi dei Lombardi, quando vi erano già
le proprie, con le quali si regolavano i feudi.
E’
da ritenere, prosegue Giannone, che questa compilazione cominciasse ad essere nota
ai nostri giureconsulti dopo l’anno 1187, quando il nostro re Guglielmo per la pace dei suoi sudditi
concluse le nozze di Costanza sua zia con Enrico re di Germania, onde vennero a
cessare le occasioni delle discordie con gli imperatori d’Occidente.
Ma
questo non bastò perchè non seguissero più fiere ed
ostinate guerre; poichè morto poco dopo Guglielmo, i
baroni del regno aborrendo la dominazione di Enrico come forastiero,
elessero loro re Tancredi, il quale anche dal pontefice romano ottenne
l’investitura del regno.
Per
la qual cosa è da credere che questi libri cominciassero ad esser conosciuti dai
nostri dopo che Enrico nell’ anno 1194, scacciati i normanni, si rese padrone
del regno per le ragioni dotali di Costanza sua moglie.
Sebbene
fossero presso di noi conosciuti, non acquistarono alcuna autorirà
di legge; nemmeno l’acquistarono quando suo figlio Federico Il promulgò le sue Costituzioni
fatte compilare da Pier delle Vigne; nè quando, ad
esempio della altre città d’Italia, avendo ristabilita in Napoli l’Università
degli Studi, introdusse che nelle nostre scuole si leggessero le Pandette e gli
altri libri di Giustiniano; poichè non è vera la
costante opinione dei nostri autori, che questi libri da Federico I,
acquistassero forza ed autorità, e che questi fosse primo imperatore che li avesse
approvati, mandandoli a Bologna aflinchè ivi
pubblicamente nelle scuole si leggessero; o che egli fosse stato l’autore, per ordine
dato a Ugolino, della decima collazione, avvalendosi della testimonianza di Odofredo. A torto i nostri scrittori imputano ciò ad Odofredo, il quale non mai scrissø che Federico
mandasse il libro de’ Feudi in Bologna.
E – prosegue Giannone – qual bisogno vi era mandar questo libro in Bologna, quando in questa città
da molti anni era conosciuto e non pur letto dai botognesi,
ma anche molto prima vi avea scritte le sue g]osse Bulgaro, che per più anni professò legge in Bologna,
sin dai tempi di Federico I da cui fu fatto anche prefetto di quella città? (Panciroli)
Quando
era ugualmente noto in tutte le altre città di Lombardia, per essetvi nato; e molti scrittori d’Italia più antichi di
Federico II avevano già cominciato a farvi le glosse come oltre a Bulgaro fece
Pileo, ed altri rapportati da Arturo (Duck), e notati anche dal nostro Andrea
d’ Isernia ?
Odofredo
nel luogo additato non scrisse altro, se non che Federico Il mandò ai dottori
bolognesi, non già il libro dei Feudi,
ma le Costituzioni sue e degli imperatori d’Occidente che furono dopo
Giustiniano, affinché, siccome Irnerio dalle Novelle avea
inserito nel Codice ciò che gli erra parso essersi per quelle di nuovo aggiunto
o corretto, così essi lo stesso facessero anche
per quelle costituzioni, l’aggiungessero al Codice, non già al libro dei
Feudi, sotto quei titoli che paresse loro convenire.
E
così, radunati a S. Petronio, da quelle Costituzioni estrassero molte cose, che
aggiunsero o adattarono alle leggi del Codice sotto i titoli convenienti e quindi
il Codice, oltre alle Autentiche d’Irnerio, si leggono ancora con le altre aggiunte.
In
proposito è da osservare
che dopo la pubblicazione delle Costituzioni (1231) vi fu tra i nostri giureconsulti grande contestazione nella Gran corte,
relativa a questi libri feudali, per quelle parti che non ripugnassero le
nostre Costituzioni e che potessero
avere per noi forza di legge, come si disputò relativamente alla Glossa (in
Costitut. De successinibus),
Si
tenga a questo punto presente che fin da quando si era incominciato a studiare
in Italia con Irnerio, il diritto giustinianeo, questo passava per diritto romano ma tale non era in quanto
era stato elaborato a Bizsanzio ed era quindi
divenuto bizantino (come abbiamo già detto in Art. sul
Corpus Juris civiis
ecc. e ci auguriamo di tornare
sull’argomento ndr.); in pratica il diritto romano originario era stato elaborato e falsato dal bizantino,
con le interminabili disquisizioni che non erano altro che polemiche intorno a un argomento (come era avvenuto in religione
per il filioque,
su cui si era discusso per secoli!), che servivano
a tagliare un capello in quttro: si pensi alle obbligazioni che per i romani nascevano
puramente da contratto o da delitto, mentre
i bizantini lo avevano diviso in quattro, in quanto vi avevano aggiunto il quasi contratto e il quasi delitto! Ciò che sarà deleterio
per il futuro dell’Italia (come abbiamo visto nel citato Corpus Jiuris civilis ecc.) portandola
verso la deleteria burocrazia dei nostri giorni!
Tornando
al Giannone: Dal che si ritiene, egli scrive, che anche in questi tempi era
dubbio se questi libri avessero acquistato forza di legge; e se ciò era
incerto, per questo stesso motivo non potevano reputarsi di una tale autorità, da
poter uguagliare quella delle leggi.
E
se Roffredo (Epifanio 1170-1243), “nostro beneventano” (per Giannone), che
fiorì in questi stessi tempi di Federico II, parlando di queste consuetudini feudali, oppose il “servari in Regno Apuliae”,
nel senso che si dovevano mantenere nel regno, non fosse per altro, se non perchè questa sua opinione era opposta agli altri periti
del regno, che sostenevano il contrario.
E così avvenne che in questi tempi e
da questo momento, queste consuetudini feudali, si fossero osservate, non già
per autorità di legge, ma di ragione e per quanto non si opponessero e non fossero
contrarie alle nostre costituzioni
(Franciscus de Andreis in “Disputae Feudalis”).
Ciò
è tanto vero, prosgue Giannone, che dopo Federico, nei
tempi degli altri re suoi successori, e più di ogni altro, degli Angioini, di
ciò non si fosse più disputato, essendo chiaro che avessero acquistato successivamente,
nel nostro regno, tutta la loro forza ed autorità, quando non si opponevano
alle nostre costituzioni, così come l’avervano acquistata
in tutti gli altri regni d’Europa ed anche presso i pontefici romani nei loro
tribunali ecclesiastici ai quali diedero pari autorità e vigore.
Anzi nel
corso del tempo, lo studio di questa parte di giurisprudenza presso di noi fu tanto
coltivato e tenuto in pregio, che i nostri superarono tutti i giureconsulti
delle altre nazioni, così in Italia, come oltre ì monti; ed oggi giorno è questo
il particolare vanto del nostro regno (è sempre Giannone, napoletano che scrive! ndr), che in nessuna altra parte si sia saputo e si sappia tanto della dottrina
feudale, quanto dai nostrì giureconsulti.
Di
ciò, conclude Giannone, ne abbiamo avuto testimonianza relativamente alla diatriba
che si era verificata tra Andrea d’Isernia e Baldo, il quale chiamato a Napoli
dalla regina Giovanna I (1326-1381) per consulto, si mostrò così ignaro della
materia feudale, che non senza discapito della sua fama, “bisognò che nella vecchiaia s’applicasse a questo studio per ristorare
la sua perduta stima” (Cardinale di Luca).
LA
SISTEMAZIONE
DI
CUJACIO
E LA
POSIZIONE
DEL “DE FEUDIS”
DI MINUCCI
|
G |
iannone, dopo aver elogiato i giurisperiti
napoletani, scriveva che dopo questi lumi della giurisprudenza feudale sorti fra noi - “non si può defraudare della meritata
lode, fra gli stranieri, l’incomparabile
Cujacio”(Jaques
Cuiace, francese 1522-1590).
Fu
il primo, egli scrive, che, rifiutando
come barbara la parte delta nostra giurisprudenza trattata dagli altri,
l’accolse e le apparecchiò una abitazione con l’aiuto dei libri più rari e
degli scrittori di quei tempi, le diede altra più nobile ed elegante apparenza,
tanto che gli altri eruditi, che prima l’avevano rifiutata come barbara, si
invogliarono con il suo esempio ad impiegarvi i loro talenti, come fecero Duareno,
Ottomanno, Vulteio ed altri
nobili ingegni, col risultato che oggi la vediamo esposta ed illustrata dagli
uni come dagli altri professori.
Egli
aveva ben provato che Oberto de Orto non fosse l’autore del primo libro, in
quanto in esso si trovavano delle sentenze che egli stesso aveva riprovato, e
poiché quelle sentenze si attribuivano a Gherardo del Negro, aveva reputato che quel libro fosse non già di Oberto ma di del Negro; alcuni
però, come il Montano (Giovanni Bonifacio 1547-1635) non erano convinti di questa congettura.
In
ogni caso Cujacio, prosegue Giannone, ritenendo che
il secondo libro fosse di Oberto, compilato su istruzione del figlio Angelo.
saggiamente reputò distinguerli, e divise, come abbiamo visto, il secondo
libro in quattro, ciò che fu accettato
dai giurecunsulti
che si astennero dal mutarli per tìmore che
nelle citazioni si sarebbe cagionata confusione sicché trovandosi già questa
compilazione in due libri, volendosi il secondo dividerlo in più libri, le
citazioni non sarebbero state corrispondenti alle precedenti citazioni onde Cujacio, decise di dividere i due libri in quattro, sicché
il primo è di Gherardo, il secondo fino al
Titolo 25mo di Oberto, i rimamenti titoli li divise in due altri libri, cominciando
il terzo dal 23 di Oberto de Orto (con
l’indicazione “Anselmo filio suo salutem”);
il quarto comincia dal titolo 25, ivi, “Negotium tale est”.
E’
chiaro, scrive Giannone, dallo stesso titolo 25 che sia stato compilato da
diversi e incerti autori e su ciò sono d’acordo Cujacio e Montano; nel quinto egli unì tutte le Costituzioni
degli imperatori attinenti ai feudi, su cui si tornerà ad argomentare.
Prima di Cujacio, Antonio
Minucci di Prato Vecchio, aggiunge Giannone, giureconsulto bolognese, per
comandamento dell’imperatore Sigismondo, intorno all’anno 1430 aveva disposti
questi libri in altra forma; ed avendoli divisi in sei, li offrì all’Università
di Bologna, perché si ottenesse da Sigismondo conferma di questa raccolta; ma
non consta che I’ imperatore l’avesse
lor data (per i motivi che abbiamo esposti), onde (in momento
successivo) i bolognesi richiesero di
nuovo conferma all’ imperatore Federico III, il quale la concesse; onde avvenne
che questi libri fossero letti pubblicamente nell’Accademia di Bologna, senza
acquistare giammai autorità pubblica: la qual raccolta fu da
poi data alle stampe da Johannes Schilter.
Successivamente alla sua prima edizione
(successiva a quella del Minucci per ordine di età ndr.), conclude Giannone, Cujacio fece un nuovo testo
nel quale con somma diligenza diede altro e diverso ordine e ridusse quei libri a miglior lezione, e
li commutò con amorevole erudizione, spiegando il loro vero significato, e sopratutto accrebbe il quinto libro, di molte costituzioni
imperiali, che erano state omesse da Ugolino, dandogli miglior ordine e disposizione.
Delle edizioni di Cujacio comunque non vi è
traccia nelle Binlioteche collegate con Internet (ndr.).
LE
COSTITUZIONI
IMPERIALI
ATTINENTI AI FEUDI
E LEGGI DI FEDERICO II
|
I |
l primo a promulgare le leggi riguardanti la
successione feudale, espone Giannone, fu eome più
volte si è detto, Corrado il Salico, seguito da Enrico IV che ne stabilì delle altre,
seguito in terzo luogo da Lotario III; ma sopra gli altri imperatori nessuno ne stabili tante quanto Federico Barbarossa e con
le Costituzioni di questo imperatore Cujacio termina
il suo libro.
Sebbene nelle edizioni volgate se ne leggono
anche di Federico Il, queste dovrebbero togliersi, poiché di Federico II come
imperatore, non si hanno costituzioni attinenti ai feudi; di queste
Costituzioni del regno ve ne sono moltissime ma esse non hanno nulla a che vedere con le altre in
quanto non sono augustali, ma erano state da lui stabilite come re di Sicilia e
solo per questi suoi regni ereditari, non per altri (si tenga presente una
volta per tutte che le Costituzioni imperiali raccolte erano anche quelle di
tutti gli imperatori bizantini che si erano succeduti sul trono di Bisanzio,
che in effetti non avevano nulla a che vedere con i feudi, inesistenti nell’impero fino a quando l’impero non fu
conquistato (1204) dai cristiani, ndr.).
Quelle costituzioni di Federico II che si leggono
alla fine del Libro dei Feudi, secondo l’antica compilazione sotto il titolo di
Statuti et Consuetudinibus
circa libertate Ecclesiae editis,
ecc., non hanno niente a che fare con i feudi, onde a torto furono aggiunte
e per questa cagione, Cujacio riferisce di non averle unite
colle altre feudali,
Per la stessa cagione le altre due di Enrico VII,
poste sotto il titolo di Estravagantes,
non appartenendo ai feudi, non meritano di trovarsi in quel luogo.
Di
questi imperatori nessuno quanto Federico I promulgò tante Costituzioni
feudali, delle quali ve ne sono otto (*).
Di
queste la sesta sotto il titolo di Pace Costantiae, come la quinta che la preceede, appartiene alla pace d’Italia e fu stabilita
a Roncaglia con i milnesi nella prima guerra che
Federico ebbe con loro.
Federico,
per questa custituzione, aveva concesso alcune regalie
alle città suddette, e verso altre egli si ritenne Fodrum e Investiturum Consulum et Vassallorum e
concesse al marchese Opizo il cognome Malatesta,
Seguono per ultimo dell’istesso imperatore, due
costituzioni de Jure
protomiseos, il quale dritto al sentir di Cujacio (che che ne dica il
nostro reggente Marinis), competendo non meno agli agnati che ai padroni dei
feudi, egli volle inserirle nel quinto libro dei Feudi; parimenti aggiunse una Novella greca dell’imperatore d’Oriente
Romano Lecapeno, che tratta il medesimo diritto,
donde Federico prese ciò che si vede stabilito nella prima sua costituzione
attenente al Jus protomiseos.
Da ciò non possiamo tralasciare di notare che
questa costituzione Sancimus, de jure protomiseos, con gravissimo errore da nno dei dottori è creduta che fosse costituzione di Federico
II e sopra tal supposizione disputano se abbia a reputarsi come sua costituzione
augustale, ovvero come una delle costituzioni del nostro regno, stabilitta per i regni di Sicilia e di Puglia; ed alcuni
sostengono che come tale abbia forza di legge nel
nostro regno.
E l’errore
è nato perchè la vedono unita insieme con le altre
costituzioni e capitoli del nostro regno; ed anche perché hanno rilevato che il
nostro Matteo d’Afflitto, che commentò le nostre, costui, fece anche sopra la
detta costituzione un particolar commento, tratto nella
maggior parte da un altro, non impresso, che ne fece prima di lui Antonio Caputo
di Molfetta, dal quale, come dice Giovanni Antonio de Nigris, soppresso il nome, Afflitto ne prese tanto, da scrivere quel
suo trattato; onde vedendola commentata dai nostri antichi scrittori, la reputarono
come una costituzione del nostro regno.
L’errore è gravissimo e indegno di scusa; onde
non possiamo non meravigliarci esservi incorso anche il cardinal di Luca, il
quale da questa credenza che tal costituzione fosse di Federico II, fa nascere
mille qaistioni, le quali cadono per sè stesse, come appoggiate sopra un falso fondamento; poichè la promulgò non Federico II, ma Federico I, il quale
non aveava nessuna autorità di far leggi nei reami di
Sicilia e Puglia, onde non poteva obbligar con quella i sudditi di Guglielmo ad
accettarla.
Acquistò essa tanta forza di legge presso di noi,
non già per autorità del legislatore, ma per consuetudine dei popoli, i quali
dopo lungo corso dì tempo la ricevettero non altrimenti che fu fatto per le stesse
Pandette, e per gli altri libri di Giustiniano e ancora di questi libri dei Feudi;
ond’è che oggi abbiano tutto il loro vigore nel regno,
ma non già nella città di Napoli, ove su questo argomento si procede con particolare
e propria consuetudine,
Le altre leggi di Federico I, così le militari stabilite
nel 1158 in Brescia ncll’assemhlea dei principi
dell’impero, come le civili, non appartenendo punto a feudi nè
a noi, volentieri tralasciamo, potendo osservarle presso Goldasto
(Costituzioni Imperiali) che le raccolse tutte nei suoi volumi,
*) La
prima è sotto il titolo de Feudis non alienandis, ove si prospettano tre o quattro motivi in
base ai quali si perde il feudo, proibendosi con maggior rigore, quello
stabilito da Lotario: relativamente all’alienazione
de’ feudi.
La
seconda, sotto il titolo de Jure Fisci, ovvero de Regalibus,
ristabilisce in Italia le regalie, le quali per disusanza
andavano mancando, di cui si è già detto in precedenza. La terza, sotto il
titolo de Pace tenenda,
appartiene alla pubblica pace di Gernnnia onde dai
Germani volgarmente è detta “Fried-brief”, cioè
Breve di pace, e fu promulgata in
Ratisbona dopo che erano state sedate le lotte intestine tra i principi di Germania,
i quali avevano lungamente guerreggiato tra di loro per il ducato di Baviera,
tolto dall’imperatore Corrado a Enrico il
Superbo; e poiché in essa si stabiliscono alcune disposizioni attenenti
ai feudi, ai baroni e alla pubblica pace, fu annoverata tra le costituzioni
feudali di questo principe.
La
quarta, sotto il titolo “de incendiariis et pacis violatoribns”, che Cujacio
prese dall’abate Uspergense, e che fu pubblicata da
Federico nell’anno 1187 in Norimberga, parimenti appartiene alla pubblica pace
di Germania, e pone alcune norme dei feudi; inoltre, anche se non riguardano
direttamente i feudi, i nostri maggiori, come bene osserva Cujacio,
han avuto l’accortezza di congiungere con i feudi, tutte quelle istituzioni che
trattavano della pubblica pace, in quanto essa non potrà mai aversi, se non dalla fede e costanza dei
vassalli.
La
quinta, sotto il titolo “Pace componenda cI rctinenda
inter suhjectos”, appartiene alla pubblica pace
d’Italia, e fu promulgata in Roncaglia e firmata in Costanza (1183) con i milanesi nella
prima guerra che Federico ebbe con loro, poiché Federico già stanco delle tante
guerre avute eon i
lombardi, volle intimare a tutti una dieta in Costanza, per poter quivi
comporre questi affari.
La
sesta sotto il titolo “de Pace Constantiae”, appartiene anch’essa alla pace d’ Italia.
Vi
intervennero molti principi e baroni e i deputati delle città di Lombardia, dei
quali detta costituzione si legge in un ben lungo catalogo. Furono in essa
accordati molti articoli e stabilite le condizioni delle città di Lombardia
intorno ai servizi che si devono prestare all’imperatore, oltre ai quali non
potessero esser gravati di alcun vantaggio.
PREMESSA
SULLA CAOTICA
SITUAZIONE
DEL PAPATO
|
A |
lla vigilia del giubileo istituito per la prima volta all’inizio del secolo (che
riscosse un gran successo di pellegrini), Roma (come riferisce Gregorovius) era
turbata da una feroce anarchia, si
combatteva (1292) per la nomina di un senatore, si distruggevano palazzi, si
ammazzavano i pellegrini, si saccheggiavano le chiese; il nepotismo dei papi
aveva dato vita alle due fazioni che dominavano la città, Colonna e Orsini; in
prossimità della Pasqua (1293) erano stati eletti due senatori Agapito Colonna
e Orso Orsini, e la morte di quest’ultimo fu causa di ulteriori lotte.
Il Campidoglio era senza senatori, il
Laterano senza papa in quanto l’anno precedente era morto (1292) il papa Nicola
IV e una feroce rivalità tra fazioni, impediva la nomina del nuovo papa: a qulcuno venne l’idea di fare il nome di un anacoreta che conduceva la vita dell’uomo primitivo in
una capanna tra i monti degli Abruzzi, sul monteMorrone
presso Sulmona; era Pietro di Monte Morrone che da poco aveva fondato l’Ordine
religioso dello Spirito Santo e da lui aveva preso il nome di Ordine dei Celestini.
Tutti furono d’accordo ma la Chiesa fece un
salto indietro di secoli; gli sostituirono gli stracci che indossava dell’’anacoreta,
con la lussuosa tiara papale, gli fu dato il nome di Celestino V e fu condotto
a Napoli dove fu ospitato in una cella do Catsel
Nuovo (Maschio Angioino) costruito dal re Carlo d’Angiò: per quanto avesse
potuto avere grandi doti umane, era assolutamente incapace a goverare la Chiesa.
Alcuni cortigiani si impossessarono del sigillo
e gli facevano firmare tutto ciò che volevano; si diceva che qualcuno (il riferimento
era all’ambizioso cardinale Gaetani, che mirava a sostituirlo), la notte con un
megafono, con una voce che sembrava provenisse dall’al di là, lo invitava a dimettersi.
Il sogno di Celestino V, se egli avesse così
immaginato il paradiso, quello in cui si era trovato, era durato cinque mesi;
date le dimissioni se ne tornò a vivere nella sua capanna; il suo posto lo prese
il cardinale Benedetto Gaetani, che assunse il nome di Bonifacio VIII (1294-1303),
di tutt’altra levatura del papa che sostituiva.
In questi casi non vi possono essere
giustificazioni del tipo del “gran
rifiuto” richiamato da Dante, perché o si è capaci di governare o non lo si
é; ai giorni nostri di esempi di ministri ( p. es. della Salute, che per impreparazione ha fatto morire migliaia di fragili anziani!) o di sindaci (p. es. Roma, che ha fatto morire
la città, nella indifferenza dei romani!), incapaci, ve ne sono a sufficienza: gente
senza pudore e senza dignità, che, con le proprie incapacità non si dimette e rimane imperterrita al
proprio posto.
Celestino V aveva avuto il pudore e la
dignità di dimettersi e questi sono meriti che la storia gli deve riconoscere.
Bonifacio VIII entrava in conflitto con Filippo
IV il Bello (1266-1314), di Francia (il re che aveva annientato i Templari) in
quanto Filippo, in guerra con Edoardo I d’Inghilterra, aveva chiesto danaro alla Chiesa.
Filippo aveva infatti chiesto al clero
francese il contributo per le spese di guerra; ma Bonifacio aveva emanato una
bolla “Clerici laicos”
(1296) che vietava alle autorità di imporre tasse senza l’autorizzazione della
santa sede, aggravata con la sanzione della scomunica; Filippo rispose
bloccando il flusso di danaro ecclesiastico che dalla Francia era mandato a
Roma.
Al momento vi fu una sospensione di questo
provvedimento, ma si aprì una discussione sulla sovranità che il re-imperatore faceva
valere nel proprio regno, come sosteneva Filippo; mentre il papa Bomifacio sosteneva
il principio della sovranità assoluta del papa sui sovrani (che equivaleva alla
teocrazia: il papa rappresentava Dio
sulla terra!), riversato nella bolla “Ausculta
filii” (1302), con la quale il papa indiceva un
concilio a Roma dei cardinali francesi che si trovavano in città.
Filippo a sua volta convocava gli Stati
generali ed era pubblicato un documento con accuse mosse contro il papa e per
di più Filippo inviava in Italia Guglielmo di Nogaret
e Giacomo Colonna (detto Sciarra perché litigioso)
per arrestarlo; il papa si trovava ad Anagni dove fu maltrattato (Sciarra gli avrebbe
dato uno schiaffo) e il papa fu portato dalla folla in rivolta a Roma dove morì
dopo due giorni
(1303) di crepacuore.
Fu eletto papa il francese Bertrand de Got, col
nome di papa Clemente V (1305-1314) il quale si trasferì ad Avignone (poi,
acquistata da Clemente VI (1348), da Giovanna I di Napoli per 80mila fiorini
d’oro); Avignone divenne così sede papale fino a quando il papa Gregorio XI, decideva
(1377) di trasferirsi a Roma; ma moriva l’anno successivo e fu eletto nuovo
papa l’arcivescovo di Bari (Bartolomeo Prignano) col nome di Urbano VI.
Di carattere duro e poco conciliante, la sua
nomina non fu accettata da alcuni cardinali i quali riuniti a Fondi, con
l’appoggio di Carlo V di Francia e Giovanna I di Napoli, elessero (1378) un
altro papa, Roberto
di Ginevra che prese il nome di Clemente VII il quale si trasferì ad Avignone.
Si ebbero così due papi, ognuno con i propri
sostenitori che eleggevano i successori; e così a Roma furono eletti papi: Bonifacio IX
(1389.1404); Innocenzo VII (1404-1406) e
Gregorio XII (1406-1407); ad Avignone dopo Clemente VII, fu eletto l’aragonese Pedro
de Luna, col nome di Benedetto XIII (1394-1423).
La situazione era caotica e un gruppo di
cardinali per mettere ordine indisse il Concilio di Pisa, ma Gregorio XII ne
indisse uno a Cividale del Friuli, mentre Benedetto XIII lo indisse a Perpignan.
A Pisa i due papi furono deposti (1409) e fu
eletto, come unico papa, l’arcivescovo di Milano, Pietro Filargo
(1409) col nome di Alessandro V, che ebbe un solo anno di pontificato e come
successore fu eletto Giovanni XXIII (1410-1415): ognuno di essi rimaneva al suo
posto (secondo il detto “hinc manebumus optime”).
A Pisa si trovava l’imperatore Sigismondo,
re d’Ungheria, nominato re dei Romni il quale persuase
Giovanni XXIII a convocare un Concilio a Costanza (1414-1418) dove gli altri due
papi, Gregorio XII e Benedetto XIII non si presentarono; il Concilio impose
all’antipapa Giovanni XXIII di deporre la sua nomina e questi accettò (1415);
Gregorio XII lo seguì, rinunziando al papato nella speranza di far cessare lo
scisma, mentre Benedetto XIII, che insisteva nel non voler riconoscere il
Concilio, fu sottoposto a processo e fu deposto (1317).
Si procedette quindi alla nomina del nuovo
papa con ventitre cardinali oltre a venti elettori
nominati dal Concilio; risultò eletto papa Oddone Colonna col nome di Martino V
(1417-1431), il quale fu riconosciuto dall’antipapa Giovanni XXIII, non da
Benedetto XIII appoggiato dall’Aragona (dove furono eletti due successori
Clemente VIII e Benedetto XIV).
Il papa Martino V succedeva al legittimo
papa Gregorio XII il quale rimaneva a Firenze i primi due anni e nel 1420 si
trasferiva definitivamente a Roma che da questo momento ritornava sede papale.
Poiché il Concilio ribadiva il principio
della propria superiorità sul papa, Martino V fissava i due Concili di
Pavia-Siena (1423-1424) e Basilea (1431) dove ebbe luogo un ultimo strascico
della nomina degli antipapi; Eugenio IV era deposto (1447) e nominato Felice V
(Amedeo di Savoia), il quale, riconosciuta la irregolarità della propria
posizione, abdicava spontaneamente (1449) chiudendo la serie degli antipapi.
A causa della peste (v. in Art. Le epdidemie nella
storia), il Concilio si trasferì a Firenze (1439). In proposito è da dire
che già dagli anni precedenti erano stati posti i presupposti, tra papa Martino
V e l’imperatore di Bisanzio, del Concilio per la Unione delle due Chiese;
definito il Comcilio di Basilea se ne doveva aprire
uno a Bologna esclusivamente per l’Unione; a causa della peste scoppiata a
Bologna, il Concilio fu trasferito a Firenze e di questo Concilio ne parliamo
negli Articoli dedicati ai Mille anni dell’Impero bizantino.

Concile de Constance
LA
PARTECIPAZIONE
DI
MINUCCI AI
CONCILI
DI PISA
COSTANZA E BASILEA
|
C |
ome scrive Miogliorotto Maccioni, Minucci si era recato al Concilio di
Pisa (1409) dove vi erano turbolenze dovute ai due papi, ciascuno dei quali sostenuto
da un forte partito; a questi due papi (come abbiamo visto), se ne era aggiunto
un terzo che aveva turbato ulteriormente l’unità dell’impero d’Occidente in
quanto ciascuno dei diversi paesi partecipava per un proprio papa.
Dopo la morte
dell’imperatore Carlo IV del Lussemburgo, era stato eletto re dei romani, il
figlio Venceslao il quale non si era recato a Roma per essere incoronato
imperatore, ed essendo di carattere indolente, inetto, instabile e non avendo le capacità di
governare era stato imprigionato e deposto e gli elettori ecclesiastisti
avevano eletto Ruperto-Roberto (elettore palatino) il quale però moriva l’anno
successivo (1410).
Era quindi eletto
re dei romani Sigismondo (sul quale si era abbattuto il movimento ussita della
Boemia), ultimo della casata del Lussemburgo, che aveva mandato al Concilio come
suoi rappresemtanti il cardinale Bessarione, Enea
Silvio, Ambrogio Camaldolense, Leonardo' Aretino, Cristofaro Landino, Andrea
Vicorati e Francesco Aretino, i quali non ricevettero l’attenzione dei padri che
dirigevano il Concilio, essendo sorte turbolenze e contrasti sui poteri del
papa e dell’imperatore; da una parte, infatti, si sosteneva la superiorità della volontà del
papa rispetto al Concilio, tesi appoggiata da
alcuni giureconsulti, mentre altri tra i quali Minucci al contrario,
sostenevano la superiorità dell’imperatore.
Con il comune consenso di
Giovanni XXIII e dell’imperatore Sigismondo ers stato
covocato il Concilio di Costanza (1414.1418) dove
Minucci fu inviato come rappresemtante
dell’imperatore, in compagnia del conte Francesco da Campo; sfortunatamente Minucci
si ammalava per due mesi e l’imperatore
lo aveva ricoperto di onori (nominandolo conte e Consigliere dell’impero); venuto
poi a conoscenza dei suoi studi nel campo degli usi e cosuetudini
feudali, gli chiedeva di emendare i Libri feudali di Oberto dell’Orto e Gherardo
del Negro (di cui abbiamo già parlato).
Già da tempo si
pensava al Concilio
di Basilea (1431-1439) per i contrasti sorti a causa degli ussiti (invitati al concilio
per esporre la loro religione) ed era stato eletto papa Eugenio IV per riparare
in parte i danni che subiva la Chiesa e le varie turbolenze che si agitavano;
lo avevano messo nella necessità di iniziare la sessione di apertura nel mese
di dicembre, invece che nel mese di marzo e si doveva discutere anche della
superiorità del Concilio nei suoi confronti.
Il papa, non
volendo saperne di questo argomento, aveva emesso una bolla con la quale
scioglieva il Concilio, ma l’assemblea non accettava la bolla e nella Sessione
XXXIV, si passò alla sua formale deposizione, dichiarandolo contumace, sinoniaco ed eretico; ma con l’intervento pacificatore di
Sigismondo i lavori del concilio proseguirono negli anni successivi
(1431-1443).
Furono molti i principi
che intrevennero al Concilio e molti gli oratori e i giureconsulti
inviati, fra i quali si distinsero Lodovico Romano e l’abate Panormitano (*) ed altri di fama.
Vari erano gli
argomenti che si discutevano in Concilio; da parte dell’Imperatore Sigismondo, si
sosteneva che il Concilio era stato convocato con suo editto e il Minucci sosteneva
che solo all’Imperatore apparteneva il diritto di convocare il Concilio, a
causa della superiorità delle ragioni che riguardavano i diritti
dell'Imperatore, che si dovevano ritenere superiori a quelle sostenute dal
pontefice nel Comcilio, come confermavano molti giureconsulti,
per provare la preminenza del Concilio sul Pontefice. e Minucci, per conto
dell’imperatore sosteneva le ragioni imperiali, che consistevano appunto nel
diritto dell’ imperatore a convocare il Concilio (in
proposito Enea Silvio nella sua Storia di Boemia riteneva Sigismondo di cuore facilmente pieghevole operando
molto in
favore e contro il Concilio,
danneggiando la Chiesa).
Oltre a questa
incombenza che riguardava l’imperatore Sigismondo, Minucci ne aveva altre che
riguardavano il re Alfonso d’Aragona e altra ancora per
la Repubblica di Venezia; mentre infatti il re Alfonso. impugnava la qualità feudale
del Regno di Napoli, e ne contestava l’investitura fatta dalla Chiesa romana; la
Repubblica di Venezia disputava di alcuni Feudi col patrarca
di Aquilea.
Era stato appena
eletto il papa Eugenio IV (veneziano Gabriele Condulmer 1431-1434) dalle
turbolenze che agitavano il Concilio, ne era intimorito e procurò di unirsi a
Sigismondo (come abbiamo detto egli era solo re dei romani in quanto non era stato ancora incoronato, e fu incoronato
imperatore a Roma proprio dal papa Eugenio 1433, ma morì all’improvviso il 1437
(**)); Sigismonodo era di carattere accomodante e con
il papa si trovarono d’accordo “in modo
che tutto si accomodò tra i Padri adunati in quell' assemblea”.
Il re Alfonso era
apertamente contrario al pontefice, approfittava del Concilio per contestare il
potere del papa rispetto a quello del Concilio e aveva sollecitato molti giureconsulti
a scrivere contro l'autorità del Papa e sostenere appunto la superiorità del
Concilio su di lui.
Per sostenere le
ragioni di Alfonso, a Basilea
era stato mandato il Minacci, il quale era ritenuto contrario ai
diritti del papa, a causa di un vecchio risentimento nei confronti del patriarca
di Alessandria, sorto quando il conte Francesco di Poppi durante un’assenza del
patriarca si era impadronito del Borgo S. Sepocro
nel Casentino, che apparteneva alla Chiesa e la Repubblica fiorentina aveva
dovuto mandare Alessandro Alessandri con l’esercito per risolvere questione.
Minucci era molto stimato per la sua dottrina e in grado di
sostenere la tesi contraria a quella sostenuta dal papa, sulla quale si
discuteva già dai tempi di Clemente IV (***) che il Regno di Napoli si riteneva
fosse feudo della Chiesa.
La tesi del Minucci,
era che il Papa non aveva alcun diritto di vassallaggio sul regno, non tanto perchè non avendolo mai posseduto, non poteva neanche trarsferirlo, quanto perchè le Consuetudíni Feudali non accordavano tali diritti,
se non all'Imperatore; e se (tali
diritti) erano stati praticati, non potevano
produrre alcun effetto per il decorso del tempo, in quanto sostenuti dalla mala
fede: dal che derivava che la prescrizione non poteva aver luogo, sia
perchè si richiedeva la buona fede fin dall'origine, sia perchè
questi diritti non ptevano essere prescritti, nè si poteva ottenere con la forza ciò che sia per le leggi, sia per le consuetudini dei feudi era riservato
all' imperatore”.
A causa dello
strepito, della confusione e della discordia e dei gravi disordini che regnavano
nel Concilio, su questo argomento non vi fu alcuna risposta!
*)
L’abate Panormitano, Nicolò Tedeschi (1386-1445),
tedesco di origine, aveva scritto un “Trattato
fopra la superiorità del Concilio”, e poi scrisse
in favore del Pontefice contro il Concilio, e quindi nuovamente impugnò le
ragioni del Papa per sostenere la Giustizia de Padri di Basilea. Similmente
Nicolò Cusano che avea tenute le parti del Concilio,
per la speranza del cardinalato si indusse a sostenere le parti d'Eugenio
(Richer, Historia Concili)
**)
Queste morti improvvise di imperatori o grandi personaggi che dal Nord si
recavano a Roma erano spesso dovute al clima pestifero di Roma che provocava la
malaria, dalla quale non erano colpiti coloro che vivevano nel territorio in
quanto ne erano naturalmente vaccinati.
***)
Clemente IV 1265-1268) era il papa che aveva offerto il regno di Napoli a Carlo
d’Angiò ma la questione del vassallaggio dei re del regno di Napoli risaliva a
oltre due secoli prima quando Roberto il Guiscardo dopo la battaglia di
Civitella (18.6.1053) era stato acclamato duca dai suoi soldati, titolo che il
papa Nicola II gli confermava al Concilio di Melfi (1059); sin da allora era
stato stabilito un censo di dodici denari per ciascun paio di buoi, o
sia per ogni estensione di tanto terreno quanto arar ne possa in un giorno un paio
di buoi; censo che rimarrà, cambiando nel tempo le modalità del suo
versamento; con il giuramento Roberto assumeva la difesa della Chiesa romana e
della persona del papa, attesi i pericoli ai quali (specie in quel periodo) era
esposto.
Ruggero
II, con la bolla del papa Anacleto (antipapa), del 1130, aveva ricevuto coronam regni della Sicilia, Calabria, Apulia oltre al principato di Capua
e ducato di Napoli che neanche gli spettavano.
Si
trattava di un abuso del papato che si considerava proprietario di quei
territori, abuso che era comunque acecettato con la contropartita
del censo, per la convenienza che avevano i re a ricevere la corona sulla
propria testa da
parte dei papi.
FINE