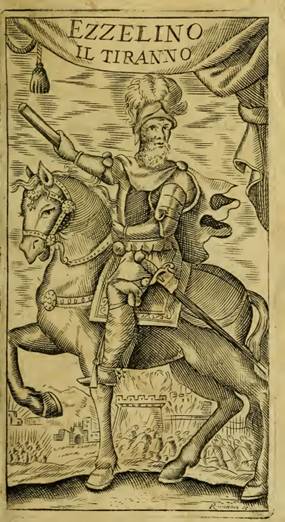
“Tu Ezzelino
spavento d'Italia,
d'ogni scelleratezza
abominevole esempio,
novello Falaride
del genere umano,
mostro e tiranno,
nella tua infamia, maledetto,
vivrai immortale” *
*) Epigrafe dello storico Carlo Leoni (1812-1872) per ricordare la tirannide di Padova che fu più lunga e fiera che altrove e perpetuare l’odio dei padovani contro il tiranno.
EZZELINO DA ROMANO
“MOSTRO E TIRANNO
MALEDETTO”
SOMMARIO: IL CASPOSTIPITE DEGLI EZZELINI; ECELO PRIMO DEGLI EZZELINI DETTO IL BALBO; EZZELINO II IL MONACO; EZZELINO II E LE PRIME CONQUISTE; L’ASSASSINIO ALLA FESTA DI VENEZIA E LA PACE FATTA DALL’IMPERATORE; LE CRUDELTA’ DEL SECOLO; EZZELINO III IL TIRANNO: SUE CRUDELTA’ VERE O PRESUNTE; LE SUE MOGLI E LE SUE DONNE; LA SCOMUNICA; MORTE DI EZZELINO III; LA SUA ANIMA E IL DIAVOLO; IL TESORO E LE GALLERIE; ALBERICO DA ROMANO; ALBERICO SI RITIRA A SAN ZENONE - LA CRUDELE SENTENZA; RESA DI ALBERICO – SUO DISCORSO AI FIGLI E AL SEGUITO; LA STRAGE DELLA FAMIGLIA; CRONOLOGIA DELLE GUERRE E CONQUISTE DI EZZELINO III.
IL CAPOSTIPITE
DEGLI EZZELINI
|
A |
voler tracciare le origini degli Ezzelino si cade in un profondo abisso in quanto dai numerosissimi cronisti e storici (elencati da Giambattista Verci, in “Storia degli Eccelini”, Venezia 1841) si hanno altrettante versioni che divergono l’una dall’altra, alcuni di essi retrodatando la venuta del capostipite che sarebbe stato un Alberico d’Olanda (provincia della Germania) e sarebbe venuto con l’imperatore Ottone III (984-1003), portando con sé il figlioletto Ecelino Tedesco o addirittura che fosse stato Ecelino II il Balbo o un Alberico a venire in Italia, mandati dall’imperatore Enrico III (1016-1096).
Tra tutte le ipotesi risulta da due documenti di vendita e uno di privilegio (1091) dell’imperatore Enrico in cui è espressamente indicato Eceli de Aunaria, che si dichiarava di legge salica (o franca, in quanto all’epoca si seguiva la legge del dichiarante che poteva essere romana, franca-salica e longobarda); secondo Rolandino (contemporaneo del III, anche se criticabile su qualche punto, come il Monaco di Padova, molto più fanatico e fazioso del primo, che citiamo sotto, in quanto ambedue cristiani e quindi guelfi), il quale indica come capostipite della dinastia degli Ezzelini è stato Ecelo I o Ezelo (*) figlio di Arpone, venuto in Italia con Corrado II il Salico (990-1039) il quale in una prima occasione, si era recato a Milano (1026) per essere incoronato re d’Italia e a Roma (1027) per essere incoronato imperatore e in una seconda occasione (1036), per un sinodo a Pavia e Ecelo avrebbe chiesto all’imperatore di potersi fermare e Corrado, in ogni caso, gli aveva assegnato i feudi di Onara e Romano.
Ecelo si stabilì a Onara per cui gli Ezzelini fino a Ezzelino II il Monaco portavano il nome “da Onara”, successivamente i padovani distrussero il castello (1199) fino alle fondamenta e Ezzelino si trasferì a Romano (a tre miglia da Bassano) nei cui pressi vi era un castello quasi inespugnabile, su collina a pianta quadrangolare e mura in doppia cinta, con torri, spalti e baluardi; tra una cinta e l’altra vi erano le abitazioni della guarnigione; nella cinta interna sorgeva il palazzo oltre a una grossa torre; in seguito, dal vescovo di Vicenza ebbe anche quelli di Bassano, Angarano e Castigliano (tutti facenti parte della Marca Trevigiana) e da questo momento gli Ezzelini divennero “da Romano”.
Cantù si chiede: Come trova Ecelo l’Italia? La sua risposta è: Come un caos! “L’Alta Italia era tutta divisa in feudi, quelli più consistenti al confine, poco a poco prendevano i più piccoli; la Marca Trevigiana fino ai deliziosi Colli euganei, costellati di castelli come nidi abitati dai feudatari che vivevano riconoscendo solo le proprie leggi; il feudo per possederlo occorreva difenderlo e combattere stando sotto la soggezione del sovrano”.
Divenuto signore di Onara, Ecelo vi pone la sua abitazione, sposa la longobarda Gisla, dalla quale ha due figli Ezzelo, chiamato con diminutivo Ezzelino, e Alberico; di lui non si sente più parlare dal 1091 data probabile della sua morte.
Egli corteggiava gli imperatori che gli concedevano onori e poderi e gli confermavano quelli usurpati, mentre dal suo canto, per essere in grazia con gli ecclesiastici, largheggiava in donazioni e non si trattava di piccole donazioni, in quanto, d’accordo con i fratelli Camposampiero con cui si imparenteranno (ma ciò non gli impediva farsi guerre o assassinarsi!), per suffragio alla sua anima (sistema raccomandato dalla Chiesa che così concedeva l’eterna salvezza dell’anima, qualunque fossero stati i delitti compiuti), Tiso, Gerardo, anch’essi primi dei Camposampiero (il cui padre, Tiso sarebbe venuto in Italia con Ecelo), donavano alla Badia di Santa Eufemia da Villanova, centosessantotto masserie con bestie servi e ancelle.
*) Cantù ritiene che fosse Hetzen, cacciare e Rolandino lo indica come Ecelo I;
la differenza di numerazione che si riscontra tra gli storici consiste nel fatto che alcuni, li hanno numerati in base alle quattro le generazioni, e Rolandino (per il quale Ezzelino il Tiranno è III e non IV), essendosi fondato sulla numerazione dei nomi, principio generalmente sempre applicato nelle famiglie dinastiche; pertanto, stipite dempto, vale a dire tolto il capostipite Ecelo I egli incomincia a contare gli Ezzelini da Ezzelino il Balbo considerandolo primo, mentre (secondo Verci che si rifà a Maurisio, contemporaneo e amico degli Ezzelini) da Ecelo I a Ezzelino il Balbo sarebbe stata saltata una generazione intermedia in quanto vi sarebbe stato un Alberico padre del Balbo (che sarebbe stato il III) e questo padre dei due fratelli Alberico e Ezzelino.
In quest’ultimo caso è da ritenere che nelle famiglie dinastiche la numerazione ha sempre seguito i nomi, non le generazioni, con la conseguenza che se vi fosse stato un Alberico padre di Ezzelino (di cui nessun altro ne parla!), Alberico sarebbe stato Alberico I, per cui è da ritenere giusto chiamare il capostipite Hetzen-Ecelo I e Ezzelino il Balbo (col nuovo nome!) è I (il Balbo), segue il II (il Monaco) e il III (il Tiranno), come d’altronde si vede indicato nella stampa di cui all’immagine riprodotta nel par. dedicato a quest’ultimo;
ECELO
PRIMO DEGLI
EZZELINI
DETTO IL BALBO
|
D |
ei due figli, Alberico e Ecelo, il primo morì senza figli, Ecelo poi detto Ecelino e quindi Ezzelino, considerato il I degli Ezzelini; questo primo degli Ezzelini, detto il Balbo, era stato crociato in Palestina (1147) con l’imperatore Corrado III, combattendo a Damasco e Ascalona; al ritorno fece parte della Lega Lombarda.
Era saggio, liberale e “moderatamente truce e orrido” nel confronti dei rei; ricchissimo, aveva palazzi a Vicenza, uno merlato in via Colle, poi convertito nella chiesa e convento dei domenicani, in Treviso in piazza Duomo, a Padova in contrada Santa Lucia e a Bassano.
Alla discesa di Federico Barbarossa, unitosi con Anselmo di Dovara fu nominato capitano generale delle città collegate nella Lega Lombarda e prima di muovere guerra indusse l’imperatore a un compromesso che però non ebbe alcun esito e si giunse alle battaglie di Alessandria e Legnano (1176) in cui Federico I fu sconfitto giungendo alla Pace di Costanza (1186), in cui l’imperatore riconosceva la Lega Lombarda e i Comuni che la componevano.
Nei Comuni, scrive Cantù, si rinchiusero i feudatari, che portavano l’orgoglio della razza e l’abitudine a comandare senza sottoporsi alle leggi ma soltanto alla forza, ed Ezzelino fu uno di questi; successivamente fortificati nelle città, continuarono a fare ciò che avevano fatto nei loro feudi.
Ezzelino il Balbo in occasione della pace di Costanza (1183) fu ricevuto dall’imperatore Federico Barbarossa che gli rimetteva ogni offesa.
A questo primo Ezzelino nacquero quattro figli, Giovanni e Gisela che non lasciarono memoria, Cunizza che sposò Tisolino della famiglia di Camposampiero e un altro Ezzelino che sarà il secondo della dinastia, detto il Monaco.
Anche lui aveva beneficato i monaci: cento lire e un cero, oltre a centoquaranta zecchini d’oro per una messa solenne annuale e cento soldi da distribuire ai chierici e poveri che vi assistessero: cinque soldi a ogni monaco per messa, e due soldi ciascuno per cinquanta altri sacerdoti.
EZZELINO II
DETTO
IL MONACO
|
E |
zzelino II (1194-1259) ci è stato descritto lontano da qualsiasi ambiguità, mostrandosi sempre molto chiaro nei fatti e molto prudente, contenuto nei costumi, con una particolare superiorità nell’eloquenza.
Aveva avuto quattro mogli, la prima Agnese dei marchesi d’Este, morta di parto; la seconda, Speronella, figlia di Delesmanno e sorella di Delesmanino, è stata descritta come una donna dalla morale piuttosto spregiudicata, facile nel cambiare i propri uomini, anche se questi erano mariti regolarmente sposati.
Essa infatti, giovinetta di quattordici anni era già maritata a Giacopino da Carrara, quando a Padova Federico Barbarossa aveva nominato come suo luogotenente (1165); un conte Pagano, odiato dai nobili e dal popolo, dopo averle messo gli occhi addosso, la rapì e la sposò.
I suoi parenti indispettiti, decisero di vendicarsi e alla vigilia del giorno di san Giovanni, Pagano, pur trovandosi nel castello sulla rocca di Pendice, posta sui colli Euganei tra Torreglia e Teolo, su una cima rocciosa inaccessibile, ma, non avendo soldati per difendersi, la cedette ai padovani che esultanti, ogni anno festeggiavano quel giorno l’avvenimento.
Liberata da Pagano, Speronella sposò un esponente della famiglia Traversari, che aveva poi abbandonato, per unirsi a Pietro da Zaussano, col quale rimase tre anni, ma poi se ne fuggì legandosi a Ezzelino che la prese in moglie “per bella e per buona”!
Speronella era con Ezzelino quando un giorno questo si recava a Monselice a far visita a Olderico da Fontana dal quale era stato accolto con gran cortesia e con tante attenzioni; tornando a casa, Ezzelino, non solo aveva raccontato alla moglie delle accoglienze che gli erano state riservate, ma imprudentemente si era spinto a raccontarle “delle fattezze fisiche di Olderico e le sue maschie bellezze” che gli aveva visto nel bagno!
“Sconsiderato”!, commenta lo storico; “la mal onesta donna ne venne in tanto desiderio che con messaggi si intese con Olderico, col quale fuggì da Ezelino e a Monselice godette della sua mal lodata vigoria”!
Speronella visse cinquantun anni “di vita scostumata”, e morendo, per farsi perdonare i peccati commessi, lasciò legati pii a chiese e ospedali (tra l’altro cento lire per edificare una casa per i poveri sul Monte della Stufa (così detto, forse per avere le stanze riscaldate dai vapori termali di Abano).
Perduta la moglie, Ezzelino senza grande rammarico, pensò di prendere un’altra moglie; in quei giorni (1167) era morto Manfredo d’Abano (erroneamente considerata dei conti da Baone) che aveva considerevoli ricchezze, lasciando ereditiera una figlia quattordicenne, Cecilia d’Abano, .
Raggiunti i vent’anni il suo tutore, Spinabello da Landrigo propose a Tisolino di Camposampiero di prenderla come moglie per il figlio Gerardo; Tisolino accettò ma volle consultare gli amici, tra i quali il suocero, Ezzelino il Balbo, ancora vivente.
Questo, approfittando della confidenza, pensò che Cecilia potesse andar bene per suo figlio e fece sapere a Spinabello che gli avrebbe dato una maggior ricompensa se avesse fatto sposare Cecilia con suo figlio; Spinabello accettò e mandò con una grossa scorta Cecilia a Bassano dove fu fatto un solenne matrimonio.
I Camposampiero si prepararono alla vendetta e un giorno che Cecilia cavalcava con poca scorta, Gerardo Camposampiero le va incontro e invitandola come parente, la condusse nella propria casa e la violentò (1175); il giorno seguente rimandò Cecilia da Ezzelino col seguente messaggio “digli che l’ho sempre onorato e se persevera a comportarsi in questo modo, questa volta mi sono lordato del suo onore, la prossima mi laverò nel suo sangue”.
Iniziarono così le inimicizie tra le due famiglie, con il sangue da cui fu bagnata tutta la Marca; Ezzelino ripudiò Cecilia che sposò un esponente della famiglia Ziani di Venezia (o secondo altri un Guidotti da cui ebbe due figli, Giovanni e Ansedisio).
Ezzelino a sua volta sposò Adeleisa (o Adelaide) sorella dei conti Mangoni di Toscana, detti conti Rabbiosi, da cui aveva avuto due femmine, Palma Novella sposata a Alberto di Baone e Emilia o Imia, sposata ad Albertino de’ Conti, governatore di Venezia, Sofia maritata a Salinguerra Torelli di Ferrara, Cunizza (v. sotto Par. Le sue mogli ecc.), maritata al conte Riccardo di Sambonifazio e due maschi, Ezzelino e Alberico.
La bella Adeleisa era dedita alla “astrologia giudiziaria” (v. in Articoli: I primordi dell’averroismo ecc. P. I) e “almanaccando le congiunzioni, le case, gli influssi dei pianeti, esponeva in versi le sue profezie, oscure quanto bastava, perché potessero, dopo l’avvenimento, essere prese per veritiere”; costei, avendo indovinato ciò che avrebbero fatto i suoi figli “ebbe un tal crepacuore, che non fu più vista sorridere”.
Da questa sua fama di astrologa e dalle atrocità commesse da Ezzelino era sorta la leggenda che i due figli erano stati concepiti dal Diavolo e su questa trama Albertino Mussato aveva scritto la tragedia “Eccerinis” (v. in Schede S. Gli Eccerini nella tragedia dimenticata di Albertino Mussato).
Ezzelino II, capo del partito ghibellino nella Marca Trevigiana, dopo aver partecipato a tutte le guerre di quel periodo, si ritirò convento (v. sotto), per questo gli fu attribuito il sopranome di “Monaco”.
EZZELINO II
E LE PRIME
CONQUISTE
|
N |
ella divisione dell’Italia tra guelfi e ghibellini (i primi sostenitori del papa, i secondi dell’imperatore), nella Marca (Trevigiana), Ezzelino era ghibellino, mentre la parte guelfa faceva capo ai marchesi d’Este denominati marcheschi, e le due fazioni erano in continua lotta e ogni volta al suono delle campane accorrevano e si riunivano gli uomini dai diciotto ai sessant’anni che prendevano le armi, si chiudevano case e botteghe, si sbarravano le strade e le piazze si combatteva devastando i campi, sviando le acque dei mulini, distruggendo i ponti e la battaglia terminava con il saccheggio.
Nella Marca dominavano cinque famiglie: gli Estensi che dal Polesine estendevano il loro dominio nella Marca di Verona, nel cremonese, parmigiano, lunigiana, modenese, piacentino giungendo fino a Tortona dove confinavano con i Monferrato; i Sambonifazio (o San Bonifacio) che sebbene conservassero il titolo di conti di Verona avevano perso l’autorità dei propri avi prima che la città si affrancasse, erano guelfi, mentre i Montecchi che dominavano quelle colline erano ghibellini; i da Camino (dei quali Rolandino indica due fratelli Guecello e Biaquino) possidenti nel trevigiano, in lotta o in lega con Conegliano e Ceneda; e infine i Camposampiero, famiglia tedesca, il cui capostipite sarebbe venuto con l’imperatore Enrico II il Santo (secondo altri sarebbe venuto con Ecelo I, v. sotto), che prese il nome del castello che innalzò presso l’antica chiesa di san Pietro (1025), a dieci miglia a nord di Padova.
Tra costoro i più famosi divennero i da Romano che si ingrandirono man mano che gli altri decadevano e Ezzelino II ne approfitta per acquistare il dominio sulle città della Marca cominciando da Treviso, da dove però fu bandito; divenne invece potente a Verona, appoggiando i Montecchi e osteggiando gli Estensi e i Sambonifazio; fu invece osteggiato a Vicenza e nonostante avesse funestato la città con sangue e incendi, dovette ritirarsi; si precipitò quindi a Bassano che si trovava sotto i vicentini ma la città voleva passare sotto la protezione di Padova e per sottrarsi ai vicentini favorì Ezzelino al quale fu concessa la protezione ... che equivaleva alla signoria!
Questa però non durò molto; Ezzelino non riusciva a vendicarsi dell’offesa recata alla moglie Cecilia dai Camposampiero (v. sopra), più forti in quanto alleati con gli estensi; essi fecero pressione sulla Lega Lombarda perché Ezzelino restituisse Bassano a Vicenza (1194); Ezzelino spinse i bassanesi contro le forze degli estensi e dei Camposampiero, ma costoro ebbero la meglio e lo costrinsero a consegnare un figlio in ostaggio e Bassano ai vicentini; Ezzelino dopo poco si riappropriò della città ma gli furono distrutti i poderi e il castello di Onara (1199), che divenne un altro motivo per Ezzelino di vendicarsi dei Camposampiero che ebbe la possibilità di farlo.
La famiglia di Tisone Novello (Camposampiero) era in possesso del castello di Campreto (nei pressi di Loregia sul confine tra Padova e Treviso), dei Camposampiero; Tisone aveva una sorella, Maria, col quale non correvano buoni rapporti; essa voleva togliersi dalla soggezione del fratello e voleva avere per sé tutto il castello, ma non avendone alcun diritto si offrì a Ezzelino che non cercava di meglio!
Ezzelino che non aveva scrupoli, dopo aver avuto da Maria una figlia, Adelaisa, si rivolse ai messi imperiali, ottenendo il riconoscimento della proprietà del castello; egli a questo punto volle disfarsi di Maria, per cui mise in giro la voce di averla colta in fallo con uno di bassa estrazione e la mandò via; i parenti di Maria fecero ricorso alle armi con le solite distruzioni di guerra che duravano, a lungo quando intervenne il vescovo di Padova, Gerardo, il quale riuscì a metterli d’accordo, ma soltanto per poco, in quanto le condizioni assunte per mezzo del vescovo erano male osservate ... e a questo punto non rimaneva altro che ricorrere agli assassini!
L’ASSASSINIO
ALLA FESTA
DI VENEZIA E
LA PACE FATTA
DALL’IMPERATORE
|
A |
Venezia era stata annunciata una festa (lo storico commenta che le feste erano un’astuzia del governo per far dimenticare al popolo i diritti che gli rapiva e per incrementare il commercio in quanto in queste occasioni si comprava e si vendeva!); alle feste partecipavano i nobili che facevano sfoggio di tutto il loro lusso e il popolo; alla festa (1206) volle partecipare Ezzelino con un gran seguito di famigli e undici cavalieri, tutti vestiti alla stessa maniera, ad esclusione dei mantelli, che per questi erano foderati di pelliccia di vaio di Schiavonia, mentre quello di Ezzelino era di ermellino; il giorno successivo, Ezzelino aveva scambiato il suo mantello con quello di uno dei cavalieri, come si faceva per gioco e mentre passeggiavano per la vecchia piazza san Marco, furono assaliti e il cavaliere che portava l’ermellino, preso per Ezzelino, fu ucciso; i mandanti erano il marchese d’Este e Gerardo Camposampiero.
Ezzelino tornato nelle sue terre, pensava a vendicarsi; i Montecchi (o Monticoli) erano stati scacciati da Verona dal marchese d’Este, divenuto podestà; Ezzelino raccolse uomini e unitosi al potente Salinguerra da Ferrara, assalì Verona che con la cacciata del marchese ritornò ghibellina e a Ferrara prese il dominio Salinguerra; il marchese non si arrende; raccoglie un enorme numero di armati dalla Lombardia, dalla Romagna, dal veronese e da Mantova e il giorno di san Michele entra in Verona e dopo combattimenti per le strade respinge i Montecchi e distrugge case e poderi; i Montecchi furono rinchiusi in un castello del Garda, ma Ezzelino non riuscì a liberarli.
Nel frattempo giunse l’imperatore Ottone IV di Brunswick (1175-1218) che si recava a Roma (1209) per essere incoronato, il quale venne a sapere del violento dissidio tra Azzo d’Este e Ezzelino; quest’ultimo fu chiamato dall’imperatore ed egli si recò presso il suo accampamento, ricevuto con tutti gli onori e ospitato in una magnifica tenda accanto al padiglione imperiale e trattato con molta dimestichezza; al campo giunse anche il marchese Azzo d’Este, accolto ugualmente in maniera cortese per la parentela che correva tra di loro (vantavano comune discendenza da Alberto-Azzo II (996/1009-1097) stipite dei guelfi italiani e dei tedeschi Welfen; i due ospiti erano seduti insieme all’imperatore quando Ezzelino alzatosi espose tutti i torti ricevuti dal marchese.
L’imperatore per rappacificarli li aveva portati con sé in una passeggiata a cavallo e mentre cavalcavano, rivoltosi a Ezzelino gli disse in lingua romanza: “Sir Ycelin, salutem li marches”, ed Ezzelino toltosi il cappuccio disse: “Signor marchese Dio vi salvi”; e il marchese, rivolto a Ezzelino gli disse, “salutèm Ycelin” l’altro a testa coperta (glielo consentiva il grado), “Dio vi salvi” e Ezzelino: “Così voi”: e la pace fu fatta.
Mentre proseguivano, giunti a uno stretto sentiero l’imperatore cavalcava davanti, gli altri due dietro e conversavano tanto amichevolmente, all’imperatore venne il sospetto che tramassero contro di lui non fidandosi della loro lealtà; gli fu risposto (vero o falso!) di aver parlato della loro antica amicizia e di lui che era il più mansueto e virtuoso e nello stesso tempo il più austero e tremendo dei monarchi!
Fatta la pace, confermata da sacro giuramento, l’imperatore fece rilasciare da Azzo i prigionieri di Ezzelino nominando questo podestà di Vicenza; Ezzelino appena assunta la carica, bandì perfidamente il perdono per i nemici che aveva in quella città, dei quali se ne era presentata una parte si era ... ma furono tutti arrestati; quelli che erano scampati presero le armi e la pace voluta dall’imperatore ebbe termine!
Ezzelino ottenne dall’imperatore Bassano (1211) e questo fu l’inizio della futura potenza; egli ebbe dall’imperatore altri favori, mentre le città lombarde con lo stesso Azzo d’Este si rivoltarono contro l’impero; in questo frangente, la potenza di Ezzelino aumentava quando i suoi due nemici, il conte Sambonifazio e il marchese d’Este, morivano prematuramente (1212); ne approfittò Ezzelino che vittorioso sui nemici ottenne la pace; ma le paci a quei tempi, nonostante sacralizzate con giuramenti, non erano fatte per durare e si ricorreva alle armi anche per futili motivi, tanto futili che era scoppiata una guerra tra Firenze e Pisa a causa di un catellino (*); le cose non cambieranno nel periodo del regno del re Sole che per una questione di precedenza tra ambasciatori francesi e spagnoli, questi avevano preteso di avere la precedenza e Luigi XIV aveva minacciato una guerra se non fosse stata riconosciuta la precedenza agli ambasciatori francesi.
Ezzelino, giunto il giorno in cui si avverte che la vita sta per allontanarsi dal corpo, chiese al papa il permesso di ritirarsi in convento secondo l’uso invalso in quei tempi, dei signori, che dopo aver commesso ogni specie di assassini e delitti, andavano a dedicarsi alla preghiera o lasciavano consistenti ricchezze quale “tantundem” per la salvezza dell’anima (come abbiamo visto aveva fatto Speronella); avuto il permesso Ezzelino si ritirò nel monastero di Oliero nel vicentino.
Ezzelino però, per il suo carattere e per la sua personalità che non era riuscito a adattare al nuovo abito indossato, non adeguandosi alla umiltà della normale vita monastica e rimanendo dentro di sé un ribelle; si era infatti dedicato allo studio delle Sacre Scritture, che potrebbe apparire cosa normale per un monaco, ma il problema era sorto nel momento in cui egli aveva tratto opinioni teologiche del tutto originali, che sfociavano nell’eresia; fu così scomunicato dal papa e dopo poco tempo moriva (1225).
*) Per catellino si intendeva in genere un cagnetto di piccola taglia (definito da sala o da salotto), che di norma avevano le regine e i cardinali,
Racconta il Villani che all’incoronazione di Federico II (1220) giunsero a Roma ambascerie da tutta Italia tra le quali quelle di Firenze e Pisa; un cardinale di Roma per onorare gli ambasciatori di Firenze li invitò a pranzo; costoro, recatisi a pranzo videro un bel “catellino” che l’ambasciatore, invaghito, chiese in omaggio e il cardinale gli disse che poteva mandarlo a prendere quando desiderasse.
Il cardinale aveva successivamente invitato a pranzo l’ambasciata pisana e anche l’ambasciatore pisano si invaghì del “catellino”, chiedendolo in dono; il cardinale, dimenticando di averlo già offerto all’ambasciatore fiorentino, gli disse che poteva mandarlo a prendere; nel frattempo l’ambasciatore di Firenze mandò a prendere il catellino e quando l’ambasciatore pisano mandò a prenderlo, si sentì dire che lo aveva preso l’ambasciatore di Firenze.
L’ambasciatore pisano non sapendo come erano andate le cose, pensò che il collega di Firenze lo avesse fatto per “onta e dispetto”, e quando si incontrarono in Roma, l’ambasciatore pisano richiese il catellino con parole villane; dalle parole fecero ricorso alle spade e i fiorentini furono in un primo momento messi a mal partito e svillaneggiati; accorsero quindi cinquanta soldati che avevano accompagnato l’ambasciatore di Pisa, e, nello stesso tempo accorsero tutti i fiorentini che erano alla corte del papa e dell’imperatore e quelli che si trovavano a Roma, che erano tanti, alla testa dei quali si mise Oderico de’ Fifanti e i pisani furono sopraffatti.
I pisani scrissero a Pisa dicendo che erano stati sopraffatti e svergognati dai fiorentini; immediatamente il Comune di Pisa fece sequestrare tutte le mercanzie dei mercanti fiorentini, che erano in gran quantità; i fiorentini mandarono ambascerie che pregavano i pisani, in nome dell’antica amicizia, di restituire ai loro mercanti le mercanzie, anche versando del denaro e in caso contrario, minacciando la guerra; i pisani non accettarono e sentendosi signori del mare e della terra risposero che accettavano la guerra, alla quale diedero inizio i fiorentini contro i pisani; i primi andarono ad assalire la città di Pisa e vi fu la battaglia di Castel Bosco (1222) con una gran quantità di morti, in cui i pisani furono sconfitti.
Villani fa notare che questo stato di cose non riguardava solo Firenze e Pisa che per la bellezza di un cagnolino si faceva una guerra, ma valeva per tutta l’Italia e massimamente per la Toscana.
LE CRUDELTA’
DEL SECOLO
|
S |
e Ezzelino era nato con inclinazioni tiranniche, l’ambiente in cui all’epoca si viveva era piuttosto favorevole alle efferatezze compiute da tutti coloro che intendevano affermare il proprio potere; in particolare Ezzelino aveva attratto l’attenzione sul suo nome, a causa delle “imprecazioni di preti e frati, delle scomuniche di papi e ancor più terribili, delle maledizioni delle popolazioni: indicato come emulo di Nerone e di Attila e sinonimo di quanto empio, crudele, barbaro e bestiale abbia saputo immaginare la fantasia di un demonio”.
Ma in quell’epoca le crudeltà erano la norma; il secolo era quello in cui Azzo VII d’Este, capo dei Guelfi che portavano il segno della bontà cristiana, la croce sul petto, faceva strappare gli occhi e tagliare il naso a Gerardo (custode di Ezzelino) che per tradimento gli aveva consegnato Monselice, e in queste condizioni Azzo lo rimandava al suo nemico Ezzelino.
Lo stesso Azzo, preso il castello della Fratta, commetteva le più orrende crudeltà non risparmiando donne e fanciulli; il monaco fra’ Giovanni da Vicenza, mandato da papa Gregorio IX a Verona per metter pace tra tutti i signori della Marca (1233), in tre giorni faceva bruciare vive sessanta persone tra i migliori cittadini di Verona, “che avevano il torto e il coraggio di non pensarla come lui”, accusati di eresia, non solo, ma, dopo aver fatto prediche in molte città che avevano attirato su di lui l’ammirazione d tutti e dopo aver fatto firmare la pace di Paquara, si era recato a Vicenza e entrato nel consiglio della comunità, disse che voleva essere lui il signore e conte di quella città e di disporre di ogni cosa a suo piacimento, come fece cambiando gli antichi statuti e facendone di nuovi. Poi si recò a Verona dove si fece eleggere signore della città, richiedendo ostaggi per la sicurezza della sua persona, gli furono consegnati i castelli di Sambonifazio, Ilasio, Ostiglia e le fortezze della città; avuti gli ostaggi, mosse guerra agli eretici, facendone bruciare sessanta, come abbiamo già detto e comportandosi da padrone.
La città di Padova che voleva signoreggiare su Vicenza, non aveva accettato queste novità e spinse il podestà a sollevarsi e cacciare fra’ Giovanni dalla città; il podestà, istigato anche da Uguccione Pileo e dai da Camino, fece venire soldati da Padova e fortificò Vicenza contro le forze del nuovo conte; fra’ Giovanni però raccolte delle truppe corse a Vicenza dove il popolo gli andò incontro; entrato in città chiese che gli fossero consegnate le case, le torri e tutti i forti e i suoi seguaci si recarono presso il podestà e dopo aver distrutto tutti gli statuti fatti da lui, lo scacciarono; ma arrivarono Uguccione Pileo con le schiere dei padovani che riuscirono ad avere il sopravvento sulle forze di fra’ Giovanni, facendolo prigioniero; rilasciato dopo alcuni giorni, si recò a Verona, dove si rese conto di aver perso il suo carisma e si vide costretto a restituire i castelli avuti in ostaggio, escluso quello di Ostiglia, dove aveva messo a difesa dei bolognesi; ma quando vi giunse non fu fatto entrare e fu respinto, per cui, vista perduta tutta la sua autorità, afflitto, se ne tornò a Bologna e una volta partito la pace di Paquara venne a cadere e le guerre tra i vari signori ripresero, come riferiamo più avanti, peggio e più di prima.
Dopo questa parentesi, torniamo alle crudeltà del secolo: nel nome del Dio (viene invocato ancora oggi dai terroristi islamici!), veniva benedetta la Crociata contro gli Albigesi, guidata da Simone di Monfort, rifugiati in chiesa dove si trovavano anche i cristiani, il quale dopo aver chiesto al vescovo come si doveva comportare, il vescovo gli ordinava di ammazzarli tutti “sarebbe stato il Padre a riconoscere i suoi” (v. in Articoli: L’Inquisizione ecc.); fu questo, ancora il secolo in cui i guelfi sostenitori del papa, per “liberare” Padova la saccheggiavano commettendo per otto giorni ogni genere di nefandezze; e il secolo in cui avveniva la carneficina di S. Zenone (v. sotto).
I Ghibellini non erano da meno dei Guelfi, quando con l'imperatore Federico II (1245), contro il quale il papa Innocenzo IV aveva predicato la Crociata, faceva segnare i guerrieri nemici che gli cadevano nelle mani, col ferro arroventato, la croce sulla fronte e sul petto e con corone intorno al capo erano poi mutilati e crocifissi.
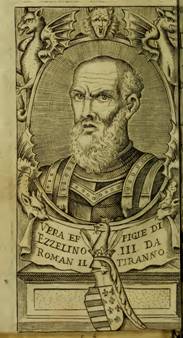 |
EZZELINO III IL TIRANNO |
SUE CRUDELTA’ VERE O PRESUNTE
|
E |
’ da premettere che, nonostante tutto ciò che di male sia stato scritto su Ezzelino, egli è da considerare il più grande guerriero e il più fine politico dell’epoca (aveva fatto molti statuti e molte riforme) e uno dei più potenti, se non il più potente signore d’Italia, e purtroppo con tanti cronisti e storici che si sono occupati di lui nessuno ha approfondito questi aspetti.
Mentre è stato scritto molto sulle sue azioni più private, sulle guerre e sulle sue crudeltà; diversi sono stati i cronisti che seguendo i propri istinti spesso non ci hanno dato certezze storiche, per cui molti dei fatti della sua vita e delle sue azioni lasciano solo delle perplessità; dove è stato possibile, abbiamo cercato di evidenziare alcune delle tante contraddizioni in modo che sarà lo spirito critico del lettore a fare opera di discernimento.
Nel suo aspetto fisico, secondo alcuni cronisti è stato concordemente descritto di statura media e ben formata, bruno nel viso, di nerissimo pelo con una ferita sul viso che sarà coperta dalla barba (le riproduzioni della sua immagine sono state fatte in secoli successivi, dettate dalla immaginazione dei rispettivi autori); a queste più certe caratteristiche sono state poi man mano aggiunti altri particolari: che aveva il capo grosso, gli occhi piccoli, il naso grande e aquilino, il volto e la fisionomia terribile e fiera; ma altri che ritenevano che le crudeltà che gli venivano attribuite corrispondessero al suo “orribile aspetto”, scrivevano: “Questo crudelissimo tiranno, questo mostro del genere umano, questa peste del mondo, era orrido di aspetto, dal parlare sgradevole, terribile coi suoi occhi di vipera, superbo ed orgoglioso nel camminare, sempre fremente d’ira, riempiva tutti di spavento, non solamente colle parole, ma anche col semplice sguardo; lo stesso cronista racconta “di aver visto passare per Este molti uomini accecati, donne senza mammelle, bambini abbacinati e a un infelice al quale mancavano il naso, la lingua, un occhio, una mano e un piede; e costoro, così conciati da quel tiranno, raccontarono che questi faceva squartare, decapitare, sbranare a pezzi le sue vittime”; il cadavere di Almerico de Tordio, morto in carcere, venne fatto decapitare e lo stesso fu fatto agli altri cadaveri.
Si diceva anche da parte di quelli che non lo ritenevano figlio del Demonio (v. in Schede S. Gli Eccerini, la tragedia dimenticata di A. Mussato) o di un cane, che fosse figlio di un amore turpe, in quanto la madre, rimasta vedova si era invaghita di un “rustico e membruto tiranno da cui era nato questo figlio”.
Ma il popolo non poteva adattarsi all’idea che un mostro tale, che doveva la sua esistenza al diavolo, alle streghe ed ai cani, fosse un uomo come gli altri: e gli attribuiva statura gigantesca; sulla parete esterna della torre di Soncino (castello nel cremonese v. sotto) si mostrano confitti due ferri, l'uno a metri 2.72 e l' altro a metri 4.18 dal suolo; mentre al contrario vi è stato chi ha raccontato che Ezzelino giungeva sino al più basso quando era a piedi e sino al più alto quando stava a cavallo; e altri ancora, che era di statura media, nero e peloso, grosso il capo, gli occhi piccoli, i denti acuti, un gran naso aquilino; ma ho sentito, scrive il cronista, che sopra il naso gli spuntava un lungo pelo che quando montava in collera si rizzava, e tutti scappavano dalla sua presenza” (sed audio quod habebat unum pilum longum super nasum pilum longum qui statim erigebatur, quando excandescebat in iram, et tunc omnes fugiebant a facie eius).
Né i vari cronisti né altri ci raccontano che egli avesse difetti corporali, che anzi era ritenuto “di persona molto attamente formata”;
ma i posteri, forse perché alla bruttezza dell' animo si vuole sempre associare quella del corpo, riferiscono che fosse “gobbo, specialmente dopo la ferita riportata a Cortenuova” (1237).
Il popolo gli attribuiva anche, come al suo contemporaneo sant’Antonio, il dono della ubiquità e per affari di guerra o di governo, egli si trovava più volte, nello stesso istante a Padova e a Verona.
Si raccontava anche che fosse invulnerabile e che le palle di fucile non lo trapassavano mai (ma i fucili si cominciarono ad usare un secolo e mezzo dopo la sua morte).
Ezzelino, prima di giungere al potere, e quando conduceva la vita del semplice cavaliere, era tremendo contro i nemici, ma cogli amici era piacevole e giulivo; fedele e costante nel mantenere le promesse fatte; fermo nei suoi propositi; nelle deliberazioni e nei discorsi prudente e moderato; nell' aspetto e nei movimenti perfetto cavaliere.
Quando giunse a un elevato grado di potenza e al dominio, e specialmente dopo la presa Padova (1237), egli mutò del tutto il suo carattere; da piacevole e gentile quale era prima, cambiò divenendo orgoglioso e superbo; era terribile nel parlare, colla sua sola presenza spaventava la gente; nel camminare era altero; mosso solo da infondati sospetti prosegue il Monaco di Padova (probabilmente calcando un pò la mano!), mandò al supplizio innumerevoli innocenti; era crudele, senza misericordia e inclinato a tutti i vizi, escludendo la lussuria a causa della sua misoginia; “esercitò il suo potere con inflessibile crudeltà, fu tiranno senza misura né freno, non perdonava nessuno, e fu crudele contro tutti”.
Tra le sue crudeltà si aggiungeva quella secondo la quale “separava le mogli dai mariti, obbligandole poi ad unirsi in matrimonio con altri”; era inoltre “contrario alle sciagurate che vendevano il loro corpo” ed ebbe in odio i lenoni che ne traevano guadagno, i ladri e gli assassini, ma a questi racconta il cronista, si sostituiva nelle imprese e azioni, perché derubava e uccideva senza ragione di sorta; era sospettoso al massimo grado, e dava sempre la interpretazione peggiore possibile alle parole ed ai fatti più insignificanti; fu sempre nemico della pace, e attivo eccitatore di guerre civili; abilissimo nell'ammassare ricchezze, ma anche nello spenderle quando doveva assoldare guerrieri o allargare la sua potenza; spogliatore di beni ecclesiastici e crudelmente, uccise molti preti e frati; arrogandosi diritti papali, concedeva a chi meglio gli pareva le prebende ed i benefici ecclesiastici; fu grande nemico della fede cattolica, e per questo motivo venne condannato dalla chiesa come perfido eretico.
“Per suo ordine morirono, di ferro o di fame, tra crudelissimi tormenti, ben cinquantacinquemila persone; gli sembrava di soffrire la fame e la sete se non vedeva straziare membra umane e spargere sangue.
Le sue crudeltà e delitti furono tali e così innumerevoli, che non possono neppure essere creduti, tanto essi superano qualsiasi immaginazione; “nemico della natura e del genere umano, volle impedire il suo propagarsi, evirando uomini e fanciulli; a molte donne fece tagliare il naso, le labbra, le mammelle, accecando i loro bambini; non solo operò tali infamie contro i nemici, ma non fu mai amico di nessuno e giorno e notte non pensava che alle uccisioni ed al modo di tormentare gli uomini con i più inauditi supplizi”; altro autore aggiunge che “i prigionieri di Ezzelino erano costretti a bere la propria orina; nelle carceri erano così numerosi che stavano stipati, da non poter rimanere in piedi né sedere e da quei luoghi si sentivano uscire continuamente voci e urla orribili di pianto e non permetteva né confessioni, né funzioni sacre o prediche”.
Quando perdette Padova (1256), Ezzelino fece morire undicimila (numero accreditato da diverse fonti ndr.) padovani in Campo san Giorgio a Verona (1256), preventivamente circondato da una palizzata.
Il racconto di Landino è di quelli che rientrano nella leggenda, ma presentato come veritiero: egli narra che “Ezzelino, essendogli insorti dei sospetti nei confronti del suo cancelliere ser Aldobrandino e avendo deciso di eliminarlo, gli chiese se sapeva chi fossero quelli che erano stati rinchiusi nello steccato, e il cancelliere gli rispose che li aveva annotati tutti in un suo quaderno; Ezzelino gli disse di aver deciso di voler presentare le loro anime al Diavolo, (da aggiungere) ai molti benefici che gli aveva concesso; per cui voleva che andasse col quaderno insieme con loro all'Inferno e nominatamente per parte sua glieli presentasse, e così lo fece ardere insieme con gli altri”!
Al suo barbiere, che lo radeva tremava la mano ed egli gliela fece troncare; molti sciancati e ciechi, ai quali Ezzelino non aveva fatto nulla, giravano per la Lombardia chiedendo pietà; e mostrando i loro difetti corporali esclamando: Ilaec, haec fecit notai Eccelinis de Romano; ed Ezzelino saputo ciò, fece annunziare che tutti i ciechi, zoppi, impotenti al lavoro gli si presentassero a Verona dove egli li avrebbe forniti di cibo e vesti per tutta la vita; se ne presentarono ben tremila, tanto che ne fu riempito un grande caseggiato; allora Ezzelino mandò a dire a costoro che dovevano uscire tutti coloro che si sentivano capaci di vivere lavorando, ma nessuno uscì e allora il tiranno fece riempire la casa di legna e paglia, e, appiccatovi il fuoco, li bruciò tutti vivi, essi stridevano e Ezzelino con i suoi cavalieri giravano intorno al caseggiato come in un torneo; secondo altre fonti a quei disgraziati furono fatti togliere i cenci e rivestiti con abiti nuovi e dopo averli fatti abbondantemente mangiare furono mandati via ... ma nei cenci furono trovate molte monete che richieste invano non erano state restituite!
E’ stato raccontato che faceva precipitar le sue vittime da alte torri; non si mostrava mai benigno né in opere né in parole e neppure nel pensiero ed era crudele al punto da non permettere che si piangesse la morte di quelli che aveva fatto uccidere; obbligava tutti a lodare le sue azioni, a chiamar giusto lui solo e ingiusti tutti gli altri uomini; aveva in ogni luogo molte spie al suo servizio e nessuno potette impetrare da lui la ben che minima cosa e quando qualcuno peccava contro di lui, sterminava sempre l’intera famiglia del colpevole.
Il cronista bresciano Malvezzi scriveva che Ezzelino aveva fatto morire di fame e tormenti il proprio fratello, Ziramonte (fratello naturale di Ezzelino non si ha notizia!) e aveva tenuto un nipote a lungo in carcere, carico di catene, facendolo morire fra inauditi dolori; lasciò pure perire in prigione il suocero con tutti i suoi figli; mutilò molte sue parenti e venerande matrone e vergini innocenti.
Presa Brescia, vi commise immani crudeltà; fece uccidere donne incinte, ad altre deturpò il viso; tormentava e uccideva i prigionieri di guerra; cacciava in esilio i cittadini dopo averli privati di occhi, mani e piedi; incrudelì poi in modo speciale contro i sacerdoti dei quali molti ne bruciò vivi, altri accecò ed evirò; fece giuramento di voler riempire di testicoli di preti un pozzo profondo.
Salimbene de Adam, dopo aver detto di Ezzelino che era stato più crudele di Nerone, Domiziano, Decio e Diocleziano, e aver narrato di lui le infamie già ricordate da altri cronisti, conclude col dire che, “come Gesù volle avere al mondo uno che gli somigliasse e mandò S. Francesco d'Assisi, altrettanto pretese di fare il Diavolo, e mandò Ezzelino”!
Narra ancora il Monaco padovano, che a Ezzelino pareva di soffrire la fame e la sete quando non vedeva dilaniare le carni dei cittadini e spargersi sangue umano; e altri ancora gli danno del bevitore di sangue umano!; e la tradizione popolare, esagerando sulla sua voracità racconta che mangiava una volta al giorno, ma, facendo concorrenza all'Orco, divorava i bimbi, suo pasto prediletto era però la carne di prete, per questo è considerato un mangiapreti!
LE SUE MOGLI
E LE SUE DONNE
|
E |
le donne? “Questo essere che, sulle ali d'angelo scende alla nostra vita, non rasserenò mai col suo sorriso l’anima cupa di Ezzelino? Le carezze ed i baci d' una donna amata, non poterono mai far spuntare un sorriso su quelle labbra use solo al comando di guerra ed agli ordini sanguinari? E un bambino adorato, colle sue carezze ineffabili, non fece mai palpitare d'amore paterno quel cuore, plasmato così insensibile e duro?”
I cronisti contemporanei o di poco posteriori, sono unanimi nel riferire che fosse misogino e che “Ezzelino odiava le donne e rifuggì sempre dal loro amore”; anche gli scrittori, che più gli sono avversi e dicono di lui tutto il male possibile e impossibile, convengono nel confessare che egli non fosse appassionato del “bel sesso”.
Solo qualche storico narra che il padre di Ezzelino ammalatosi a Padova (1219) ospite in casa di Zilio dei Bonici (o Bonizi), il figlio che allora aveva 25 anni, andò ad assisterlo e in tale occasione si innamorò e fu riamato da Gisla moglie di Zilio; la storia non ebbe seguito (Gisla avrà un figlio di cui Ezzelino ignorava l’esistenza).
Dopo molti anni un Pietro dei Bonici a seguito di una congiura contro Ezzelino (1246), fu condannato a morte; Gisla recatasi da lui e gettatasi ai suoi piedi, nel ricordargli 1'antico amore, gli giurò che Pietro era suo figlio, supplicandolo che lo perdonasse; Ezzelino, cambiò a Pietro la pena di morte in quella della prigione a vita e lo mandò a morire nel castello di Angarano.
Dopo questo amore giovanile che gli viene attribuito, Ezzelino ebbe quattro mogli da cui non ebbe figli, in quanto pare che egli seguisse uno dei movimenti ereticali che vietavano i rapporti tra uomo e donna (come suggerisce Pietro Forese in nota al testo di Rolandino “Vita e morte di Ezzelino da Romano” Fondazione Valla); per i movimenti ereticali del X secolo v. in Articoli L’Inquisizione ecc. P. I, in nota al Par. I primi roghi alla fine del Xmo sec.).
Nel 1221 Ezzelino sposò Zilia o Gilia, sorella del conte Rizzardo di Sambonifacio, il quale a sua volta impalmò la celebre Cunizza (che aveva ventiquattro anni), sorella di Ezzelino; questa unione avrebbe dovuto legare in pace perenne le due famiglie, ma presto le due famiglie tornarono in lotta; presso la corte dei Sambonifacio viveva Sordello (da Goito, il noto trovatore del “dolce stil novo”) che divertiva i nobili con canzoni e racconti e Cunizza se ne innamorò; Ezzelino era al corrente di questa storia (ma qualche altro storico scrive che presso quella corte era trattata male) e per vendicarsi chiese a Sordello, che rientrava nel parentado dei da Romano, di rapirla, mentre Ezzelino ripudiava Zilia di cui non si sa più nulla.
Cunizza (1198 c.a-1279) si trovava nel castello di Ezzelino (anch’egli circondato di trovatori, giullari, buffoni e astrologi come Guido Bonatto, con i quali passava le notti), dove viveva anche Sordello, suo amante, la loro storia finì quando Ezzelino cacciò Sordello dalla corte.
Cunizza era divenuta famosa per la sua spregiudicata liberalità nei costumi, aveva avuto diversi mariti e molti amanti e qualche cronista la definisce senza perifrasi, “magna meretrice”; si era trasferita a Firenze (dove moriva ultraottantenne) e viveva presso la famiglia di Cavalcante de’ Cavalcanti e Dante (1265-1321), pressappoco ventenne aveva avuto l’occasione di conoscerla o comunque di conoscerne la fama scandalosa che l’accompagnava.
Dante ben conosceva le vicissitudini della Marca Trevigiana e la malvagità che vi regnava (come nel resto d’Italia) e fa riferimento, senza nominarlo a Ezzelino, con i seguenti versi (Par. IX, 25): “In quella parte della terra prava - che siede tra Rialto (Venezia) e le fontane (sorgenti) di Brenta e di Piave) - si leva un colle” (di Romano), “là ove scese una facella - che fece alla contrada un grande assalto” (da dove scese una fiamma, che aveva portato distruzione e morte in quel territorio, instaurando un regime tirannico).
Con questi versi Dante introduce Cunizza (sorella di Ezzelino): “D’una radice nacqui ed io ed ella (la facella): Cunizza fui chiamata e qui refulgo - perché mi vinse il lume d’esta stella (fui dominata dai raggi di questo pianeta, vale a dire fui dominata dalla passione d’amore); a questo punto ci si è chiesti come mai Cunizza, pur avendo dato il suo amore a “chiunque lo chiedesse”, l’avesse messa in Paradiso (IX-32); qualcuno aveva detto che Dante si riferisse ad altra Cunizza, senza dire però chi fosse; la spiegazione più accettabile è che “per Dante la forza di quell’amore (L’amor che move il sole e l’altre stelle!), poi rivolto a Dio, l’avesse portata alla salvezza” (Verci); “qualunque tipo di amore fosse, poteva essere quello di Beatrice, di Francesca da Rimini, di Cunizza o dei mistici” (T. Di Salvo, Divina Commedia, Zanichelli).
L’incontro con Sordello fu pieno di affetto, uguale a quello avuto inizialmente con Virgilio, per la comune patria, Mantova, considerato da Dante “un’anima nobile”; il Canto del Purgatorio (VI, 57-58) è quello celebre “Ah serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma gran bordello” (pensa, raro e caro lettore, non ti sembra l’Italia di oggi? nda!).
L’imperatore Federico II, ritornando dalla Lombardia (1237) con Ezzelino che si era distinto per atti di valore e per la sua fedeltà, volle gratificarlo dandogli in moglie una sua figlia naturale, Selvaggia, fatta venire dalla Puglia o più probabilmente dalla Germania; le nozze si celebrarono (1238) nella chiesa di S. Zeno in Verona e i festeggiamenti durarono venti giorni tra grandi pompe, giostre e tornei; “il popolo immaginava che i sorrisi della giovane moglie avrebbero reso Ezzelino più mite e buono, ma questi, insuperbito nel vedersi genero dell' imperatore, divenne da quel giorno ancor più tremendo di prima”.
Come finì Selvaggia (dopo sei anni di matrimonio)? Non si sa; chi racconta che il marito la fece morire per giusta o ingiusta gelosia e chi narra che l’avesse eliminata per sposare Isotta Lancia.
Isotta, sorella di Galvano Lancia di illustre famiglia siciliana, zio materno di Manfredi (principe di Taranto, poi re di Sicilia) era al seguito di Federico II (del quale era giustiziere - ministro della giustizia - in Sicilia) che lo nominò podestà di Padova; pare che Ezzelino (1244) se ne fosse incapricciato (ma non era misogino? nda.); non potendola avere come amante, la prese in moglie e la sposò.
Anche Isotta gli venne presto a noia (!) e, senza una ragione, la ripudiò; Galvano non intendeva sopportare 1’offesa e pensava alla vendetta, ma Ezzelino, che non era avvezzo a perdere tempo in ragionamenti e disquisizioni, lo anticipò, cacciandolo da Padova dove Galvano aveva commesso “molte ribalderie e ladronecci”, facendosi restituire la grossa somma che aveva rubato all’erario di Padova e facendo buttare in una prigione 1’arcidiacono Filippo che aveva sentenziato che Isotta era e doveva essergli moglie.
Nel palazzo del patriarca d'Aquileia a Padova, nel quartiere del ponte Animi (il 16 Settembre 1249, dieci anni esatti prima della battaglia di Cassano), presenti molti cavalieri e cittadini di Padova e Vicenza, Ezzelino, volendo mostrare il suo speciale affetto e amicizia, si promise sposo di Beatrice figlia del conte Bontraverso di Castelnuovo, “nobile, bella, di specchiati costumi, colta e, in secreto colloquio le fece mille promesse di servizi ed onori per la famiglia”.
Il mese seguente Beatrice passò, con gran seguito, da Padova a Verona e andò ad abitare col marito, il quale, per quanto si raccontava, ne fosse innamorato (dato che sia possibile credere, commenta Rolandino, che nella stessa persona si possano trovare assieme amore e crudeltà); ciò che può meravigliare (ma non troppo, visto che a quei tempi era la norma nda.), prosegue Rolandino, “che questa fanciulla, bella e giovane, fosse data in moglie a un uomo potente, nobile, esimio, magnifico come si vuole, ma vecchio”
Si cercò in tutti i modi di cercarne le cause, alcuni dicevano che Ezzelino, stanco di lotte e di governo, voleva smetterla con le guerre e, visto che era quasi l’unico signore della Marca, passare ai piaceri della vita nel castello che stava costruendo a Padova, o nel palazzo, che egli progettava allora di farsi edificare presso il Ponte Molino con le pietre delle case e delle torri da lui distrutte.
Molti ritenevano questa unione fatta per motivi politici e sospettavano che unico scopo del matrimonio fosse quello di servirsi del suocero per pacificarsi col marchese d’Este e con altri suoi potenti nemici della Marca e della Lombardia e, se fosse stato possibile, rientrare nelle grazie del papa, il quale ogni anno a Roma, nella settimana santa, e davanti a grande moltitudine di gente, ripubblicava contro di lui la scomunica.
Anche in questa occasione i veronesi celebrarono grandi feste sperando che 1'amore della giovane sposa avrebbe mitigato la sua innata ferocia; ma Ezzelino non si smentì in quanto, non badando alle preghiere della moglie, fece uccidere (1256) il suocero conte Bontraverso con tutti i suoi, per i soliti sospetti; secondo altri, il conte ferito a una gamba a Soncino, fu messo in prigione dove morì (1259) e fu sepolto nella chiesa di san Francesco.
E’ stato tramandato (non però dai cronisti dell’epoca ma da autori di tragedie di molto posteriori, Brentari rimanda a Cantù che a sua volta riporta la storia dopo aver avvertito che Ezzelino “né di amori né di libidini viene incolpato se non da una tradizione di novelle e tragedie”), il racconto della tragica fine di Bianca dalla Porta che Ezzelino volle amare per forza: narra infatti che Vicenza si era ribellata contro Ezzelino e governatore della città era Giambattista della Porta che morì combattendo per la sua difesa; egli da un anno aveva sposato Bianca de' Rossi, tanto bella quanto virile che, morto il marito, lo sostituì combattendo per vendicarlo, ma alla fine fu fatta prigioniera con le armi in pugno.
Ezzelino, colpito dalla bellezza o dal valore volle averla, ma, rifiutato, tentò di violentarla; Bianca, non accettando lo stupro, si buttò dalla finestra, slogandosi però una spalla; appena guarita Ezzelino la riprese con la forza e se ne “satollò” come meglio volle!
Bianca neanche questa volta accettò la violenza dalla quale se ne sentì a tal punto disonorata che, dopo aver chiesto a Ezzelino il permesso di vedere per l’ultima volta il marito, accompagnata alla tomba, fu alzato il coperchio di pietra che fu puntellato e lei mettendo la testa sotto il coperchio, spingendo il puntello ne rimase schiacciata.
 |
LA SCOMUNICA |
|
E |
zzelino fin dai tempi del papa Gregorio IX (1227-1241) era incorso nelle censure ecclesiastiche del vescovo di Caltello, autorizzato dal papa, perché aveva occupato alcune ville e castelli di appartenenza del vescovo di Treviso ed era stato ammonito perché le restituisse; Ezzelino rispose che il papa non doveva immischiarsi in queste faccende; il vescovo di Treviso insistette quindi presso il papa Innocenzo IV (1254) per l’approvazione del breve (2 Marzo), che lo aveva scomunicato (1248) per “la truculenta rabbia di uomo inumano e la crudele barbarie di Ecelino da Romano, reso insigne dalla enormità della sua malizia e celebre dalla quantità di fatti atroci non ignoti al mondo. Costui, nascondendo sotto volto umano un’anima di belva, sitibondo di sangue cristiano e imbaldanzito dall'aiuto degli altri, muove guerra implacabile contro tutti i diritti dell’umanità. E non solo infierisce con ferale eccidio contro i corpi degli uomini, ma passando ogni limite, misura e numero, non contento d’un torrente di sangue, a mezzo dei corruttori della fede, tenta anche la rovina della vita spirituale per la dannazione delle anime [...].
La efferata sua crudeltà infuria talmente, che non perdonò né ai beni né alla vita neppure degli amici, non ebbe per alcuno misericordia, né per il sesso, né per la età, non venerazione né a religione né a grado, accecando fanciulli innocenti, ed uccidendo gli adulti, avendo immaginato contro essi ogni genere di tormento.
E, cosa vergognosa a pensare e a dire, con tagli orrendi, come si dice, evirò uomini e donne, spegnendo nei superstiti degli uccisi la speranza di prole futura, facendosi omicida di coloro che la natura non ancora aveva fatto nascere nei lombi. Chi dubiterà perseguitar egli negli uomini non le persone solo, ma la natura? Chi esiterà a dichiararlo pubblico nemico, quasi non fosse individuo del genere umano?”
E dal momento della scomunica in ogni giorno di Pasqua, il papa la ricordava durante le funzioni religiose!
MORTE DI
EZZELINO III
|
N |
ello stesso anno (16.IX.1259), fallitogli il tentativo di impossessarsi di Milano sulla via del ritorno, inseguito dai milanesi, giunto sul fiume Adda, riuscì a far passare l’esercito sull’altra riva e in questo frangente era stato ferito da una freccia conficcatasi nell’osso del piede sinistro; fu portato a Vimercate dove i medici aperta la ferita gli estrassero la freccia e dopo essere stato medicato e fasciato egli risalì a cavallo recandosi al fiume per seguire il passaggio del fiume del resto del suo esercito,cosa che avvenne “in pieno ordine che era una meraviglia a guardarlo”; erano nel frattempo sopraggiunti gli altri suoi nemici, il marchese Azzo d’Este con i ferraresi e i mantovani, il marchese Oberto Pallavicino e Buoso da Dovara con i cremonesi a cui si aggiunsero i bresciani che erano nel suo esercito e lo tradirono passando nell’esercito nemico.
Ezzelino vedendo che le forze spiegate che lo circondavano erano di gran lunga superiori alle sue, si rese conto di non poterle affrontare e cercò una via di fuga, ma sopraggiunsero gli avversari e la prova del suo valore fu del tutto inutile in quanto fu circondato e fatto prigioniero.
Sulle cause della sua morte i cronisti non sono concordi, la causa non era stata la freccia al piede che come riferisce Rolandino era stata ben curata, ma la ferita alla testa sulla quale vi sono diverse versioni, quella di Rolandino la riteniamo più vicina alla realtà, secondo la quale “ci fu un uomo con la falce che villanamente (Rolandino condanna questo gesto nei confronti di un prigioniero indifeso) gli assestò due o tre colpi di falce sulla testa, giustificando l’offesa col dire che vendicava il proprio fratello, al quale Ezzelino aveva fatto tagliare un piede”; i suoi avversari che erano stati anche suoi amici, marchese d’Este, marchese Pallavicino e Buoso da Dovara e gli altri magnati, lo trattarono con onore e lo condussero prima alla tenda di Buoso e poi al castello di Soncino dove ricevette lodevoli cure, ma dopo undici giorni dalla cattura (27.IX) finì i suoi giorni.
Secondo le altre versioni Ezzelino ferito da saetta al piede sinistro, (da Mazzoldo de' Lavelonghi, nobile di Brescia), gli spaccò il cranio colla spada; altri racconta che Ezzelino, mentre guadava il fiume, venne ferito da una freccia al piede e poi ucciso di clava mentre fuggiva; il Novellino, che Ezzelino, dopo essere stato fatto prigioniero, “percosse tanto il capo al feristo del padiglione (il palo che sosteneva la tenda) ove era legato, che s' uccise; vi è persino chi racconta che egli venne ferito mortalmente nel capo dai suoi stessi seguaci, quando essi si accorsero che non c'era più salvezza per lui; altri ancora, che Ezzelino, fatto prigioniero; e trasportato a Soncino, non permise che il medico lo curasse, ma che anzi nella notte si lacerò colle proprio mani le ferite, “è certo in ogni modo che Ezzelino morì li 27 dello stesso mese”.
La notizia della sua morte fu salutata con grande gioia di popolo, il papa Alessandro IV (1254-1261) aveva inviato una circolare, invitando a esultare con lui che ringraziava la mano di Dio posata sul malvagio e dalle chiese le campane gioiose suonarono a distesa fino a Venezia dove la notte i chierici salirono sui campanili e li illuminarono con ceri e torce.
LA SUA ANIMA
E IL DIAVOLO
|
E |
la sua anima e il suo spirito dov’erano finiti? Ezzelino, come abbiamo visto nell’articolo sulla tragedia di Mussato (cit. Gli Eccerini ecc.) era ritenuto fosse figlio del Diavolo che si era unito con la madre, per cui dopo la sua morte fiorirono racconti a non finire pari a quelli sorti quando era in vita.
Essendo peraltro scomunicato Ezzelino non poteva essere sepolto in terra consacrata e fu sepolto presso la torre di san Bernardino nei pressi del palazzo pubblico; relativamente alla sua anima era stato religiosamente detto: “Il diavolo ebbe la sua anima e per questa morte sia glorificato Iddio per tutti i secoli dei secoli” e gli abitanti di Soncino inventarono l’epitaffio: “Dà sepolcro Soncino, a quel can d’Ezzelino, che lacerano i (lacerato dai) Mani e i tartarei cani”.
E si narrava che la camera dove era spirata la sua anima si era riempita di fumo denso e puteabondo, portato dal demonio che era andato a prendere suo figlio; oppure che una tigre (!) con un cane andarono a mangiare il suo cuore e che il cadavere chiuso in una cassa, poco dopo non fu più trovato; e sulla sua anima si diceva anche che non era andata all’inferno perché il Diavolo non l’aveva voluta, per questo essa vaga per i castelli che erano stati suoi e nei luoghi che aveva bagnato di sangue; tra i castelli era stato inserito anche quello di Marostica (sebbene costruito mezzo secolo dopo la sua morte da Cangrande della Scala nel 1311), il popolo invece insisteva nel raccontare che era stato costruito per ordine di Ezzelino e la sua anima andava a passeggiare di notte tra quelle rovine.
Secondo altri racconti l’anima di Ezzelino era stata accolta nell’inferno dove rimaneva chiuso tutto il giorno, ma di notte usciva finché il Diavolo non lo richiamasse; e vi era chi affermava di averlo visto (attualmente il Diavolo non lo vede più nessuno...sostituito dagli alieni... descritti più o meno come diavoletti!), chi a piedi e solo, tutto vestito di ferro, chi coperto con un lenzuolo bianco circondato da demoni e streghe che cantano e ballano, chi in carrozza tirata da due cavalli bianchi (ciò che preannunciava sempre cattivo tempo!).
Per i turisti (o TV) che cercano spiriti, può essere interessante sapere che in alcune notti d’inverno Ezzelino gira per le strade di Romano, pallido, magro, con la barba rossa e un muso da cane e non di rado si reca in cima al colle, circondato da ombre che piangono e ridono e con le sue magie riesce ad attrarre uomini e donne, facendoli poi precipitare giù per la china; sotto la chiesa vi sono stalle con i suoi cavalli, anch’essi indiavolati e vi sono ampie caverne dove sono nascosti barili di monete d’oro, di olio e di vino!
Il duomo e la canonica di Bassano sono costruiti sulle fondamenta del castello di Ezzelino e la sua anima è condannata a stare nei sotterranei del castello da dove egli esce di notte avvolto in un bianco lenzuolo urlando e piangendo, circondato dai suoi soldati che non riescono a difenderlo dalle anime delle sue vittime che lo inseguono e tormentano; qualche notte lo si vede girare su un bianco cavallo per tre volte intorno alle mura di Bassano che aveva fatto costruire, per poi tornare nei suoi sotterranei; qualche volta poi si reca per vie sotterranee nella chiesa, per rubare qualcosa... ma lo fa quando l’arciprete è assente da Bassano; per questo motivo i sacrestani non volevano dormire in canonica quando l’arciprete fosse assente.
A Romano, dove era nato Ezzelino vi era un munito castello quasi come quello di san Zenone, distrutto dalle fondamenta quando Ezzelino era morto; i veneziani ne costruirono un altro (1370) e fu anch’esso distrutto (1388), in quel posto vi fu costruita la chiesa parrocchiale ed eretto un bel campanile a guisa di torre rotonda e merlata, che passa per opera di Ezzelino; i popolani ignoravano il castello veneziano, ricordando quello di Ezzelino e raccontando che sotto la chiesa vi è una caverna in cui è rinchiusa la sua anima, custodita da due demoni che qualche volta lo fanno uscire, togliendogli, per precauzione, la lingua, gli occhi e le unghie, egli quindi, attraverso il buco della serratura, entra nella chiesa e si mette a salmeggiare o lo si sente gridare e far rumori.
Di storie del genere ve ne sono ancora tante da riferire, ma chiudiamo con questa collegata ai quattro conti di Vado che Ezzelino aveva fatto uccidere.
A Cornuda vi era la famiglia dei Camposampiero che Ezzelino aveva fatto sterminare eccetto un bambino che fece educare nella sua corte, ma in un momento d’ira o di sospetto (1250) lo fece buttare in una torre per farlo morire; i conti di Vado si offrirono come mallevadori del ragazzo, ottenendo che fosse tolto dalla prigione; il ragazzo però era nel frattempo riuscito a fuggire e Ezzelino fece rinchiudere nella torre i conti di Vado lasciandoli prigionieri per quattro anni, quando decise di far chiudere le porte per farveli morire; essi morirono di stenti e i loro corpi furono trovati disseccati con le ossa ricoperte di pelle annerita: finché durò la torre di Cornuda si vedevano le anime affamate dei conti vagare intorno ai merli a rosicchiare il muschio e l’edera.
IL TESORO
E LE GALLERIE
|
N |
ei racconti, non potevano mancare i tesori, nascosti da Ezzelino in diversi luoghi; tra questi è indicata la chiesa di Bassano sotto la quale vi sarebbe un tesoro inestimabile e le istruzioni sono le seguenti: occorre scavare dietro la chiesa, fin che si trova una pietra su cui è scolpito un triangolo, da quel punto occorre spostarsi di sei passi dalla pietra e scavando profondamente si trova il tesoro che Ezzelino nascose quando fu assediato dai padovani, ma non è tutto, perché sotto il tesoro è nascosto un agnello tutto d’oro.
E ancora, un sacerdote di Bassano (del cui manoscritto dei primi dell’800 è stato indicato il nome, Francesco Chiuppani), raccontava che nelle viscere del colle Castellaro, a oriente delle rovine, erano stati nascosti cinque “pittari” d’oro battuto, sepolti per sottrarli alla avidità di Ezzelino; ma lo stesso sacerdote scoraggiava i possibili “cercatori”, dicendo che era occulto e profondo con difficoltà a poterlo trovare!
Ma non era l’unico posto indicato dal sacerdote che indicava anche una casa rustica presso Nove, con un sotterraneo molto profondo dove scendendo le scale alla fine vi era un mucchio di monete d’oro che ... “non si potevano prendere perché Ezzelino vi faceva la guardia di persona”!
Altro luogo si troverebbe a nord di Bassano, presso Solagna, in direzione del Brenta si trova uno sperone di monte detto Bastia dove vi sono le rovine di una rocca eretta dagli Ezzelini, all’interno della rocca, sotto le fondamenta a nord, verso il Brenta, andando a grande profondità si trovano due forzieri di lamine d’acciaio pieni di oro e argento; cercando verso oriente, anche qui si scoprirà un sasso su cui, a differenza dell’altro indicato, sono scolpiti il sole e la luna; da questo punto facendo tre passi verso mezzogiorno si troveranno sepolti quattro vasi ripieni d’oro ....e scavando in altro sito (suggerisce lo stesso prete) si troveranno due “ramine” piene di medaglie d’oro battuto e d’argento con l’impronta degli antichi imperatori romani ... e così via!
Non parliamo poi delle gallerie che da Bassano portano in tutte le direzioni e arrivano o a san Zenone e da qui fino al Piave (dove Alberico si sarebbe potuto salvare con la sua famiglia dalla strage!), o fino a Onara o fino a Padova, dove sono sepolti i cadaveri di quelli che erano stati uccisi da Ezzelino ed è da questa galleria che Ezzelino si recava a Padova per commettere stragi e rovine ...ma nessuno vi può accedere in quanto il luogo è custodito da serpenti!
A Castellaro, in epoca ottocentesca, un signore avendo visto tra le rovine l’ingresso di un sotterraneo, vi aveva mandato un suo cane che non era tornato, ne aveva mandato un secondo che era tornato con in bocca una zampa del primo; anche una bambina, di cui si conosce il nome, Maria Tessari, andata a giocare con una palla tra le rovine, questa cadde nella caverna, la bambina entrata facendo pochi passi, sentì una voce che diceva: “Maria, Maria, se non ti chiamassi Maria tu saresti mia”! ... la bambina moriva dopo qualche tempo, impazzita!
ALBERICO
DA ROMANO
|
I |
l Monaco padovano non risparmia neanche Alberico del quale ha lasciato il più nero ritratto e per darcene una idea racconta che un giorno aveva ordinato che fossero impiccati certi guerrieri, innanzi alla forca fece condurre le loro mogli alle quali, in presenza dei mariti fece loro tagliare i capelli e levare le vesti, poi, esse presenti, fece impiccare i mariti e infine cacciò nude le done, com’erano, fuori Treviso.
Egli aveva sposato (1220) una Beatrice, probabilmente vicentina, che gli aveva dato sei figli maschi Giovanni, Alberico, Romano, Ugolino, Ezzelino e Tornalasce o Tornalasco e una femmina, Adeleita (o Adeleisa); morta Beatrice, Alberico sposò o conviveva con una Margarita, dalla quale aveva avuto due figlie Griseida ed Amabilia e un maschio, che al momento della strage della famiglia era ancora infante.
Federico II, tornando dalla Lombardia, si era recato a Padova, dove era stato accolto con magnificenza, per mettere pace tra i signori della Marca dove aveva invitato il marchese Azzo d’Este, con salvacondotto, il quale fu ben accolto dall’imperatore e tenuto come ospite, mentre Ezzelino (per proprio conto) metteva delle spie per controllare tutti quelli che andavano a visitarlo ... che in seguito sarebbero state vittime designate!
L’imperatore, dopo essersi assicurato le piazzeforti tra l’Adige e il Tagliamento, fece firmare la pace tra Ezzelino e Azzo, mettendo suoi soldati nei castelli estensi e per garanzia volle come ostaggio il figlio Rinaldo d’Este che aveva sposato Adeleita (1235), la quale volle seguire il marito; in proposito però è da dire che Rolandino scrive che Adeleita seppur promessa, non era ancora sposata, di conseguenza sarebbe da supporre che sarebbe stata mandata da sola, accompagnata dal seguito e dalle sue ancelle in Puglia (è stato suggerito il castello di Avellino ma non vi sono risultanze documentali) dove morì (1251).
A conforto di questa ipotesi è da rilevare che il matrimonio tra i due era stato stabilito nella c.d. pace di Paquara, fatta firmare da fra’ Giovanni da Vicenza (per altri fra’ Giovanni da Schio), nell’assemblea della nobiltà della Marca (1233) e secondo il Verci e altri che il matrimonio avvenne poco dopo; ma il trattato, passato appena un mese, non fu osservato anzi le lotte divennero ancora più accanite di prima; inoltre lo stesso Verci aggiunge che “il matrimonio stabilito con la pace, disgustò Ecelino”, come gli altri accordi che gli imponevano la vendita di alcune acquisizioni, e non mancavano neanche alcuni che odiavano fra’ Giovanni perché era inesorabile contro gli eretici (come abbiamo visto sopra).
E’ da aggiungere poi che nel discorso che Alberico fece ai suoi prima di arrendersi (v. sotto), aveva loro detto di raccomandarsi al marchese d’Este
“col quale “stipulai” un tempo il matrimonio tra suo figlio Rinaldo e la mia diletta Adeleita”, se quindi era stato “stipulato”, il matrimonio vuol dire che non aveva avuto luogo, altrimenti Alberico si sarebbe espresso diversamente; in ogni caso i cronisti e storici senza entrare in particolari, considerano Rinaldo d’Este trasferito in Puglia, dandolo per morto in quel luogo.
Alberico si ritenne offeso per questa soluzione di cattività della figlia che adorava, tanto più quando seppe che sua figlia, era trattata male e le si lasciavano mancare persino gli alimenti e i vestiti; egli aveva sospettato che fosse stato il fratello Ezzelino ad aver dato questo suggerimento all’imperatore e da qui nacquero i dissapori tra Alberico, l’imperatore e Ezzelino (col quale si rappacificò nel 1256).
Alberico andò quindi a impossessarsi di Treviso (1239) che governava per conto proprio, difendendola sia dal fratello sia dall’imperatore fino alla sua morte; vi aveva instaurato un regime di tirannide tormentando più del solito cavalieri e popolani, imponendo dure tasse e tributi alle chiese, accanendosi nei confronti delle vedove, orfani e fanciulli, puniva alcuni di spada altri col fuoco, facendo morire altri tra le torture, altri in carcere, esiliando altri ancora, molti se ne fuggivano a Venezia, altri a Padova.
Ciononostante egli proclamava, nei consigli e negli arenghi “che per onore della Chiesa aveva separato il grano dalla paglia, aveva allontanato le serpi dalla macchia e, grazie all’aiuto di Dio, aveva scacciato i lupi dall’ovile”.
ALBERICO
SI RITIRA
A SAN ZENONE
LA
CRUDELE SENTENZA
|
A |
lla morte di Ezzelino (27.IX.1259), Alberico, vedendo che la fortuna e gli amici lo avevano abbandonato, non sentendosi più sicuro in quanto i trevigiani cominciavano ad agitarsi e facevano presagire una rivolta, decise di mettersi in salvo con la propria famiglia, mandandola avanti con i suoi tesori (considerati inestimabili e poi inutilmente cercati) al castello di san Zenone (tra Asolo e Bassano) e poi, con alcuni amici fidati e una masnada di tedeschi, si rinchiuse nel castello, da dove nell’inverno seguente uscì qualche volta per fare scorribande nei dintorni, e procurarsi i viveri.
Era giunto il momento del “redde rationem”!
Una tremenda tempesta si andava addensando sul suo capo; a Treviso era stato mandato come podestà il veneziano Marco Badoer (16.III.1260), il quale emise una sentenza in cui, considerando che Alberico ad onta delle promesse e dei giuramenti, si era allontanato dalla religione, rovinando e scompigliando Treviso e il territorio dei trevigiani, accecando iniquamente pargoli innocenti, facendo uccidere preti, chierici, ed altre persone religiose vestite per spregio dei paramenti sacerdotali; visto che per impadronirsi di Treviso aveva commesso nel territorio violenze, omicidi, scelleraggini di ogni genere, facendo numerose prede, tutti i suoi beni erano aggiudicati al Comune di Treviso.
La sentenza prevedeva noltre che Alberico, la moglie, cd i suoi figli, fossero in perpetuo banditi da Treviso, e che questo bando non potesse mai ed in modo alcuno venir annullato; e infine, “ad honorem Dei et Sancta Matris Ecelesiae”, era decretato che se Alberico fosse caduto nelle mani del Comune di Treviso, “dovesse venire tratto a coda di cavallo per la città, e quindi impiccato per la gola” e la stessa pena fosse toccata ai suoi figli e che Margherita e le figlie dovessero essere bruciate: e se qualcuno avesse osato parlare contro la sentenza, fosse bandito e privato dei beni.
RESA DI ALBERICO
SUO DISCORSO
AI FIGLI E AL SEGUITO
|
I |
trevigiani vollero eseguire immediatamente la crudele sentenza e lo fecero in maniera ancora più crudele; alleatisi coi Veneziani, Padovani, Vicentini, Veronesi, Friulani, Bassanesi, marchese d' Este e signori da Camino, tra i quali vi era lo stesso podestà di Treviso Marco Badoer il quale non mosse un dito per evitare le crudeltà della strage.
Ai primi di giugno (1260) si trovarono con le truppe ad assediare tutt’intorno il castello, assaltandolo con petriere e altre macchine da guerra.
Il castello si trovava in cima a un monte dalle parti di Pedemonte, ai confini di Treviso ed entro il suo distretto; era stato costruito da Ezzelino II il Monaco nel tempo in cui Gerardo Camposampiero le aveva preso la moglie Cecilia; successivamente aveva pensato Ezzelino, nell’arco di dieci anni, a renderlo una vera e propria fortezza, prevedendo cosa avesse potuto succedere in futuro a lui e al fratello, estorcendo denaro a tutti, senza distinzione, affaticando uomini, buoi, cavalli, asini e giumente fino alla morte; il castello era circondato da robuste mura e fortificato, con dimore sotterranee, un sicuro e bel palazzo e una torre alta, fortissima e inespugnabile.
Gli assedianti, poiché con trabucchi, petriere, balestre e incendi, non riuscirono a ottenere alcun risultato, ricorsero al tradimento; si trattava del maestro di castello e l’ingegnere del posto, addetto alla difesa delle mura, il cui nome era Mesa da Porcilia; costui, al quale era affidata la difesa della cinta inferiore del castello, detta cortina; corrotto dall’oro, corruppe a sua volta i tedeschi che comandava e, dopo la commedia di un finto assalto (23 agosto), consegnò ai nemici quelle fortificazioni inespugnabili.
Alberico con la famiglia e i pochi suoi uomini rimastigli fedeli, dovette rifugiarsi nella torre dove, senza cibo e in particolare arsi dalla sete, poterono resistere per tre giorni dopo i quali, avendo gli assalitori respinto ogni proposta di patteggiamenti, dovette arrendersi a discrezione.
Alberico riunita la famiglia fece un discorso ai suoi figli in cui, pur rivolgendo il pensiero a Dio, li invitava alla vendetta del padre e dello zio! “Figli dilettissimi, è inutile dire che siamo precipitati da tanta altezza; vi do la benedizione paterna e l’estremo abbraccio; il Signore Iddio ascolti la mia preghiera e vi conceda senno, copia di amici, prospera e lunga vita; qualunque cosa ne sia di me, voi eredi di nobilissima prosapia, vivrete ... e se il cielo vi concede tanta forza, che è dovere di ogni ben nato, vendicate la infelicissima fine del padre e dello zio; i partigiani abbondano in Lombardia e Pedemonte; dalla Toscana non vi mancheranno di aiuti i conti Mangoni, vostri parenti, valorosi e potenti....”; poi chiamò tutti quelli del seguito che lo assistevano e i soldati della masnada, dicendo loro che fosse meglio che morisse solo lui “anziché tutti insieme con me; prendetemi pure prigioniero con la famiglia” e si diede loro con la famiglia aggiungendo “supplico in particolare il marchese d’Este se si ricorda con quanta benevolenza e amore stipulai con lui il matrimonio del figlio Rinaldo con la mia dilettissima Adeleita, contro la volontà di mio fratello Ezzelino e dei suoi amici di accogliere sotto la sua protezione me e i miei figli e degnarsi di difendermi dall’assalto dei nemici” (parole al vento in quanto il marchese, come vedremo, non mosse un dito per fermare lo scempio!).
Uno degli intimi di Alberico, Lodoviso, andò a parlamentare ma proprio i sacerdoti che dovevano richiamarsi alla pace e misericordia, ricordarono il passo della Bibbia in cui Samuele impose a Saul che uno a uno sterminasse gli ammoniti!
Quelli del seguito invece dissero che avrebbero consegnato il loro signore e tutta la famiglia, il sito, la torre e avrebbero indicato dov’erano le ricchezze e il tesoro e loro volevano andarsene liberi con i loro beni: ottennero queste richieste e il patto fu pienamente osservato.
LA STRAGE
DELLA FAMIGLIA
|
A |
vuta nelle loro mani l’intera famiglia, tutti accorrevano e quelli della marea accorsa che avevano tra le loro mani Alberico, gli ficcarono in bocca un morso di legno perché non potesse né raccomandarsi, né pregare, né lamentarsi; e quindi tutta la famiglia fu fatta passare in trionfo in mezzo all’esercito al suono di trombe e altri strumenti, infine Alberico fu gettato per terra e bastonato, gli montarono addosso e lo percossero e spinsero cogli speroni; dopo averli lasciati sfogare Marco Badoer, “nella sua immensa magnanimità” (scrive Rolandino!), comandò che gli fosse levato il morso di bocca, per tanto tempo quanto gli fosse bastato per confessarsi e chieder perdono a Dio (“che aveva perdonato sulla croce che quei guelfi portavano sul petto e non nel cuore”).
Poi cominciò su essi la barbara ed orrida carneficina “che resterà sempre un'infamia per chi la compì, per chi la fece o lasciò fare, per chi la ispirò, ed anche per gli scrittori guelfi che tentarono difenderne e giustificarne i bestiali autori”.
I sei figli furono alla presenza del padre, al quale gli occhi erano tenuti aperti per forza, 1’uno dopo 1’altro, decapitati e tagliati a pezzi a colpi di spada e quei brani sanguinolenti e ancora palpitanti vennero scagliati in faccia ad Alberico e poi divisi come misere reliquie di selvaggia vendetta, fra le città, di Padova, Vicenza e Verona; Margherita, che Rolandino descrive come giovane e bella e le due figlie, furono denudate, vilipese, straziate: e, dopo che venne loro raso il naso ed il seno, bruciate vive; Giacomino dei Tebaldi bolognese, giudice e consigliere di Alberico, fu anch’esso tagliato a pezzi; Alberico infine, dopo che ebbe assistito a tutta quella orrenda carneficina dei suoi, venne legato alla coda di un cavallo, trascinato per le strade e per campi, in modo da lasciare il terreno macchiato di sangue, e brandelli delle sue carni sui sassi e sugli sterpi e, quando, morto, non era che un ammasso di carni, fu tagliato a pezzi, dei quali alcuni furono gettati in pasto ai cani, e altri portati a Treviso, altri bruciati sulla pubblica piazza.
Nei giorni seguenti furono distrutti dalle fondamenta i castelli di san Zenone ( per il quale i trevigiani decretarono anche che in quel posto nessuno potesse più né edificare né abitare) e quelli di Fonte, Romano e gli altri di Pedemonte; le città collegate si spartirono gli immensi beni della famiglia, “che pagava tanto cara la sua discesa per dominare e guastare la nostra patria” (aggiunge Cantù).
CRONOLOGIA
DELLE GUERRE E CONQUISTE
DI EZZELINO III
1194 Nasce Ecelinello detto poi Ezzelino.
1213 All’assedio di Este si distingue per bravura e audacia;
1220 Entra trionfante in Vicenza.
1221 Ritiratosi il padre in un monastero, diventa padrone di sé.
1223 Divide feudi ed allodì col fratello Alberico.
1224 Promette soccorsi al cognato Salinguerra, assediato in Ferrara
da Azzo d' Este.
1225 Comincia ad immischiarsi negli affari di Verona.
1226 Entra vittorioso in questa città, e ne viene creato podestà.
1227 Fa trionfare il partito ghibellino a Vicenza, ove viene eletto
podestà Alberico;
Il marchese Azzo d’Este con il figlio Rinaldo vanno a prestare
aiuto ai fratelli Guecello e Biaquino da Camino che combattono
contro i trevigiani ai confini di Padova e Treviso e i trevigiani
sono sconfitti.
1228 Assediato a Bassano dai Padovani, è costretto a piegare la
testa.
1229 Conduce i trevigiani a prendere Feltre e Belluno, provocando
così una nuova guerra ai Padovani: e nello stesso anno riprende
a forza Bassano, ove si erano ribellate le masnade di Alberico.
In seguito è immischiato in continue guerre contro Padova,
Mantova, i conti di Sambonifacio, il marchese d' Este, ora
vincitore, ora vinto, ma mai stanco.
1232 Si dichiara aperto partigiano di Federico II.
1233 E’ sedotto anche lui dalla ispirata parola di Fra Giovanni da
Vicenza (o da Schio), a Paquara, a giurare eterna pace a quelli
che ha combattuto fino al giorno prima, ma la pace dura appena
un mese e la lotta riprende più accanita di prima;
1234 Caccia da Verona il conte Rizzardo di Sambonifacio;
Quell’inverno fu terribile per l’eccesso di neve e gelo, muoiono
le vigne, gli olivi, i fichi e molti altri alberi da frutta e muoiono
e molte persone; il Po era interamente ghiacciato da Cremona
a Venezia e vi potevano camminare sopra con sicurezza uomini
e carrette.
1235 Va in Germania per sollecitare Federico II a scendere nel
“giardin imperi”.
1236 Prende Vicenza assieme coll'imperatore, il quale lo nomina
suo luogotenente.
1237 Occupa Padova, ove comincia le sue tirannie, e nello stesso anno
combatte per 1' imperatore alla battaglia di Cortenuova e viene
ferito a una spalla;
1238 Sconfigge sotto Padova il marchese Azzo VII, prende e perde
Este; si fa creare capitano generale a Verona
1239 Per sedare una congiura a Padova, con disumana ferocia inveisce
con la mannaia, il fuoco, la corda, contro uomini e donne.
1240 Rottura col fratello Alberico (inizio della rovina di entrambi), col
quale doveva restare in discordia per diciassette anni e gli prende
Bassano;
Nei cieli appare una stella chiomata (cometa portatrice di
sventure!): si diceva che il titolo di marchese d’Este sarebbe
passato ad altri, ma ciò non avvenne!
1241 Tenta invano di avere Este a tradimento, e porta guerra al
fratello.
1242 Occupa Montagnana.
1243 Con grosso seguito di padovani, vicentini e veronesi, assedia
e prende il castello di Sambonifacio, e devasta il mantovano.
Prende Ostiglia, e caccia da Padova il podestà, Galvano Lancia.
1245 Interviene al congresso di Verona, prende Mestre e Noale
e continua la guerra contro il marchese d’Este.
1246 Avuto Castelfranco da Guglielmo di Carnposampiero, lo
fortifica e toglie Mussolente ad Alberico.
1247 Con Federico II ed Enzo, va all' assedio di Parma.
1248 Viene scomunicato da papa Innocenzo IV.
1249 Prende Belluno ed Este.
1250 Dichiarato signore di Verona, dopo la morte di Federico II,
sciolto ormai, da ogni dipendenza dall' impero, è al colmo
della sua potenza.
1251 Tenta invano di prendere Lodi, e onora l'imperatore Corrado IV
che scendeva in Italia.
1252 E’ minacciato dalla Lega Lombarda, rinnovata a Brescia
contro i Ghibellini in generale e contro di lui in particolare;
Appare nel cielo una cometa, ma non aveva la chioma (era
certamente un asteroide o meteorite).
1255 Riprende Trento che gli si era ribellato: ma da quell'
epoca comincia la sua curva discendente.
Nello stesso anno papa Alessandro IV (1254-61) rinnova contro di
lui la crociata già bandita da Innocenzo IV (1243-1254) l’anno
precedente.
1256, Sotto il legato apostolico Filippo Fontana arcivescovo di
Ravenna, si radunano presso Venezia i Crociati (fra i quali
mille balestrieri veneziani, guidati da Tommasino Giustinian),
e occupano Padova, che Ezzelino tenta invano di riprendere.
1257 Alberico, venuto in sospetto ai Guelfi è accolto con grida nemiche
nel campo dei Crociati, si riconcilia con Ezzelino, al quale deve
però consegnare tre figli in ostaggio.
1258 Si accorda con Oberto Pallavicino e Buoso da Dovara per
signoreggiare la Lombardia, sconfigge i Crociati facendo
prigioniero lo stesso legato Fontana e rendendosi signore di
Brescia.
1259 Si inimica con Oberto e Buoso, i quali contro di lui fanno
alleanza col marchese Azzo VII d' Este, il conte di Sambonifacio,
ferraresi, cremonesi, padovani, parmensi e mantovani.
Nello stesso anno, il 16 Settembre, fallito il tentativo di impossessarsi di Milano, è preso in mezzo a Cassano d' Adda da Martino Torriano che lo inseguiva con i Milanesi e viene ferito e preso;
Come sul luogo della nascita, così sul modo della morte i cronisti sono discordi; chi narra che Ezzelino fu colpito da una freccia mentre tentava di ripassare 1' Adda a guado; qualcuno aggiunge che il feritore fu Buoso da Dovara; chi dice che, poiché Ezzelino fu ferito da freccia nel piede sinistro, Mazzoldo de' Lavelonghi, nobile di Brescia, gli spaccò il cranio con la spada; qualche altro racconta che Ezzelino, che guadava il fiume, venne ferito da una freccia al piede e poi ucciso con una clava mentre fuggiva; il Novellino dice che Ezzelino, dopo essere stato fatto prigioniero, percosse tanto il capo al feristo del padiglione ove era legato, che si uccise; qualche altro narra che Ezzelino, mentre veniva condotto prigioniero, venne ferito da una falce sul capo da un villano, al quale egli aveva fatto mutilare un fratello; e vi è infine chi racconta che venne ferito mortalmente al capo dai suoi stessi seguaci, quando essi si accorsero che non c' era più salvezza per lui.
Lo stesso cronista, d’accordo con altri, racconta che Ezzelino, fatto prigioniero e trasportato a Soncino, (castello del Cremonese), non permise che il medico lo curasse e durante la notte si lacerò colle proprio mani le ferite; ma altri ancora racconta al contrario che si ebbero per lui cure tali che maggiori non avrebbe potuto avere da un fratello;
E’ certo comunque, che Ezzelino morì li 27 dello stesso mese di quest’anno.
1260 Strage cruenta nei confronti della famiglia di Alberico, anch’egli fatto morire tra impensabili crudeltà.
FINE