
Giovanni II Comneno
���
I MILLE ANNI
DELL�IMPERO
BIZANTINO
TRA INTRIGHI
COMPLOTTI
E COLPI DI STATO
��������
MICHELE DUCAS-PUGLIA
CAP.
VIII
L�EPOCA
DEI COMNENO
PARTE II
SOMMARIO: GIOVANNI II ASSUME IL POTERE E AFFRONTA
IL COMPLOTTO DEI FAMILIARI; LE GUERRE A DIFESA DELL�IMPERO; VENEZIA ACQUISTA
L�INDIPENDENZA; REGOLAMENTO DEI CONTI CON I CROCIATI (In nota Le quattro Armenie); �L�INCIDENTE
DI CACCIA - LA SCELTA DEL SUCCESSSORE E MORTE DI GIOVANNI II; MANUELE I INCORONATO
IMPERATORE; MANUELE PERDE LE SUE QUALITA� INIZIALI; I SUOI� MATRIMONI E LA NIPOTE CONCUBINA; MANUELE
TERRORRIZZA I TURCHI - PERDITA DI EDESSA; PARTE LA SECONDA CROCIATA CON CORRADO
III E LUIGI VII-RAPPORTI CON MANUELE (In Nota: ELEONORA D�AQUITANIA); LUIGI E
ELEONORA OSPITI AD ANTIOCHIA; RINALDO DI CHATILLON DA CAVALIERE DI VENTURA A
PRINCIPE DI ANTIOCHIA; RINALDO SACCHEGGIA CIPRO E CHIEDE PERDONO
ALL�IMPERATORE; TENTATIVO DI RUGGERO II DI CONQUISTARE L�IMPERO; IL TRAGICO
DISASTRO DI MIRIOCEFALO (In Nota: LA DINASTIA DANICHMENDITA); LA BATTAGLIA DI
HATTIN E LA VENDETTA DI SALADINO (In Nota: IL FEROCE SALADINO); LA GUERRA CON
VENEZIA E ANCONA SALVATA DALLA CONTESSA ALDRUDE; MANUELE VERSO LA FINE.�
�������������������������������������������������
������������������������
GIOVANNI II
ASSUME
IL POTERE
�E AFFRONTA
IL
COMPLOTTO
DEI
FAMILIARI
|
A |
bbiamo visto nella prima parte come Giovanni II era
riuscito, nonostante i maneggi e gli intrighi della madre Irene e della sorella
Anna, a impadronirsi e rinchiudersi nel palazzo,� assumendo le redini dell�impero.
Irene, la mattina seguente alla morte di Alessio (1118), aveva
fatto un ultimo tentativo, per impedirgli di assumere il potere, facendolo
chiamare per partecipare al funerale del padre e assistere alle funzioni funebri;
ma Giovanni non sentendosi ancora sicuro del potere acquisito, pens� bene di
non accettare l�invito, mandando parenti e amici perch� seguissero loro il
funerale.
Quando Giovanni si sent� pi� sicuro del proprio potere, rese
libero l�ingresso al palazzo e provvide ad assegnare le cariche ai parenti e
agli amici; testimoniando il suo affetto nei confronti del fratello Isacco, gli
riconobbe il titolo di �sebastocrator�
datogli dal padre, associandolo all�impero e alla mensa; tra i parenti aveva
nominato il cugino Giovanni Comneno conferendogli la carica di �parakoimomenos� (preposto al sacro cubicolo, vale a dire
colui che dormiva accanto alla camera del sovrano); questa nomina per� fu di
breve durata e gli fu tolta perch� costui, mostrando cipiglio e� alterigia, faceva tutto a modo suo e in
precedenza aveva gi� procurato grandi inquietudini a suo zio, l�imperatore
Alessio, per il suo carattere torbido e imperioso!
A Gregorio Taronite fu concessa la carica di �protovestiario�
(v. in Schede S., Cerimoniale e cariche
ecc.), il quale attenendosi alle disposizioni imperiali, le seguiva �senza fare passi pi� lunghi della gamba�
e cos� conserv� la carica per lungo tempo.
L�imperatore Alessio, padre
di Giovanni, nel novero dei suoi segretari, aveva Gregorio� Camatero (kamater�s-laborioso,
considerato da Niceta, soprannome, in effetti si ritiene fosse� da considerare proprio il cognome del
ministro) il quale, sebbene di bassa origine, era persona affidabile e onesta; era
stato nominato esattore delle imposte e
dopo essersi arricchito volle imparentarsi con l�imperatore il quale gli fece sposare
una sua parente, innalzandolo alla carica di �gran tesoriere�: Giovanni lo nomin� logoteta dei sekreta� (v. cit.� Cerimoniale e cariche ecc.).
Tra tutti coloro che avevano
ottenuto delle cariche, vi era Giovanni Axuch, persiano
di origine (i cronisti usavano spesso chiamare persiani i turchi, era figlio di un ufficiale di Solimano); era
stato fatto prigioniero quando Nicea era stata conquistata dall�imperatore Alessio
I, al quale era stato dato come dono; l�imperatore a sua volta lo aveva messo
al seguito di Giovanni di cui era coetaneo, come compagno di giochi, e per il
suo carattere era diventato �il pi�
amabile tra i suoi famigli e le sue guardie�.
Axuch tra tutti quelli che circondavano il nuovo imperatore era
il preferito e in gran confidenza, tanto da meritare il titolo di �paradun�steuon�, favorito
dell�imperatore e Giovanni gli assegna la carica di �gran domestico�; �questa carica,
essendo la prima imperiale comportava che tutti gli altri funzionari e anche
parenti dell�imperatore, dovessero scendere dal cavallo per salutarlo, ci� che
poteva suscitare delle invidie e dei risentimenti, ma Axuch
non solo era molto �accorto e preparato
nel lavoro che svolgeva, ed era bravo nel maneggio delle armi, ma era anche
liberale e benefico verso i bisognosi, al punto che questa sua generosa
inclinazione lo aveva messo al di sopra delle invidie e aveva fatto dimenticare
le sue� origini e gli aveva guadagnato
l�affetto di tutti.
Non era passato ancora un anno di governo, che la gelosia
di molti di coloro che gli stavano vicino e della stessa madre Irene e della sorella
Anna (che aveva un largo seguito), le aveva spinte a preparare una cospirazione
contro Giovanni �e l�incarico del colpo
di Stato era stato dato a Niceforo Briennio �che rivestiva la carica di �cesare�.
Briennio aveva un largo seguito, per essere un uomo
brillante, di bell�aspetto, alto e regale, particolarmente apprezzato tra gli
intellettuali per la sua cultura; oltretutto come marito di Anna faceva parte
della stessa famiglia imperiale, e aveva inoltre il favore dell�imperatrice
Irene.
Peraltro, le sue doti fisiche, evidenziavano un contrasto
con il mediocre aspetto di Giovanni, malfatto nel fisico, di bassa statura e di
pelle olivastra, che gli avevano valso il soprannome ironico di Kaloioannes (Giovanni il Bello, ma il riferimento, come
vedremo, era alla bellezza del suo spirito), che non ancora si era avuto modo
di scoprire , come anima di natura sublime, generosa e superiore a quella di
Briennio.
I congiurati avrebbero dovuto approfittare della
circostanza che Giovanni dormiva nella casina di caccia che faceva parte
dell�ippodromo, denominata �philopation�, poco lontana dalle porte di terra delle mura,
e avevano corrotto il comandante della guardia addetto all�ingresso, da dove essi
sarebbero entrati; costoro attesero la venuta di Briennio, fissata all�una dopo
mezzanotte, ma gli scrupoli e l�innata pigrizia e indecisione gli fecero
rinunciare all�impresa e Briennio non si present� e i cospiratori si
dispersero.
Fu allora che venuta a conoscenza della infingardaggine
del marito ��la kaisarissa Anna, furente per l�indolenza
del marito, se ne indign� e rimprover� aspramente la natura, accusandola di
aver fatto a lei il sesso diviso e incavato e a Briennio il sesso eretto e
sferico�!; ma qualche altro cronista riporta una versione pi� castigata,
secondo la quale Anna si era lamentata che ��la natura
aveva dato alla donna l�anima formata per il maschio�!
Il giorno seguente propagatasi la notizia della
cospirazione, l�imperatore non volle far ricorso alla violenza� con punizioni cruente che i cospiratori
meritavano e provvide solo a disporre la confisca dei loro beni che dopo non
molto tempo furono restituiti.
Quanto alla principessa Anna, l�imperatore, recatosi in
compagnia di Axuch in una delle sue stanze nel
gineceo, la trov� piena di tutti i suoi tesori in oro, argento, abiti e stoffe,
e sospirando, rivolto ad Axuch disse �ahim�, i miei congiunti mi sono nemici e gli
stranieri amici; giacch� il delitto ha rovesciato l�ordine della natura,
seguiamo quella del merito�, aggiungendo che quelle ricchezze le donava a
lui.
Ma Axuch gettandosi ai piedi
dell�imperatore e chiedendo perdono, �gli
disse che lo ringraziava per i preziosi doni, ma non doveva dimenticare che la principessa, sebbene meritasse il suo
sdegno, era sua sorella e continuava ad esserlo e che il suo carattere augusto
concessole dalla natura non poteva essere cancellato: il suo pentimento
ravviver� il sentimento; accordale il perdono, dimentica che abbia potuto odiarti
perch� se ne possa ricordare per amarti maggiormente; l�hai vinta con la tua
clemenza, perfeziona questa vittoria lasciandole i beni perduti; questo �
patrimonio di famiglia ed � atto di giustizia che esso torni a lei e sarebbe
profanato se finisse in altre mani; io per mio conto sono gi� colmo dei tuoi
benefici e sar� sempre tanto ricco finch� sar� onorato della tua benevolenza�.
L�imperatore dispose quindi che i beni fossero restituiti,
ma nello stesso tempo che sia Irene (sebbene fosse, come abbiamo visto, dalla
parte della figlia, non aveva partecipato alla cospirazione), sia Anna, fossero
ambedue confinate nel monastero di Kecharitomene
fondato da Irene accanto all�altro di Philatropos dove
Anna passer� tutto il resto della sua vita (1154).
Dopo questo avvenimento e nei venticinque anni di
regno,� non vi furono altre cospirazioni
contro l�imperatore il quale abol� in tutto l�impero la pena di morte;
severo� con se stesso e indulgente con il
suo prossimo, ridusse il fasto della Corte; senza assumere gli atteggiamenti
tirannici, poco a poco riform� in maniera sensibile i costumi pubblici e
privati. �
Ostrogorskji scrive che a detta di tutti gli storici �� ritenuto il pi� grande dei Comneni per rettitudine,�
per nobilt� e forza di carattere; egli inoltre alla astuta prudenza
accoppiava energia sicura, pieno di moderazione�
ma fermo e inflessibile nel perseguire i suoi fini, con perseveranza
prosegu� nella politica di suo padre, senza perdere di vista i confini del
possibile�.
Giovanni aveva sposato Irene, figlia di Ladislao
d�Ungheria dalla quale aveva avuto quattro figli maschi Alessio, Andronico,
Isacco e Manuele; Alessio era stato investito della porpora imperiale e nella
proclamazione annuale il padre gli dava il titolo di imperatore; al secondo,
Andronico, fu assegnata la carica di �sebastocrator�;
costoro moriranno giovani, colpiti uno dopo l�altro da una forte febbre
(Andronico aveva avuto un figlio di nome Giovanni che troveremo alla presa di
Corf� e raccomander� al figlio la vendetta, v. sotto par. Ruggero II);
rimarranno gli altri due Isacco e Manuele; delle tre femmine la prima delle
quali, Maria, era gemella di Alessio, and� in sposa a Ruggero della famiglia
dei principi di Capua il quale spogliato da re Ruggero di Sicilia dei suoi
beni, and� a rifugiarsi presso l�imperatore dal quale ebbe il titolo di cesare; questa principessa mor� durante
i primi anni del regno del padre; la seconda divenne moglie di Stefano Contostefano al quale fu assegnato il
titolo di granduca e gli fu concessa
l�isola di Corf�, occupata da Ruggero II di Sicilia, e mor� durante l�assedio
di Manuele (1149); la moglie continu� a reggere l�isola con i numerosi figli
avuti dal marito; la terza spos� il generale Teodoro Vatatze.
������������������������������������������������������
LE GUERRE A DIFESA
DELL�IMPERO
|
G |
iovanni II aveva la passione delle armi e alle calde mura
del palazzo preferiva le intemperie e l�aria aperta che respirava seguendo
l�esercito e al lusso del palazzo, le frugalit� della tenda, e con l�esercito
passer� quasi tutti i ventiquattro anni di regno, mostrandosi un ottimo
generale.
Per mantenere intatti i confini dell�impero (sebbene
sognasse di ingrandirlo riportandolo all�antica estensione), aveva dovuto
combattere sin dall�inizio del regno; comunque al suo interno, aveva la spina
nel fianco dei quattro feudi crociati (*) i cui feudatari, nonostante i loro
giuramenti, non riconoscevano altri che il re di Gerusalemme.
Giovanni dovette affrontare per primi i turchi che
rompendo i trattati stipulati con l�imperatore Alessio I, avevano incominciato
a saccheggiare alcune citt� della Frigia (che rappresentava per l�impero un
passo strategico lungo la costa dell�Egeo); egli si rec�� subito al suo capoluogo, la citt� di Laodicea
(1119), governata dall�emiro Abuchara (nominalmente
dipendente dal sultano di Iconio), e dopo averla cinta di mura e aver lasciato
un presidio, torn� a� Costantinopoli.
Dopo essersi riposato, anche per tenere le truppe allenate
(aveva
diviso l�esercito in base alla etnia dei soldati, in greci, macedoni, peceneghi
e turchi), part� per una spedizione in
Panfilia (Anatolia sud-occidentale), per conquistare la citt� di Sozopoli, difficile da espugnare per la sua posizione su
una montagna inaccessibile e scoscesa, alla quale si saliva attraverso uno
stretto sentiero, difesa peraltro da fanteria pesante.
Egli pens� quindi a uno stratagemma: la sua cavalleria era
comandata da un certo Paktiarios al quale sugger� di
girare intorno alle mura lanciando frecce; se i soldati dall�interno fossero
usciti, essi non dovevano combattere ma darsi alla fuga fino a raggiungere dei
sentieri reconditi e boscosi che erano nelle prossimit�, dove si sarebbero trovati
nascosti altri cavalieri; in una di queste incursioni, i turchi uscirono dalla
citt� e inseguirono i cavalieri greci, pensando a rincorrere e catturare i
fuggitivi; i cavalieri si infilarono nelle strettoie dove un�altra parte della
cavalleria greca era in agguato e uscita dalle strettoie si diresse verso la
citt�; i primi cavalieri inseguiti si rivoltarono e i turchi fecero
altrettanto, ma si trovarono circondati e in parte furono passati a fil di
spada, in parte fatti prigionieri e la citt� fu cos� conquistata; dopo Sozopoli furono conquistate altre piazzeforti, villaggi e
castelli.
Circa quattro anni dopo (tra il 1121-1122) i peceneghi
attraversato il Danubio andarono a saccheggiare la Tracia; Giovanni, va ad
accamparsi presso la citt� di Berea (in Tracia) e per
sondare le loro intenzioni, manda personaggi che parlavano la loro lingua,
offrendo doni e allestendo banchetti per i loro ufficiali; i peceneghi (v. in
Schede: I peceneghi ecc.) erano divisi in trib� e non avevano un unico capo e
di questo ne approfitt� Giovanni che con alcuni di essi riusc� a fare la pace,
con gli altri ebbe un terribile scontro.
I peceneghi fecero ricorso a un insolito stratagemma;
formarono con i loro carri ricoperti di pelli, sui quali� erano nascosti� donne,�
bambini e soldati, un grande cerchio come una palizzata, attraversato da
entrate oblique, in modo che quelli che combattevano in campo aperto, si
rivoltavano e correvano verso il cerchio e nello stesso tempo i cavalieri che
li inseguivano venivano colpiti dai peceneghi che erano sui carri.
Giovanni vedendosi in questa situazione disperata,
rivolgeva i suoi gemiti alla �Madre di
Dio (la cui icona gli imperatori portavano sempre in battaglia); rasserenatosi,
riun� il corpo della sua guardia che aveva scudi giganteschi e asce a un taglio,
con cui form� un muro che sfond� la barriera di carri e a questo modo si pot� affrontare
lo scontro diretto.
I peceneghi cos� sopraffatti si diedero alla fuga, ma
inseguiti furono fatti prigionieri; all�imperatore si presentarono i familiari
di costoro dicendo che volevano vivere sotto le leggi dell�impero e furono loro
assegnate delle terre da essi coltivate, dove sorsero dei villaggi; altri, fra
i pi� prestanti, furono assegnati come soldati all�esercito, altri ancora furono
offerti ai soldati come bottino e venduti come schiavi; tornato a
Costantinopoli, l�imperatore indisse �la
festa dei pazinaci�.
Dopo questa guerra, segu� quella con i serbi; sebbene non
fossero ancora potenti, incominciarono a fare scorrerie; avevano distrutto il
castello di Raso che era fuggito a Costantinopoli, ma fu punito per la sua
vilt� e vestito da donna fu portato in giro per la citt� e per la gran piazza.
L�imperatore partito per quest�altra campagna, fece molti
prigionieri dei quali, alcuni furono assunti nell�esercito, altri furono
portati nelle campagne di Nicomedia rimaste spopolate
dalle scorrerie dei turchi. ��
Un�altra campagna attendeva Giovanni, quella con gli
ungari, che attraversato il Danubio assalirono Belgrado con i cui materiali costruirono
al di l� della Sava, una citt� che chiamarono Z�ugmine;
il pretesto della guerra era che gli abitanti di Belgrado maltrattavano e
spogliavano i mercanti ungari,� ma vi era
anche un motivo politico.
Il re Ladislao aveva avuto come successore il nipote
Calomanno (di cui si � parlato nella parte precedente), in quanto vigeva il
costume che successori erano i fratelli del re e non i figli; questi fratelli
vivevano in buoni rapporti, fin quando il re non fosse divenuto padre: la
nascita di un figlio soffocava ogni sentimento fraterno; il regnante in questo
caso, per far succedere il proprio figlio, faceva cavare gli occhi ai propri
fratelli.
Calomanno divenuto padre fece accecare suo fratello Almo e
poi lo fece uccidere in una chiesa; il figlio di questo, Bela, fu anche
accecato, ma riusc� a fuggire andando a rifugiarsi dall�imperatore a
Costantinopoli; alla morte di Calomanno (1116), gli succedette il figlio
Stefano �II (1101-1131), il quale intendeva
far scacciare Bela dalla corte, ma non essendo riuscito, fece la guerra all�imperatore
il quale riusc� a impadronirsi di tutto il territorio� pi� fertile dell�Ungheria, tra i fiumi Sava e
Danubio e oltre alla citt� di Zeugmite e del castello
di Crame, fece costruire una fortezza sulle rovine di
Belgrado dove lasci� una guarnigione agli ordini di Curticio
e se ne torn� a Costantinopoli.
Appena vi giunse, venne a sapere che la fortezza di
Belgrado era stata attaccata dagli ungheresi e i soldati trucidati o presi
prigionieri, era riuscito a salvarsi solo un piccolo gruppo con Curticio, che l�imperatore irritato fece sferzare, sebbene
egli avesse dimostrato di non aver abbandonato la fortezza �se non dopo che era stato dato fuoco agli
edifici.
L�imperatore part� nel cuore dell�inverno e si trattenne a
Belgrado, dove fece rialzare il forte; ma privo di foraggi, informato
dell�arrivo di Stefano, avendo pochi soldati con s�, ritenne opportuno
abbandonare la fortezza, inseguito da Stefano, che non riusc� a raggiungerlo in
quanto Giovanni aveva preso strade quasi impraticabili; tra i due sovrani fu poi
sottoscritto un trattato di pace.
Borice, figlio di Stefano, ma di madre diversa, al quale
Calomanno aveva fatto cavare gli occhi, aspirava anch�egli al regno del padre,
e si era recato in Grecia, sperando nell�aiuto di Giovanni e di sposare una sua
parente; ma Giovanni se ne astenne, in modo che Bela II il Cieco� (1131-1141) divenne pacifico possessore del trono
d�Ungheria.
VENEZIA
ACQUISTA
L�INDIPENDENZA
|
E |
ra giunto anche il momento delle contestazioni con
Venezia: il doge Domenico Michiel (1116/17-1129/30), aveva chiesto a Giovanni il
riconoscimento dei privilegi avuti da Alessio I che Giovanni non volle
riconoscergli, e i veneziani presero le armi contro i greci; a sua volta
Giovanni, trattandoli da ribelli espulse i commercianti dall�impero, facendo
devastare i loro possedimenti in Dalmazia.
La flotta veneziana che aveva aiutato Baldovino II a conquistare
Tiro, fece subito vela verso le isole di Rodi e�
Schio, occupandole e trattenendosi durante l�inverno; nella primavera
seguente furono saccheggiate Samos, Mitilene e le Andros e sbarcate
nel Peloponneso, le truppe distrussero le mura di Modone,
facendo prigionieri ragazze e ragazzi, ritornando a Venezia carichi di bottino;
fu in quest�epoca (1124) che Venezia si liber� definitivamente della sua
dipendenza da Bisanzio.
Dopo aver riportato una ulteriore vittoria con i turchi,
Giovanni, impossessandosi della fortezza di Castamone,
rientrava a Costantinopoli con un gran numero di prigionieri; nel giorno del
suo ingresso, le strade furono ornate� di
tappezzerie e furono allestiti dei palchi lungo la strada che dalla porta Orientale
conduceva alla chiesa di santa Sofia; si vide sfilare un cocchio fregiato
d�argento e guarnito di pietre, tirato da quattro cavalli bianchi che in luogo
dell�imperatore portava l�icona della Vergine della quale l�imperatore era
devoto e alla quale egli attribuiva i suoi successi, egli lo seguiva umilmente
a piedi nudi con una croce in mano.
Dopo aver affrontato nuove guerre con i turchi, per dieci
anni in Paflagonia, Cilicia e Cappadocia, ritornando vincitore, giunse il
momento per regolare i conti con i crociati.�
�
L�anno seguente, prima di partire per Antiochia, Giovanni
combattendo con i turchi in Bitinia e nel Ponto, aveva portato con s� il figlio
Manuele che aveva raggiunto i diciotto anni, il quale durante un combattimento
si butt� da solo nella mischia, raggiunto dal suo squadrone, che� lo aveva liberato dal pericolo corso; il
padre dopo averlo elogiato lo fece stendere per terra a pancia in gi� e lo fece
frustare per la sua insubordinazione; anche in altre occasioni Manuele,� aveva dato prova di coraggio meritando,
l�affetto del padre che lo ritenne degno di occupare il trono.
In questo periodo Giovanni si vide abbandonato dal nipote
Giovanni, figlio di Isacco al quale l�imperatore, avendo visto un cavaliere
crociato rimasto senza cavallo, gli chiese di dargli il suo; Giovanni irritato,
dopo aver dato il cavallo, se ne and� presso il sultano di Iconio Masoud e abbracciando la religione islamica ne spos� la
figlia prendendo il nome di Zelebis (di nobile
nascita): in seguito Maometto II che conquister� Costantinopoli (1453) si
vanter� di discendere da Soliman Schah,
figlio di Zelebis;
Anche il padre Isacco per uno screzio con il fratello,
ingrandito dai pettegolezzi della corte, se ne and� dal sultano di Iconio; egli
era di alta statura e aveva un aspetto maestoso, ben diverso dal fratello, con
alcune qualit� superiori che si manifestavano in base alle occasioni che si
presentavano; ma privo di danaro non veniva apprezzato dagli emiri che non
davano alcun valore alla sua illustre nascita e non godeva dei privilegi di cui
aveva goduto stando all�ombra del trono, per cui torn� dal fratello che non gli
serb� alcun risentimento; ma l�ambizione di Isacco riemerse quando suo fratello
si era recato ad Antiochia; i ministri lasciati da Giovanni scoprirono i suoi
intrighi e l�imperatore dispose il suo trasferimento a Eraclea, dove rimase
prigioniero fin dopo la morte dell�imperatore.
REGOLAMENTO
DEI CONTI
CON I CROCIATI
RAIMONDO DI POITIERS
|
A |
bbiamo visto nella prima parte, come i crociati avevano
costituito quattro feudi: il principato di Antiochia che si estendeva da Tarso
fino a Maraclea presso Tortosa, la contea di Edessa
che si estendeva dall�Eufrate al Tigri; la contea di Tripoli da Maraclea fino al fiume Adoni fra Biblo e Baruth e il regno di Gerusalemme che dal fiume Adoni si
estendeva fino all�Egitto; i rispettivi vassalli, pur avendo prestato il
giuramento di sottomissione all�imperatore, in effetti si sentivano vassalli
del re di Gerusalemme, al quale avevano prestato giuramento e agivano per proprio
conto, non sentendosi legati all�imperatore.��
Giovanni dal suo canto non perdeva di vista il principato
di Antiochia, vanamente reclamato dal suo predecessore Alessio I; titolare del
principato era Boemondo II, che aveva sottomesso come abbiamo visto, la Quarta
Armenia (*), che si trovava tra le montagne della Cilicia, prendendo prigioniero
il re Leone; Boemondo II era morto (1130) durante una imboscata tesagli da Ghazi, figlio dell�emiro Danishmand
(che trent�anni prima aveva catturato il padre Boemondo I) - e non in un
combattimento con Zenki (come riportato da alcuni
cronisti); la sua testa bionda era stata imbalsamata e mandata in una scatola
d�argento� come dono al sultano.
Egli lasciava una figlia di nome Costanza (di otto anni)
che era stata proposta come moglie all�imperatore, il quale pi� abile a vincere
che a negoziare rifiut�, perdendo l�occasione di avere, senza combattere, la
capitale della Siria che tanto desiderava; come vedremo la sposer� il figlio
Manuele.
Tutore della piccola principessa era Folco, re di
Gerusalemme, il quale per caso aveva incontrato Raimondo (1115-1149) figlio di
Guglielmo IX, conte di Poitiers e di Filippina di Tolosa, il quale travestito
da mendicante faceva il viaggio nei luoghi santi in cerca di indulgenze; Folco
lo riconobbe e volle concedergli la grossa fortuna di fargli sposare, con il
consenso dei suoi consiglieri, la piccola Costanza: presa in moglie Costanza
(1136), Raimondo si trasfer� ad Antiochia e dopo aver messo in libert� il re di
Armenia, si un� a lui per combattere i greci.
L'imperatore, dal suo canto, si alle� con i turchi; la
guerra fu lunga, ma Giovanni �nonostante
la difficolt� dei luoghi e il numero dei nemici, si rese padrone di tutta la
Cilicia e and� a porre l'assedio ad Antiochia; il re di Gerusalemme� aveva promesso aiuti a Raimondo, ma egli
stesso assediato a Montferrand� implorava inutilmente l'aiuto dei crociati.
Raimondo, di ritorno da una spedizione, trov� la sua citt�
assediata dai greci; con estrema audacia egli penetr� di notte con un gruppo di
cavalieri nell�accampamento dei greci, uccidendo chi si opponeva al suo
passaggio e riusc� a entrare nella citt�; tutto il campo dei greci era stato
preso dal terrore con i soldati morti o feriti, senza che si vedessero nemici;
l�imperatore propose quindi un incontro con Raimondo ricordandogli il
giuramento fatto dai crociati, che gli avrebbero dovuto consegnare le piazze
conquistate ai turchi.
Raimondo rispose che non poteva essere garante delle
promesse di Boemondo, avendo ricevuto la citt� come dote della moglie e avendo
prestato giuramento al re di Gerusalemme; il re Folco, consultato rispose che
non poteva contestare il diritto dell�imperatore e Raimondo dovette recarsi a
Costantinopoli a prestare giuramento (1143), riconoscendosi feudatario dell�impero.
Sulla cittadella fu issato il vessillo imperiale e Giovanni
si assicur� che le porte della citt� sarebbero state sempre aperte quando
l�imperatore avesse desiderato entrare; a sua volta egli concesse al principe
di Antiochia il possesso delle citt� che insieme sarebbero state conquistate ai
turchi (**).
L�imperatore si apprest� a marciare con i propri soldati,
mentre i due principi, di Antiochia e di Edessa, lo secondavano mollemente,
prendendo qualche citt�; dopo questa prima campagna, l�imperatore rientr� ad
Antiochia (1138) ricevuto trionfalmente dal patriarca e dal popolo con i
principi cristiani che tenevano le briglie del suo cavallo e l�imperatore si
insedia nel palazzo.��
Giovanni prima di ripartire voleva essere sicuro di
rimanere padrone della citt� e aveva chiesto di avere per s� la cittadella, per
la difesa contro i musulmani; i principi colpiti da questa proposta non osarono
opporsi apertamente ma il conte di Edessa �opponendo
l�artificio alla cattiva fede, chiese
all�imperatore, del tempo per convincere la popolazione�; ma la popolazione
fu sollevata contro l�imperatore e tutti i crociati si armarono e si
avventarono contro i greci.
Il principe di Edessa, recatosi dall�imperatore e
mostrando spavento, si gett� ai suoi piedi e gli disse che i crociati volevano
massacrarlo;� al che l�imperatore temendo
il pericolo, decise di abbandonare il palazzo e raggiunse precipitosamente il
suo accampamento; qualche giorno dopo i principi, recatisi dall�imperatore,
furbescamente, lo supplicarono di rientrare in citt�, ma l�imperatore
contrariato nelle sue intenzioni, decise di tornare a Costantinopoli.
Dopo altri scontri con i turchi, dai quali era uscito
vincitore, impadronendosi di tutte le isole del lago di Iconio, Giovanni,
segretamente, accarezzava l�idea di cacciare i turchi dalla Palestina e rendere
omaggio al santo Sepolcro; si rec� nuovamente ad Antiochia, dove si rifiutarono
di aprirgli le porte e il legato del papa Innocenzo II gli proib� di entrare
nella citt�;� Giovanni, irritato, diede alle
fiamme e mise a sacco il territorio circostante (1142), distruggendo le messi e
i frutti e tagliando alla base gli alberi fruttiferi, non risparmiando gli
eremiti che vivevano sparsi nella campagna e bruciando le loro celle.
Giovanni si era ripromesso di andare a visitare il santo
Sepolcro per donare la sua corona e una lampada che aveva fatto fare, di venti
libbre d�oro (tra sei e dieci chili), e aveva chiesto il permesso a Baldovino,
il quale gli rispose che sarebbe stato onorato di riceverlo, ma non era in
grado di nutrire la sua armata, in quanto poteva concedere ospitalit� a non pi�
di diecimila uomini: ci� comportava la possibilit� che i crociati, potendo
affrontare questo numero di soldati, avrebbero potuto farlo� prigioniero; Giovanni dissimulando il suo
risentimento se ne torn� in Cilicia dove lo attendeva un tragico incidente di
caccia che lo avrebbe privato della vita.�
��������������������
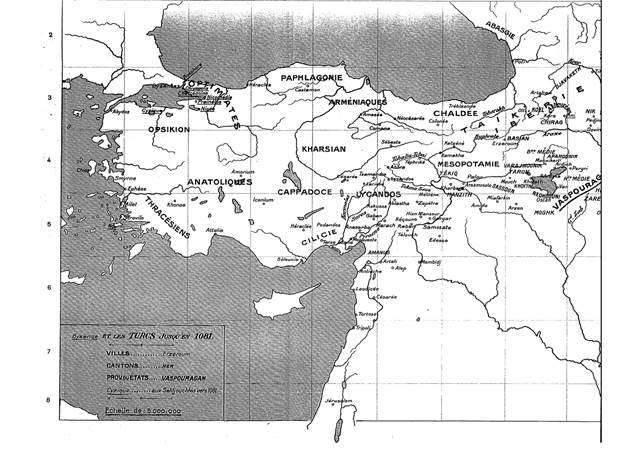
*) LE QUATTRO ARMENIE�
|
A |
lla prima grande Armenia, provincia
romana creata da Diocleziano, con capoluogo Melitene,
con Teodosio si ebbe l�Armenia I con Sebaste e Settala e Armenia II con Melitene; Giustiniano (536) riorganizz� l�insieme delle
province armene in grande e piccola con la seguente ripartizione: Armenia I
comprendeva Erzeroum, Setala,Nicopoli,
Colonea, Trebisonda e Cerasonte,
con capoluogo Giustinopoli; l�Armenia II comprendeva
Sebaste, Comana,Zela e Berissa,
con capoluogo Sebaste; l�Armenia III, formata da Giustiniano con Melitene, Arca, Arabissos, Ariarathe, Comana II e Cucusos,
capoluogo Melitene; l�Armenia IV era la parte che
fronteggiava Melitene fino al Tigre e Martyropolis al di l� del fiume.
Dopo la divisione con i persiani (591),
l�imperatore Maurizio oper� una ulteriore divisione amministrativa: la Armenia
I era costituito dal territorio di Melitene;
l�Armenia II quello di Sebaste;�
l�Armenia III scomparve e appariva invece una provincia della Grande
Armenia� che comprendeva la valle
dell�Eufrate; l�Armenia IV di Giustiniano fu mantenuta e denominata
Mesopotamia, ma fu aggiunta una seconda Armenia IV o Giustiniana con le citt�
di Dadima, Arsamosate, e Kitharizon e rimase con questo nome per lungo tempo, per i
bizantini e gli armeni.
L�Armenia interiore fu formata dal
territorio di Erzeroum e Kars,
dopo la valle di Tchorokh fino all�Araxe� e si �estendeva tra Kars e
il lago di Sevan, e , in questi limiti, dall�Araxe al
Kour.
Gli arabi designavano Armenia I le citt�
di Arran, Sisakan, Chirvan, Bailakanne Bardaa, vale a dire la Siounie,
l�Albania e la Transcaucasia orientale fino al
Caspio; Armenia II la Georgia, e la Trancaucasia
occidentale; l�Armenia III il Vaspouragan, Douin, Chirag, Bagr�van e Nakhtich�van, vale a
dire il nocciolo della Grande Armenia entro il Kour,
l�Araxe e il lago di Van; l�Armenia IV, Chimchat, Kalikala, klath, Ardjech, Badjoun, vale a dire l�Armenia occidentale.
Successivamente gli armeni designavano
come Armenia I Sebaste, Melitene e Cesarea di
Cappadocia; Armenia II Cesarea, Sebaste, Erzindjan e Kamakha; Armenia III Melitene con
Mouch e Van e Cesarea; quello di Armenia interiore e
Armenia inferiore alle stesse contrade dei bizantini inserite tra l�Armenia
dell�Eufrate e la Cilicia e successivamente, in periodo crociato, come abbiamo
visto costituito dal territorio della Cilicia e del monte Tarso.�
Gli armeni erano nemici dei greci ai
quali erano stati lungamente soggetti e dai quali desideravano staccarsi;
avevano lingua e caratteri particolari e pur seguendo la stessa religione, �concordavano con i greci sugli articoli
religiosi, ma non nella pratica: recitavano le preghiere in volgare; non
digiunavano negli stessi giorni e non celebravano negli stessi giorni dei greci
e durante la messa non mescolavano nel calice l�acqua col vino; nella loro
quaresima si astenevano dalla carne, dalle uova, dai latticini, dal pesce,
dall�olio e dal vino, ma mangiavano frutta e legumi in tutte le ore del giorno;
inoltre avevano un proprio calendario.
Quando gli armeni avevano ricevuto
l�investitura dall�imperatore Enrico, attraverso l�arcivescovo di �Magonza, essi promisero ubbidienza al papa ma non
vollero cambiare nessuna delle loro osservanze; come soldati erano selvaggi
come le montagne dove abitavano e in eterna lotta con i turchi (durata fino
alla prima guerra mondiale quando l�impero ottomano fece ricorso al genocidio tra
il 1915-1916 in cui ne furono massacrati circa un milione e mezzo, circostanza che
i turchi contemporanei continuano a fare l�errore di negare, o non volerne
parlare, dal momento che essi non possano essere ritenuti responsabili di ci�
che in passato avevano fatto i loro predecessori!
L�eroe della indipendenza armena era
stato Thoros che con il padre, il re Leone e il
fratello Rupen, erano stati fatti prigionieri da
Giovanni II; pi� fortunati erano stati tre altri figli di Leone, Constantin, Sdephan� e Mich i quali erano scappati,
andando a rifugiarsi dal loro parente (per via di matrimonio) Jocelin, conte di Edessa; anche Thoros
sposer� una latina, la figlia di Simone signore di Raban.
��
**) Berea, Larissa, Epifania, Emeso-Aleppo, Schisal, Hamar, Hems. �
L�INCIDENTE DI
CACCIA
�DI
GIOVANNI II
E LA SCELTA
DEL SUCCESSORE
|
G |
iovanni si trovava in Cilicia e durante una caccia a un
grosso cinghiale che gli si stava avventando contro al quale infila la lancia
nelle viscere; per il contraccolpo la lancia gli capovolge la faretra e una
delle frecce che avevano la punta avvelenata gli ferisce la mano; inutili furono
le cure prestate; i cacciatori in caso di ferite usavano togliere un pezzo di
pelle dal tallone e metterla sulla ferita ... l�espediente non ottenne alcun
risultato; la mano incominci� a gonfiarsi, una incisione non aveva dato alcun
risultato e il gonfiore era cresciuto tanto da raggiungere le dimensioni di una
coscia d�uomo; i chirurghi pensarono di amputargliela, ma l�imperatore rifiut�;
le discussioni dei medici non portarono ad alcuna conclusione; frattanto
scoppi� un forte temporale, l�accampamento si allag� e la tenda nella quale si
trovava l�imperatore dovette essere spostata; l�imperatore aveva sulle labbra
il vaticinio che gli aveva predetto �in
luoghi acquosi cadrai contro l�aspettativa� e un altro �Oh come diverrai pasto di orribili corvi�
su cui si imbastirono discussioni e interpretazioni bizantine sui vari
significati!
Sta di fatto che l�imperatore resosi conto che non sarebbe
sopravvissuto, radun� tutti i parenti e dopo aver fatto una breve cronistoria
della sua vita, vissuta per la maggior parte sotto una tenda e negli
accampamenti all�aria aperta piuttosto che a palazzo e della conquista di varie
citt� a lui tutt�ora sottoposte, giunse a toccare il punto principale della
successione che non sarebbe stata quella naturale del passaggio dell�impero al
figlio maggiore vivente (Isacco, mentre i primi due Alessio e Andronico erano
premorti) ma al minore (Manuele o Emanuele), spiegandone i motivi: La coppia, sebbene originata da un unico padre
si divide per le differenti disposizioni d�animo di ambedue; sono tutti e due
belli, spiccano per la forza fisica, la nobilt� dell�aspetto, la profondit� di
pensiero, ma dei due si � mostrato di gran lunga migliore per il governo
dell�impero l�ultimogenito Manuele. Mentre
Isacco mi si � mostrato spesso collerico, irritato da futili motivi, vittima di
quella sconfinata animosit� che rovina anche i saggi a causa della quale la
maggior parte agisce in modo sconsiderato, l�altro (Manuele) invece con la restante serie di virt� di cui
nemmeno Isacco � sprovvisto, non � neppure privo del grande bene della mitezza,
cede facilmente quando � utile e si mostra facilmente docile al freno della
ragione .... poich� noi uomini usiamo sottometterci �all�innocenza del cuore .... ho scelto come
imperatore Manuele; accogliete dunque il ragazzo come signore unto da Dio e
come regnante per mia decisione .... e sistemate cos� la questione della
successione�; dopo due giorni Giovanni II spir� (1143) dopo aver regnato
per ventiquattro anni e otto mesi.� �
Riassumendo le qualit� dell�imperatore, Niceta ne fa
l�elogio scrivendo che: Aveva
amministrato benissimo il potere; �di
carattere non dissoluto n� eccessivo, era stato munifico nei doni e nelle
spese, distribuendo agli abitanti della capitale monete d�oro� ed edificando chiese grandissime e
bellissime; si curava a tal punto dell�aspetto esteriore del suo seguito che
faceva attenzione al taglio dei capelli e alle suole delle scarpe se erano
state ben cucite e secondo la forma del piede di chi le calzava; durante il suo
regno non vi furono a corte pettegolezzi o parole sconvenienti nel corso delle
pubbliche udienze; non vi era stata sregolatezza nel vestire e nel mangiare;
pur non essendo difficile da trattare o inavvicinabile,� era piuttosto arcigno e spesso collerico ma
nell�intimit� non trascurava il discorso faceto e non soffocava il riso;
durante il suo regno (come abbiamo gi� detto) non priv� nessuno della vita e
non inflisse pene corporali; degno di lode entro la stirpe dei Comneno�, conclude
Niceta, �super� anche molti altri
imperatori del passato�.
MANUELE I
INCORONATO
IMPERATORE
|
M |
entre Manuele I (1118-1180) veniva acclamato imperatore
(1143) nell�accampamento, il fratello Isacco si trovava insediato nel palazzo a
Costantinopoli ed essendo primogenito rispetto al fratello, non pensava
minimamente che il padre avrebbe fatto una scelta diversa.
Il fedele Axuch fu incaricato da
Manuele di recarsi nella capitale per preparargli il terreno prima che �arrivasse la notizia della sua nomina; Axuch, accompagnato da un militare (Basilio Tzintzilakes), giunto a palazzo fece prelevare Isacco,
facendolo rinchiudere nel monastero del Pantokrator; Isacco
apprende cos� della morte del padre e che suo fratello minore era stato
nominato imperatore, se ne rammarica dicendo che il diritto sarebbe spettato a
lui,
Axuch oltre che a tenere a bada i possibili sostenitori di
Isacco si rec� in santa Sofia mostrando al clero il diploma dell�imperatore che
assegnava diecimila franchi in argento a ciascun membro del clero che si fosse
dichiarato in suo favore (ma Axuch aveva anche un
secondo diploma in cui la cifra era stabilita in oro, qualora la prima non
fosse stata ritenuta sufficiente!); il clero ritenne l�offerta in argento sufficiente a soddisfare la propria avidit�
e non vi fu bisogno del secondo decreto.
Manuele era rimasto in Cilicia per rendere gli onori a suo
padre il cui feretro, che aiutava a portare anch�egli sulle spalle, fu messo su
una nave e mandato a Costantinopoli via mare (Manuele fece costruire nel luogo
dove il padre era morto un monastero).
Il principe Raimondo di Antiochia ritenendo di poter
riparare col nuovo imperatore alle perdite subite, gli sped� ambasciatori per
chiedergli la restituzione delle terre della Cilicia, appartenute al principato,
ma Manuele rispose che trattandosi di restituzione occorreva restituire
all�impero la stessa citt� di Antiochia che gli apparteneva per doppio titolo,
sia per l�antico possesso, sia per il trattato stipulato con i crociati e in
caso di diniego egli avrebbe fatto ricorso alla forza.
Manuele col suo esercito lasci� quindi la Cilicia dirigendosi
a Costantinopoli, attraversando l�Isauria, la
Licaonia e la Frigia senza chiedere il permesso di passaggio ai turchi che ne
erano gli occupanti e senza perdere nessuno dei suoi uomini, all�infuori dei
due principi Andronico (che vedremo come protagonista della vita da romanzo), indicato
dagli storici come �cugino� dell�imperatore Manuele, ma in effetti pronipote (Andronico
infatti era figlio di Giovanni Comneno, a sua volta figlio di Andronico, premorto
a Manuele), e Teodoro Dasiote il quale aveva sposato Maria,
figlia del detto �Andronico, �i quali allontanatisi dall�esercito per andare
a caccia �furono fatti prigionieri dai
turchi e portati dal sultano di Iconio Masoud (*).
Manuele che intendeva raggiungere Costantinopoli quanto
prima, non si sofferm� per recuperare i due prigionieri e per questo fu
accusato �di indifferenza nei confronti
dei suoi parenti, ma li liberer� in seguito, senza pagare alcun riscatto.
Il feretro dell�imperatore defunto giunse a Costantinopoli
prima di Manuele e fu messo dal Senato nel mausoleo accanto alla imperatrice
Irene nella chiesa del Pantocrator;
quando giunse, Manuele fu accolto dal popolo numeroso e festante che ne
ammirava il coraggio, la magnanimit�, la passione per la gloria; �sul volto�, scrive Niceta, �gli splendeva la grazia e il fascino degli
occhi ridenti; di statura era alto ma un p� curvo nel portamento, aveva la
pelle piuttosto nera, ma� - �aggiunge lo storico �- era bello cos�!
Manuele era giunto sulla soglia del palazzo sul suo
cavallo arabo dall�altera cervice, dove tutti, all�infuori dell�imperatore, erano
obbligati a entrare col cavallo alla mano; il cavallo emise un forte nitrito e
dopo aver� battuto pi� volte gli zoccoli
sul selciato, si volse intorno e docilmente attravers� la soglia: ci� fu considerato
dagli astrologi un buon auspicio per la vita dell�imperatore.
Dopo i riti di ringraziamento e l�acclamazione, Manuele fece
prelevare i due Isacco, il fratello dal monastero di Costantinopoli e lo zio
che si trovava a Eraclea (Bitinia), e con sincera lealt� nei confronti di
ambedue, li tenne a Corte insediandoli nelle loro cariche; essi per�,
nascondevano ciascuno i propri sentimenti, di ambizione da parte dello zio, di
gelosia da parte del fratello (il quale pur
essendo grande e robusto era tanto timido, tanto che il minimo strepito lo
faceva tremare!).
Il popolo di Costantinopoli, sempre vigile sui cambiamenti
che avvenivano a Corte, dopo essere venuto a conoscenza dei difetti di Isacco,
approv� la scelta fatta dall�imperatore Giovanni; Manuele licenzi� quindi i
soldati, dopo averli generosamente ricompensati e mand� due pezze d�oro in omaggio a ogni famiglia della citt�.
La chiesa di santa Sofia era da tempo priva di patriarca,
in quanto l�ultimo in carica, Leone Stypiote era
morto e occorreva procedere alla nuova nomina; Manuele fece convocare il clero,
il Senato e i principi, i cui suffragi furono indirizzati verso Michele Curcuas, detto Oxite per la sua
provenienza dal monastero di s. Oxensio nell�isola di
Oxia, ritenuto uomo virtuoso, affabile, versato nelle
lettere sacre (ma poco nelle scienze umane); dopo l�insediamento del patriarca
fu fatta la cerimonia dell�incoronazione e a fine cerimonia l�imperatore lasci�
generosamente sull�altare cento libbre d�oro ... assegnando al clero di
Costantinopoli una pensione di duecento libbre d�oro (guadagnandosi con questa
generosit� la pubblica stima!).
*) Alla morte di Masoud
(1117-1155) succedeva nel sultanato di Iconio, il figlio Kilidj
Arslan il quale aveva due fratelli e come d�uso presso i turchi, ne fece
scomparire uno, mentre l'altro, Shahinschah riusc� a fuggire
a Gangres, che il padre gli aveva donato con Ancyra, ai bordi del Mar Nero.
Egli, due anni dopo l�insediamento (1157)
si mosse verso la Siria e la regione dell�Eufrate� e poi giunse davanti ad Antiochia, ci� che
spinse Norandino a trattare con i franchi, mentre Sdefan�,
fratello di Thoros (capo degli armeni v. Nota Le
quattro Armenie) gli consegn� Pertounk;
�Kilidj si
impadron� di Behesni e Kesoun
e di alcune altre citt� che Norandino gli aveva tolto, e pi� tardi si impadron�
di Raban e Marasch.
Kilidj si era alleato con il re di Gerusalemme,
il principe di Antiochia e Thoros; fu in questo
periodo che egli riusc� a rompere anche l�unione dei principi danichmenditi (v. Nota: La dinastia danicmendita),
attirando al suo partito Dhou�l Noun.
MANUELE
PERDE LE SUE
QUALITA� INIZIALI
|
M |
anuele non conserv� per molto le buone qualit� mostrate all�inizio
del regno �compassionevole, generoso,
nemico di ogni vessazione, di facile accesso, incapace di inganni, di sospetti,
di malignit�, �insomma, un modello di
virt��.
Circondato da ministri che pur essendo competenti non
seguivano i principi dell�onest� (si trattava di Giovanni Putze,
Giovanni Agioteodorite, Teodoro Stypiote)
�divenne duro, altero, pieno di disprezzo
verso gli altri che riguardava come schiavi, avido di imposizioni e pronto a
riprendere le pensioni che aveva egli stesso elargito a quelli che lo avevano
servito�; �pur non essendo avaro, ma
saccheggiato dai suoi ufficiali, dai ministri e dalla concubina Teodora, oltre
alle spese delle guerre, era costretto a rifarsi spremendo i suoi sudditi�.
Per mantenere l�esercito l�imperatore aveva commesso un
errore imperdonabile per un comandante�
come lui: invece di provvedere alla paga dei soldati con le proprie
finanze, assegn� la paga alle citt� e province, cosa che costitu� un peso
economico gravoso per i cittadini; non solo, ma si verific� l�inconveniente che
gli ufficiali addetti alla riscossione, procedevano a tassazione indiscriminata
senza rispetto delle potenzialit� dei contribuenti, s� che per gli abitanti
delle campagne e delle citt� la tassazione era divenuta cos� eccessiva� che molti fuggivano, abbandonando mogli e
figli.
Talvolta la sussistenza di un cavaliere era distribuita
tra uno o pi� abitanti, che finivano per perdere le loro propriet� e il
cavaliere si appropriava delle parti migliori delle loro terre, oppure i
malcapitati vendevano la loro libert� divenendo schiavi; si era verificato
anche un altro inconveniente: molti artigiani ritenendo che fosse meglio
vessare, che essere vessati, si arruolavano, in modo che divenuti soldati
facevano ci� che prima i soldati avevano fatto nei loro confronti.
Purtroppo l�imperatore si accorse troppo
tardi di queste storture e poich� erano tanti coloro che nati liberi erano
stati ridotti in schiavit�, emise un decreto che rendeva liberi tutti coloro
che erano nati liberi.
Putze era uomo abile e di molto spirito che aveva esercitato la
carica di ministro delle finanze sotto Giovanni, con soddisfazione dello stesso
imperatore; ma sotto Manuele pi� avido di suo padre e meno attento alle
lamentele del popolo, Putze si propose di guadagnarsi
la sua benevolenza, aumentandone i tesori e arricchire anche s� stesso, per cui
aument� le imposizioni, rimanendo sordo e indifferente alle lamentele e alle
lacrime dei contribuenti.
Per risparmiare sulle spese della flotta, �distrusse la marina facendo colare a picco
le navi...quasi anche con i marinai�; questa operazione fu presa
dall�imperatore come l�operazione di un gran politico, ma le conseguenze furono
disastrose per l�impero in quanto i mari furono presi d�assalto dai pirati e le
spiagge erano rimaste aperte alla merc� dei saccheggiatori; a seguito dei
pettegolezzi di corte, che fecero vacillare la sua credibilit�, e avendo reso
ricchi anche i propri figli, Putze ebbe l�accortezza di
ritirarsi a vita privata, impunito per i suoi misfatti.
Giovanni Agioteodorite era
cancelliere, molto apprezzato dall�imperatore e Teodoro Stypiote,
di intelligenza viva e acuta, eseguiva i suoi disegni con costanza; saggiamente
occultava queste sue brillanti qualit� con un carattere allegro e con le grazie
di una buona educazione; piaceva all�imperatore del quale era divenuto primo
consigliere, le cui opinioni l�imperatore talvolta accoglieva, tal�altra non
condivideva; ma Agioteodorite dotato di una brillante
eloquenza riusciva sempre a convincerlo; Manuele, incantato dai suoi talenti,
lo elev� al grado del cancelliere Stypiote, ci� che
non era stato gradito da quest�ultimo.
Era sorta una questione nel Peloponneso dove era governatore
Michele Paleologo con Giovanni Balsamone, cognato di Stypiote, il quale ne approfitt� per disfarsi del suo
concorrente;� egli convinse l�imperatore
che Agioteodorite era il solo che potesse risolverla
e questo fu spedito in Peloponneso e Stypiote,
approfittando della sua assenza, non solo si fece assumere nella carica di Agioteodorite, ma si appropri� dei suoi titoli e delle sue
pensioni, riducendo Agioteodorite alla estrema
miseria. ���
Male per� incolse Stypiote
per le cattiverie commesse nell�esercitare il suo potere!
Il logoteta del
dromo, Giovanni Kamatero, non potendo soffrire la
prosperit� di Stypiote e geloso del fatto che Stypiote accompagnava l�imperatore in tutte le ore del
giorno, and� a trovarlo, come un serpente, con falsa apparenza di amicizia,
presentandogli un pesce in un vaso d�oro; subito dopo questa visita, come un
essere perfido e traditore, si rec� dall�imperatore per accusarlo di voler
imbrogliare la questione siciliana.
L�imperatore gli chiese delle prove e il logoteta fece in
modo che in un incontro organizzato, facendo nascondere l�imperatore dietro una
tenda, parlando con Stypiote, fece cadere il discorso
sulla Sicilia e gli fece biasimare la condotta che Manuele aveva avuto
nell�attaccare la Sicilia.
L�imperatore, non solo non prese nessun provvedimento nei
confronti di Stypiote, ma con una �crysobolla guarnita di pietre preziose, diede a Stypiote l�ordine di presiedere la cerimonia del giuramento
del principe ereditario ungherese Bela, incarico che rientrava nelle
attribuzioni del logoteta del dromo; Kamatero per vendicarsi, scrisse una falsa lettera con la firma
di Stypiote, indirizzata al re di Sicilia e la fece
mettere tra le carte del rivale, e a seguito di denuncia, durante la
perquisizione, fu trovata la lettera e Stypiote fu condannato
a perdere gli occhi.
Giovanni Kamatero che aveva
condotto questo intrigo, era un personaggio particolare; anche se disdegnava la
filosofia, era dotato di una facondia straordinaria che gli permetteva di
improvvisare e affrontare qualsiasi argomento; egli aveva molteplici talenti
che gli avevano consentito di raggiungere il successo; oltre a quello di
improvvisatore �aveva una eloquenza che
scaturiva dalla sua bocca a guisa di una abbondantissima fonte� (Niceta),
cantava, accompagnandosi con la lyra o con la cetra, spedito
e snello nel saltare e nel danzare, era dotato di un robusto appetito e beveva
grandi quantit� di vino senza mai ubriacarsi, e pi� beveva, pi� rimaneva lucido
nel ragionare.
Manuele si divertiva a vederlo mangiare tutto quello che
gli servivano; quando lo mandava in missione presso qualche sovrano come
ambasciatore, era ammirato come uomo forte, non meno di quanto mangiasse e bevesse!
Gli piacevano le fave e ne mangiava intere piantagioni: un
giorno, da dove era accampato, vide dall�altra parte del fiume un intero
campicello e spogliatosi, attravers� il fiume, ne mangi� una buona met�,
l�altra parte se la caric� sul dorso e la port� nel suo padiglione, dove si
sedette e, piacevolmente, continu� a mangiarle.
Aveva scommesso con l�imperatore che avrebbe potuto bere
l�acqua contenuta in un grosso bacile (di due staia) come quello di porfido che
in altri tempi si trovava nella sala di Niceforo Foca; ebbene, bevve come un
bue dopo aver respirato non pi� di una volta e ricev� il premio di
preziosissimi panni di lino con molte mine d�oro!
Tornando all�imperatore Manuele e in particolare al suoi
interessi religiosi, egli era desideroso di riunire le due Chiese e mantenne
stretta corrispondenza con il papa Alessandro III; quanto ��al suo
zelo, arrivava al punto di voler essere egli stesso teologo, pretesa�,
commenta lo storico, �che avevano molti
imperatori che si credevano dottori della Chiesa e che ritenevano avere le
chiavi delle Scritture, e guai a chi
non si sottometteva alle loro decisioni: la deposizione e l�esilio erano
l�argomento di persuasione dei malcapitati�.
Manuele si compiaceva di ragionare sui misteri e di �mettere in imbarazzo i teologi e si
comportava da despota nello Stato e nella Chiesa, e pretendeva di far valere le
interpretazioni che egli dava ai libri santi�; e lo storico prosegue: �gli imperatori si lusingavano di essere, se
� permesso dirlo, i confidenti�
dell�Essere Supremo e di penetrare nell�abisso dei suoi segreti: e
chi ne dubitava, come si verific� con l�imperatore Manuele, finiva �per essere sospeso, come capit� ad alcuni
vescovi, o privato dell�impiego, come accadde a tante altre persone che non la
pensavano come lui; �egli aveva steso un
formulario, che fece sottoscrivere in un concilio, minacciando la scomunica o
anche la morte a chi avesse osato oppugnarlo o sottometterlo a esame�.�
I SUOI
MATRIMONI
E LA NIPOTE
�CONCUBINA
|
E |
ra giunto anche il momento del matrimonio di Manuele,
preparato dal padre: l�imperatore�
Giovanni, di fronte alle ambiziose mire di Ruggero di Sicilia aveva
pensato di rafforzarsi con delle alleanze e aveva preso contatti con
l�imperatore di Germania, Lotario (1075-1137), con il quale stipul� un
trattato, sancito� dal matrimonio del
figlio Manuele con una principessa tedesca.
Nel frattempo Lotario moriva e gli succedeva Corrado III
di Hohestaufen, duca di Franconia (1093-1152), al
quale Giovanni aveva rinnovato la richiesta del matrimonio; Corrado la
accettava di buon grado, offrendogli Berta, sorella della moglie Geltrude,
figlia di Berengario di Sultzbach (Baviera).
Nella lettera scritta a Giovanni, l�imperatore tedesco
usava un tono altezzoso con una premessa pomposa, con la quale, si rivolgeva a
Manuele non come imperatore, ma come re dei greci, oltre a innalzare l�impero
d�Occidente vantando di essere ubbidito da tutti i paesi dell�Occidente (come
Francia, Spagna, Inghilterra), dal Nord al Sud; Corrado chiedeva quindi una
chiesa esclusiva per i tedeschi e proponeva il doge di Venezia, Pietro Polano,
per regolare i termini delle convenzioni matrimoniali; Giovanni rispose con una
lettera pi� compiacente e Berta con il suo seguito, affidata a Embricone, vescovo di Wisburgo,
part� per Bisanzio (1142), gioiosamente accolta dalla imperatrice madre, Irene,
e dalle altre principesse e� dame di
corte.
Quando Manuele decise di sposare Berta (nella settimana
dopo l�Epifania del 1146 e le fu dato il nome di Irene), nel comunicarlo
all�imperatore di Germania, gli aveva dato anche la notizia del suo avvento
all�impero; nello stesso tempo Manuele chiedeva, in caso di bisogno,
cinquecento soldati e Corrado rispose che non solo gliene avrebbe mandati
due-tremila, ma che avrebbe dato anche la
sua persona per aiutare il suo caro
figlio e fratello, inviandogli ancora il vescovo Embricone
e cinque personaggi della� sua corte, per
onorare con la loro presenza il matrimonio della cognata.
Berta� era bella, virtuosa e piena di buonsenso;
non faceva uso delle polveri cinerine (fard!), del trucco intorno agli occhi, del rosso
artificiale, del busto a cui ricorrevano di norma le bizantine; aveva
mostrato interesse per la letteratura greca e il grammatico Giovanni Tzetzes (1110-1180) le aveva composto il testo �Allegorie sull�Iliade� in cui riportava
la storia dei principali personaggi, con annotazioni sulla biografia di Omero.
Manuele, pur ricevendo da Berta dolcezza, compiacenza e la
regolarit� di costumi che regnava nelle corti dell�Alemagna, e, esteriormente, ricambiava
con gli onori del fasto imperiale e con la scorta, non mostrava alcun
apprezzamento per i suoi pregi, in quanto era preso da altri piaceri, non solo
del vino e del ballo, ma da costumi licenziosi; egli infatti, oltre ad avere
rapporti (di pubblico dominio e considerati incestuosi) con sua nipote Teodora,
(probabilmente) figlia del defunto fratello Andronico, frequentava ... con foga
giovanile anche altre donne, e la corte, non solamente i giovani, seguiva il
suo esempio: �si videro i vecchi
servitori del precedente imperatore, cambiare abitudini e adottare la moda dei
nuovi costumi e rivalizzare con i giovani che seguivano il sovrano, che cerca
sempre nuove avventure galanti��
(purtroppo i cronisti non ci hanno dato notizie sulle sue donne,
all�infuori di Teodora!)
La giovane Teodora era di carattere altero e arrogante (e
anche qualcosa in pi�, perch� aveva fatto assassinare una rivale!) e aveva il
sadico piacere di eclissare con il suo splendore la pi� modesta imperatrice,
alla quale faceva concorrenza nelle spese della casa (aveva un suo palazzo con
la sua corte) e nella pompa della scorta; �sar� peggio quando avr� il figlio maschio
(Alessio, in assenza del figlio legittimo era destinato alla corona) e, in
seguito, anche altri che, scrive lo storico, �saranno insetti che divoravano una parte della sostanza dell�impero�.
Irene dar� a Manuele due figlie femmine, Maria e Anna
(morta a quattro anni quando mor� la madre), e quando Irene mor� (1160),
Manuele che l�aveva trascurata si rese conto del bene perduto e la onor� con un
tardivo rimpianto ... ma ... scacciando subito i nefasti pensieri con donne
vive e sposandosi l�anno successivo!�
Le donne francesi piacevano ai greci per la loro vivacit�
(v. in Nota Eleonora d�Aquitania) e Manuele chiese a Baldovino III di
Gerusalemme una principessa del suo parentado: Baldovino aveva due nipoti, tra
di loro cugine, una, Melisenda, era figlia del conte Raimondo di Tripoli,� e l�altra, Maria (1145-1182) era figlia di Raimondo
di Antiochia e di Costanza (Maria di otto
anni a dire dei cronisti era di una bellezza incomparabile!).
Manuele, in un primo momento aveva scelto Melisenda, figlia
di Raimondo di Tripoli; il �fratello di
Melisenda si chiamava anche Raimondo, il quale, appena venuto a conoscenza
della scelta dell�imperatore, fece grandi spese per il matrimonio della sorella
e allest� una flotta di dodici galee per accompagnarla a Costantinopoli, e con intempestiva premura, fece spese
eccessive in oro, argento e gioie di tutte le specie; tutta la nobilt� dei
dintorni (ospitata a spese del fratello), si rec� a festeggiare la promessa
sposa, ma poi giunse la notizia, da parte di Baldovino III, che l�imperatore
(dopo tante indecisioni) aveva cambiato idea e sposava Maria d�Antiochia (dicembre
1161); Raimondo se ne sent� offeso e per vendicarsi mand� la flottiglia
preparata per i matrimonio a saccheggiare l�Arcipelago e le coste del Bosforo.�
MANUELE
TERRORIZZA I
TURCHI
PERDITA DI EDESSA
|
I |
l sultano di Iconio saccheggiava i territori cristiani e
Manuele gli and� contro con il suo esercito infliggendogli sonore sconfitte; in
battaglia Manuele era scaltro e prode per la forza delle sue braccia; aveva
vinto diverse volte il sultano di Iconio ed era divenuto il terrore dei turchi
che preferirono chiedere la pace con la quale ottenne definitivamente la
Panfilia e la Cilicia.
Manuele dirigendosi verso Antiochia, sconfigge il ribelle
che non gli aveva prestato il giuramento, �inseguendolo fino alle porte della citt�;
Raimondo, resosi conto di non potergli resistere decise di conciliarsi con
l�imperatore e si rec� a Costantinopoli; l�imperatore si rifiut� di riceverlo
se non fosse andato prima sulla tomba del padre a chiedere perdono, dopodich�
fu ammesso alla udienza e pot� prestare finalmente il giuramento di fedelt�.
La contea di Edessa invece, era stata presa di mira da Zenki (Imad ad Din Zangi,� 1086-1146) atabeg di Aleppo e Mossul; a causa delle sue dissolutezze,
il conte Jocelin II aveva lasciato la citt� nelle
mani di milizie mal pagate e si era trasferito in una citt� delle delizie, in
riva all�Eufrate, dove conduceva una vita voluttuosa; peraltro non era in buoni
rapporti con Raimondo che avrebbe potuto aiutarlo in caso di necessit�; Zenki venuto a conoscenza di questi particolari ne
approfitt� per andare ad assediare Edessa.
Messo l�assedio, un armeno che abitava in una delle torri
della citt�, per vendicarsi di Jocelin che gli aveva
rapito la figlia, di notte, aveva fatto entrare i turchi i quali si erano dati a
un orribile saccheggio; la citt� non fu presa interamente, ma i turchi avevano
preso solo due fortezze, mentre nella rimanente parte erano rimasti pochi
cristiani che fecero sapere a Jocelin che avrebbero
potuto farlo entrare in citt�; nel frattempo Zenki
era morto e il suo posto lo aveva preso il figlio Norandino �(Nur ed Din � luce della religione � 1118-1174),
valoroso come il padre, il quale si rec� a porre nuovamente l�assedio.
I cristiani non erano in grado di affrontare le nuove
forze di Norandino; non sapendo cosa fare uscirono tutti, uomini, donne,
bambini,� andando incontro agli
assedianti che ne fecero un macello; tra costoro vi era anche Jocelin che fu preso e tenuto nelle prigioni di Aleppo dove
mor� (1159); anche le truppe che erano state mandate in aiuto degli assediati erano
state fatte a pezzi da Norandino, il quale rimase il solo padrone della
contrada.
PARTE
�LA
SECONDA CROCIATA
CON LUIGI VII E CORRADO III
RAPPORTI�
CON MANUELE
|
L |
a caduta di Edessa in mani turche aveva spinto i titolari
dei tre rimanenti feudi cristiani, che temevano di perderli, a chiedere aiuto
ai principi dell�Europa; i due pi� potenti monarchi in Europa erano il re di
Francia Luigi VII (1120-1180) e l�imperatore Corrado III (1093-1152); il papa
si rivolse a Luigi, re di Francia a portare aiuto alla Palestina.
Luigi convoc� un�assemblea a Vaselay
alla quale partecip� come oratore san Bernardo, che si rese promotore di questa
crociata; il calore delle sue parole aveva toccato il fanatismo� religioso di principi, signori e cavalieri
che giurarono di andare a perire per la salvezza del santo Sepolcro; tra
l�entusiasmo generale, si volle affidare a san Bernardo il comando dell�armata,
ma egli pi� abile e pi� astuto di Pietro l�Eremita, rifiut� l�onore poco
conveniente al suo stato.
Contrario a questa crociata si mostr� il pi� saggio e celebre
Sugero, abate di Saint Denis, che suggeriva al re di
non sacrificare la sicurezza del regno, alla gloria di una spedizione lontana e
pericolosa; ma Luigi volendo coprirsi della gloria di Goffredo di Buglione,
presa la croce, raccolse un grosso esercito di ottantamila uomini (con suo
fratello conte di Boulogne, con i conti di Fiandra, Champagne, Nevers, Soissons, Arcimbaldo di Borbone,
Goffredo di Guascogna e Angoumois uno dei pi� grandi
baroni del suo tempo); dopo aver lasciato il governo del regno al conte di
Vermandois e a Sugero, part� portando con s� la
moglie, Eleonora d�Aquitania (*) con tutto il suo seguito di dame, che non
vollero privarsi delle loro damigelle, servit� e bagagli, che resero esagerato
il numero dei carri che seguiva l�esercito, e ritardava il cammino dei soldati
che se ne lamentavano!
San Bernardo aveva raccomandato ai crociati di non
perseguitare gli ebrei che �sono i
testimoni delle verit� del Vangelo... sono i depositari delle profezie; con
il riconoscimento finale: - Sono i ciechi
che portano davanti a noi la fiamma della fede� !
Luigi si rivolse a Manuele per ottenere il passaggio;
Manuele, accusato di perfidia nei confronti dei crociati, era ben consapevole dei
disastri che avevano fatto quelli che li avevano preceduti; egli �era pi� preoccupato dei crociati, che delle
armi dei turchi; e pensando ai danni che essi gli avrebbero procurato, pur
avendo espresso a Luigi tutti i suoi sentimenti di amicizia, inform�
segretamente il sultano d�Iconio che in Occidente si stava preparando un
formidabile esercito per marciare contro di lui.
Lo stesso ardore religioso della Francia corse in Alemagna,
dove Corrado prese la croce, allestendo un esercito di settantamila cavalieri e
numerosa fanteria; la politica, �
stato detto, lascia poca forza al legame
di sangue: la partenza di Corrado (come abbiamo visto, cognato di Manuele) aveva
suscitato serie apprensioni da parte di Manuele, per l�arrivo dei tedeschi.
Costoro, fino a Filippopoli marciarono senza creare
disordini; vescovo di questa citt� era un italiano di nome Michele, il quale
seppe guadagnarsi la simpatia di Corrado offrendogli ospitalit�; Corrado� aveva ricambiato, considerandosi protettore
della citt� e punendo quei soldati che commettevano qualche violenza.
Ma partiti da questa citt�, i tedeschi ruppero ogni freno
e ubriacandosi si dettero al saccheggio; i greci che li trovavano a terra
ubriachi, li facevano passare dall�ubriachezza alla morte; un parente di
Corrado, rimasto a Adrianopoli, fu assassinato e l�imperatore, volendolo
vendicare invi� il nipote Federico (il futuro Barbarossa) in questa citt�, dove
Federico ridusse in cenere il monastero e pass� a fil di spada tutti i greci
che incontrava.
Pi� i tedeschi si avvicinavano a Costantinopoli, pi�
aumentavano le preoccupazioni di Manuele ... la fortuna per� gli and� incontro;
l�imperatore aveva suggerito a Corrado di prendere la strada del Chersoneso, ma Corrado non accett� il consiglio e prese
imprudentemente un passaggio tra due fiumi, le cui acque erano basse, ponendo l�accampamento
nella piana di Choirobackoi, piena di foraggi; all�improvviso
esplose un violento temporale,�
ingrossando i due fiumi, che impetuosamente esondarono portando via
uomini, tende, cavalli, bagagli e infliggendo all�esercito perdite maggiori di
una grande battaglia (1147); quello che rimase dell�armata (novantacinquemila
uomini) and� ad accamparsi nei pressi della Porta Dorata di Costantinopoli.
Nessuno dei due monarchi, orgogliosamente, voleva fare il primo
passo (uno di uscire dal suo palazzo, l�altro dall�accampamento, in quanto come
abbiamo visto l�imperatore d�Oriente si sentiva superiore a quello d�Oriente e ciascuno
si sentiva successore degli imperatori romani!), finirono �per inviarsi ambasciatori; dopodich�, Corrado,
senza attendere l�arrivo del re Luigi, attravers� il Bosforo e pass� in Asia.
Stava arrivando anche Luigi al quale Manuele aveva mandato
ambasciatori che, secondo gli usi bizantini facevano lunghi discorsi pieni di elogi
e adulazioni, cosa che ai francesi non piaceva e mentre uno di essi aveva
incominciato a recitare la litania degli elogi, intervenne il vescovo di Langres, il quale tagli� corto, dicendo che ciascuno dei
loro due signori conosceva le qualit� dell�altro e dire in due parole quello
che avevano da riferire!
I capi delle trib� amiche dell�impero, avvertiti, erano
stati aizzati contro i francesi, e comani e peceneghi ne uccisero un gran
numero; alle lamentele di Luigi, l�imperatore rispose che li avrebbe vendicati,
ma non mosse un dito; accampatosi in prossimit� della capitale, il giovane
Luigi venne a sapere che Manuele aveva firmato una tregua di dodici anni con i
turchi, cosa inconcepibile per i latini che consideravano i greci eretici e ritenevano
di compiere un�opera pia uccidere i turchi; a loro volta i greci consideravano
i latini idolatri e purificavano i luoghi o gli altari dove i preti cristiani
avevano recitato le preghiere o avevano officiato una messa!
Luigi comunque, con Eleonora, furono ricevuti a corte con
grandi onori e cordialit� tributati dall�imperatore e dalla imperatrice pari
alla ipocrisia prodigata, ricambiata con sincerit� da parte del monarca
francese; vi furono feste, giochi e magnifici festini e poich� ricorreva la
festa di san Dionisio patrono di Francia, l�astuto Manuele fece sfoggio di
tutto il lusso della Corte nella chiesa di santa Sofia, mettendo in mostra
tutte le ricchezze dell�Oriente e tutta la pompa del clero.
Luigi contento dell�accoglienza, prima della partenza
dovette intervenire nella querelle sollevata
dal conte d�Auvergne e marchese di Monferrato, che
rifiutarono di prestare il giuramento di fedelt� all�imperatore, e alle minacce
di Manuele presero le armi e saccheggiarono i dintorni della capitale; dovette
intervenire Luigi che forz� i suoi vassalli a prestare il giuramento.
Manuele, perfidamente, aveva dato a Corrado delle guide
infedeli che lo portarono nella zona montuosa della Cappadocia dove ai tedeschi
venivano tese delle imboscate e venivano sgozzati; inoltre gli era data farina
mista a calcina e dappertutto erano rifiutati i viveri ed erano loro chiuse le porte
delle citt�; erano state finanche coniate delle monete false in modo che quando
i francesi vendevano propri oggetti, erano pagati con queste monete, che poi
nei successivi acquisti erano rifiutate!
Alla fine, in prossimit� del Tauro (alle porte della
Cilicia), le guide li abbandonarono ed essi si trovarono circondati da una
folla di musulmani che gli impedivano il passaggio e li attaccavano; in questo
modo Corrado rimase con circa diecimila uomini, ma facendosi strada con la
spada, riusc� a congiungersi con Luigi a Nicea.
Vergognandosi di trovarsi senza truppe al seguito del re
di Francia, Corrado si trovava a Efeso quando �ricevette la visita dell�imperatore e
imperatrice Irene che, rompendo il ghiaccio, lo ricoprirono di doni e lo
convinsero a lasciare momentaneamente la spedizione e andare a Costantinopoli;
Corrado fu portato via mare a Costantinopoli e poich� non stava bene fu curato
dallo stesso imperatore che, come era d�uso, durante i suoi studi aveva studiato
medicina.
Appena ristabilito furono organizzate feste in suo favore
e poich� Corrado aveva perso un gran numero di cavalli l�imperatore gliene don�
duemila equipaggiati; probabilmente in questa occasione il fratello di Corrado,
Enrico d�Austria si fidanz� con la principessa Teodora, figlia del fratello di
Manuele, Andronico.
Luigi �con delle
guide sicure si rec� a Laodicea dove contava di
trovare, sussistenza ma la guarnigione greca prelevati tutti i viveri and� a
riunirsi con i turchi; Luigi aveva davanti a s� quindici giorni di cammino, nessuno
voleva fare da guida ai francesi, che entrati nelle montagne della Pisidia furono attaccati dai turchi che ne fecero una
carneficina, massacrandone ottomila; Luigi e i suoi cavalieri fecero prodigi
per rimanere in vita e raggiunsero Satalia (detta anche
Athalia) da dove, lasciandovi tutti i malati, si
imbarc� per Antiochia, mentre i greci per non dar da mangiare ai malati, avvertirono
i turchi che li andarono a massacrare.
LUIGI E
ELEONORA
OSPITI AD ANTIOCHIA
|
Q |
uando Raimondo venne a sapere dell�arrivo (1147)� del re Luigi, (scrive Guglielmo di Tiro) gli
and� incontro con tutti i nobili della contrada e con una scorta d��lite e lo
accompagn� ad Antiochia testimoniando tutto il rispetto e con la pi� grande� magnificenza, in mezzo al clero e al popolo
accorso ad accoglierlo.
Accompagnava il re la moglie Eleonora (*) nipote di Raimondo,
(era figlia del fratello Guglielmo �pi�
vecchio di lei otto anni);
Il re ricambi� ai nobili e principi che componevano la
scorta ricevettero la testimonianza delle sue liberalit�. Eleonora, scrive G.
di Tiro, �era una persona fortemente
sconsiderata come dimostrava la sua condotta anteriore �e provarono ancora di pi� il seguito degli
avvenimenti: disconoscendo la dignit� reale e le leggi del matrimonio� !
Anche se tra zio e nipote vi era una differenza di et� di
otto anni, da fanciulli erano stati compagni di giochi e tra i due, complici il
fascino del luogo e la bellezza dei giardini in cui passeggiavano e Raimondo aveva una voce dolce e affabile e
il suo corpo aveva una grazia singolare e il contegno di un principe; mentre
i due si scambiavano i ricordi d�infanzia e parlavano la stessa lingua d�oc, sconosciuta a Luigi.
Non c�� da meravigliarsi se i due fossero stati presi
l�uno dall�altra, e che quelli che erano stati i giochi infantili di un tempo,
possano aver preso la piega di giochi amorosi; insomma i due, durante il
periodo di permanenza ad Antiochia, divennero amanti (alcuni storici negano
questo rapporto ma da parte di altri non si fa che parlarne, calcando la mano
sulla circostanza che il rapporto fosse considerato incestuoso!).
Non si spiega diversamente il comportamento di Luigi �che se ne ripart� segretamente, accompagnato
dai suoi; la sua uscita non somigliava�
in alcun modo al suo arrivo quando fu accolto con tutti gli onori, si
ritir� senza gloria�.
Oramai, �con tutte le
vicissitudini subite, i crociati erano demotivati; Luigi dopo combattimenti
avuti presso Antiochia e Gerusalemme, and� a porre l�assedio a Damasco ma il
tradimento dei greci fece abortire questa impresa.
Nel frattempo lo raggiunse Corrado che rammaricato e
scoraggiato lasci� i pochi soldati che gli erano rimasti e se ne �torn� in Alemagna senza soldati, senza danaro
e senza gloria.
Luigi, coraggiosamente, rimase ancora due anni in
Palestina ma la sua lotta fu vana sia contro i nemici turchi, sia contro la
cattiva fede dei suoi alleati; egli si imbarc� per la Francia ma la navigazione
fu perigliosa (1149): sulla sua rotta incontr� la flotta di Ruggero II in
guerra con i greci; egli pass� su una nave siciliana, ma correndo il rischio che
la nave fosse presa, fece issare il vessillo francese e fu fatto prigioniero
dai greci (come scrive Guglielmo di Tiro) e tenuto per diverso tempo a
Costantinopoli dall�imperatore; egli comunque perse tutte le sue navi, con le
persone del suo seguito; secondo un�altra versione Luigi sarebbe stato fatto prigioniero
e liberato dall�ammiraglio che comandava la flotta siciliana Giorgio Sindulino.
Ebbe fine in questo modo tragico, con la morte di migliaia
di esseri umani (a qualsiasi parte appartenessero), senza altro scopo che
quello di incrementare l�odio tra l�Occidente e l�Oriente (tra latini, ortodossi
e musulmani) ... e siamo solo agli inizi, delle nove crociate che dureranno
ancora per circa un secolo!
San Bernardo che aveva dato impulso alla crociata,
assicurando �che la vittoria era stata
predisposta dalla volont� di Dio�, dovette giustificarsi, riversando la
colpa sui crociati peccatori che �l�Onnipotente
aveva voluto punire i crociati per i loro peccati�!
�
ELEONORA D�AQUITANIA
|
E |
leonora (1122-1204), alla grazia della
persona, aggiungeva doti seducenti e attrattive che per gli uomini erano come
il miele per le api; a queste univa uno spirito libero, carattere, e forte
personalit�; aveva sposato Luigi VII (nel 1137 quando aveva 15 anni) e considerava il pio e devoto Luigi �un monaco� (Eleonora certamente non aveva avuto la possibilit� di conoscere
i monaci dell�epoca, che, quanto a sesso, avevano tutt�altra fama!).
Alcuni storici la consideravano �coquette�, civettuola e vanitosa, altri,
esagerando, a torto, la consideravano una Messalina; aveva voluto partecipare
alla crociata, non per spirito di piet��
o per purgarsi dei suoi peccati, ma per conoscere quell�Oriente di cui
si raccontavano meraviglie e nella brama di conoscerlo non era stata dissuasa dal
lungo e estenuante viaggio e dai pericoli ai quali andava incontro.
Se il suo modo di prendersi delle libert�
era considerato scandaloso non vi �
dubbio che fosse per il piacere del sesso (che per le donne, come si sa, �
determinato dal raggiungimento dell�orgasmo che all�epoca - come ancora oggi! -
per molte fosse una vera scoperta!), e fosse aperta a nuove esperienze; per
questo riteniamo vero il rapporto con il giovane turco avuto ad Antiochia che
raccontiamo pi� avanti; tra l�altro, le era stato attribuito anche un rapporto
con Saladino, impossibile, in quanto in quell�anno (1148) egli aveva appena undici
anni!
Quando Eleonora era stata ricevuta alla
Corte imperiale a Costantinopoli, tra le bizantine, non aveva trovato nessuna
rivale; anche tutte le spumeggianti dame e damigelle francesi che l�avevano
accompagnata, ignare della etichetta di corte (che in Francia arriver� con
Luigi XIV), rispetto alle bizantine impaludate nel loro rigido formalismo, si
comportavano con vivace spontaneit� e avevano suscitato negli uomini grande
ammirazione.
Erano molte le dame che l�accompagnavano,
alcune seguivano i loro mariti, altre i loro amanti; tra di esse vi era il
fiore della nobilt�, la contessa di Blois,�
Sibilla d�Angi� contessa di Fiandra, Maurilla contessa di Roussy, Faydide di Tolosa,
Florina di Borgogna, Talquery duchessa di Buglione, tutte
con le rispettive damigelle e servit�, in quanto nessuna intendeva rinunciare alle
proprie comodit� e abitudini.
Non mancavano i menestrelli per allietare
le ore di riposo! Con un tal gran numero di donne, gli uomini cercavano di
affogare le fatiche nei piaceri, e ci� che poteva essere semplice divertimento,
divenne presto �debauche�
e libertinaggio; tra l�altro san Bernardo�
aveva chiamato a raccolta malfattori, uomini corrotti e i pi� grandi
peccatori, ai quali aveva promesso la salvezza eterna: tutti costoro non fecero
altro che nuocere ai costumi dell�esercito cristiano!
Tutti i bagagli avevano fatto aumentare
notevolmente il numero dei carri che seguivano l�esercito che, cos� numeroso,
non aveva potuto seguire la via del mare, come aveva proposto Ruggero II di
Sicilia che avrebbe messo a disposizione le sue navi, ma quello terrestre
dell�Ungheria; la sera negli accampamenti vi erano intorno alle tende delle
dame degli andirivieni furtivi, sorrisi sospetti ... con lo sgattaiolare nel
buio ... con quello che poteva seguire!
Nell�esercito di Corrado giunto poco
prima vi era un contingente di donne, su cui Niceta, inorridito, scrive: �cavalcavano come maschi e in sella non
tenevano le gambe unite, ma stavano spudoratamente a cavalcioni; armate di aste
e spade, avevano l�aspetto di uomini e indossavano vesti da uomo, avevano uno
sguardo marziale ed erano pi� maschie della amazzoni�; tra di esse vi era
quella che le comandava, soprannominata Piede
d�oro, dall�oro che screziava la sua veste correndo lungo i bordi e le
frange.
Quando Eleonora si aggirava per� Antiochia, i saraceni attiravano i suoi
sguardi voluttuosi e l�esperienza con un giovane turco doveva averle fatto
girare tanto la testa (si diceva!), da ricoprirlo di doni, non solo, ma per lui
pare volesse abbandonare il marito (Michaud).�
Non vi � dubbio comunque che il
comportamento di Eleonora fosse stato ritenuto dal re Luigi, scandaloso, da
indurlo, quando rientrarono in Francia, a chiedere il divorzio, giustificato,
per non creare altro scandalo, �dalla
circostanza che il matrimonio era da considerare nullo per grado di parentela.� ��
Ottenuto il divorzio Eleonora non si perse
d�animo; se ne and�� a Poitiers, capitale
della sua Aquitania e scrisse un biglietto a Enrico, per incontrarlo.
Enrico era l�ultimo dei Plantageneti
(1133-1189), erede al trono d'Inghilterra, potente quando diventer� Enrico II, in
quanto, oltre a essere re d�Inghilterra, era feudatario di mezza Francia, aveva
pi� feudi dello stesso re francese; aveva infatti il ducato di Normandia, le
contee d'Angi�, di Touraine e del Maine, e con il
matrimonio con Eleonora avr� in dote il ducato d'Aquitania e il Poitou (e sar� la causa funesta di trecento anni di guerre
con l�Inghilterra e dei mali che si abbatteranno sulla Francia, ne sar� data la
colpa a Eleonora!).
Con il matrimonio Eleonora dar� a Enrico
II (1152 Eleonora aveva trent�anni) una caterva di figli (Guglielmo, Enrico,
Matilde, Riccardo Cuor di Leone, Goffredo, Leonora, Giovanna, Giovanni Senza
Terra); fuori dal matrimonio Enrico� (tombeur de femme ... non tralasciava altre donne!),
ebbe due figli illegittimi Goffredo e Guglielmo Lungaspada.
I figli legittimi avevano preso il
carattere ribelle della madre e si ribellavano al padre, il quale fin� per fare
�imprigionare Eleonora (per quattordici
anni!), �in quanto riteneva che fosse lei
a sobillarli; Eleonora sopravvisse al marito e mor� a ottantadue anni, et�
straordinaria per quei tempi quando le donne normalmente morivano di parto, di
setticemia.
����
RINALDO DI
CHATILLON
DA CAVALIERE
DI VENTURA A
PRINCIPE DI ANTIOCHIA
|
R |
aimondo di Antiochia era nel frattempo deceduto (1149), �ucciso da uno squadrone di Nour
ed-Din, al quale fu mandata la sua testa e la mano
destra, mentre il cadavere cos� mutilato fu portato ad Antiochia; egli lasciava
un figlio maschio, Boemondo (che sar� il futuro Boemondo III) e due bambine,
Maria� (che sposer� l�imperatore Manuele)
e Filippa (che dopo essere stata concubina di Andronico Comneno, sposer� il
principe Homfroi de Toron, connestabile del regno di
Gerusalemme,).
�Il principato era
ora, nelle mani della vedova Costanza; costei ancora giovane (ventiduenne), non
solo aveva rifiutato il cesare Ruggero, cognato dell�imperatore, perch� troppo
vecchio, ma anche altro pretendenti della famiglia imperiale, come il cesare �Andronico-Giovanni Comneno, e altri personaggi
di alto rango proposti dal re Baldovino.
Quando si present� ad Antiochia Rinaldo
di Chatillon (1125-1187) le cose cambiarono aspetto!
Rinaldo, era un personaggio romanzesco, giunto in
Palestina al seguito di Luigi VII come mercenario, e quando Luigi se ne torner�
in Francia, Rinaldo si metteva alle dipendenze di re Baldovino III: Rinaldo quando
era giunto in Terrasanta aveva diciannove anni (a quei tempi si maturava molto
presto, mentre ora i tempi si sono allngati ... oltre
il pensabile ... in quanto i giovani italiani rimangono in famiglia fino alla
maturit�...dai� trent�anni in su ...e
cos� qualificati bamboccionii!).
Rinaldo proveniva dal castello di famiglia di Chatillon,
era figlio cadetto e cavaliere di ventura sconosciuto, ritenuto brutale,
arrogante, cinico e sprezzante; per gli arabi Arnat,
sarebbe divenuto simbolo della malvagit� dei franchi, e Saladino (*) aveva
giurato di ucciderlo con le proprie mani.
Giovane e prestante, si era recato ad Antiochia (1153) per
mettersi al servizio di Raimondo, non sapendo della sua morte, ma aveva trovato
la giovane vedova che gli raccontava della morte del marito, avvenuta quattro
anni prima (G. Schlumberger gli aveva dedicato un libro, citando tra le fonti
Guglielmo di Tiro e� scrivendo,
relativamente a questo incontro, che �non
conosciamo i dettagli�!): ma conoscendo il personaggio, egli dovette sedurla
(come � stato anche detto da qualche autore) al primo incontro.
Erano ambedue giovani (lei ventiduenne e lui aveva un anno
di meno),� Costanza, dal suo canto se n�era
invaghita dal momento in cui aveva messo la sua mano delicata in quella del rude
cavaliere ... �accettandolo di buon grado
(come scriver� Dante per Paolo e Francesca... le prese di costui amor s� forte ...); �non si spiega diversamente la circostanza, che dovettero mantenere segreto il fidanzamento, perch� Costanza, pur essendo cugina di primo
grado di Baldovino III, come vassalla il diritto feudale prevedeva il consenso
del suo re e i due senza il suo consenso non potevano sposarsi.
Rinaldo per poterlo ottenere, precipit� da Baldovino,
e� buttandosi umilmente ai suoi piedi
(era bravo in queste scene!), gli chiese di non negargli questo grande onore e ottenne
il consenso; tornato a Antiochia Rinaldo mostr� a Costanza la lettera del re
che autorizzava il matrimonio e la cerimonia fu officiata dal patriarca; Rinaldo
diveniva quindi principe di Antiochia e dovette subito� partire per prestare aiuto a� Baldovino, cha aveva stretta d�assedio Ascalona (1153), dove Rinaldo si conquist� il titolo di eroe, sposo della principessa Costanza.
Costanza, sposandosi, non aveva neanche chiesto il
consenso all�imperatore che ne era rimasto indispettito; dal sua canto Rinaldo
cercava di stare nelle sue buone grazie, e si era subito recato da Manuele per
il consenso.
L�imperatore ne approfitt� (ricorrendo al sistema usato da
tutti gli imperatori, di mettere i nemici dell�impero l�un contro l�altro), chiedendogli
di sottomettere alla sua obbedienza Thoros, di cui Rinaldo
era amico; egli chiese a Thoros la restituzione di
alcune piazze che i latini avevano tolto ai greci, dei quali se ne erano
impossessati gli armeni; tra queste vi era la piazza di Gastin,
importante in quanto� dominava la strada
tra la Cilicia e Antiochia, che Rinaldo richiedeva per i Templari; sul rifiuto
di Thoros scoppi� la guerra tra i due, vinta da Thoros che spontaneamente consegn� Gastin
ai Templari, con i quali firm� un trattato d�alleanza.
Rinaldo esercitava il potere con la moglie Costanza, dalla
quale era amato; non lo era invece da parte dei principi cristiani, per il suo
carattere, seppur ossequioso, estremamente violento; era un terribile uomo di guerra, nemico sleale dei propri
correligionari, predone delle grandi strade di comunicazione, avido e brutale e
sopratutto era un uomo per il quale i trattati e la parola data non contavano
niente; questa duplicit�' un giorno gli coster� la vita.
L�imperatore aveva promesso a Rinaldo importanti sussidi
che, nonostante le ripetute richieste, non gli aveva mandato, e Rinaldo per
vendicarsi and� a saccheggiare l�isola di Cipro (1155).
RINALDO
SACCHEGGIA
�CIPRO� E
CHIEDE PERDONO
ALL�IMPERATORE
|
L |
�isola era ricca in quanto serviva da scalo per tutte le
navi che si recavano o tornavano dall�Oriente,�
frequentata dai mercanti veneziani, genovesi e pisani; era governata da
Giovanni Comneno, nipote di Manuele, il quale era stato avvertito da latini di
Antiochia (le notizie arrivavano velocemente!), delle intenzioni di Rinaldo.
Agli ordini di Comneno vi era Michele Branas,
e si prepararono a riceverlo, ma le forze bizantine stanziate a Cipro non erano
sufficienti ad affrontare quelle di Rinaldo e al primo scontro furono battute e
ripiegarono su Leucosia (Nicosia), dove furono inseguite e sconfitte;
dopodich�� i soldati latini si sparsero
per l�isola saccheggiando ville, villaggi, chiese, monasteri senza risparmiare
niente e nessuno, come se quel saccheggio fosse stato fatto in territorio
musulmano.
Gli abitanti furono massacrati, i monaci greci mutilati
con il taglio del naso; il bottino fu colossale, in argento, oro, stoffe
preziose e bestiame; nello stesso tempo Rinaldo impose un enorme contributo di
guerra e a garanzia del pagamento prese come ostaggi ecclesiastici e importanti
abitanti dell�isola, portandoli ad Antiochia; per di pi�, non potendo
trasportare con le navi tutti gli animali, si fece pagare il loro riscatto.
Questo saccheggio ebbe vasta eco presso i latini,
preoccupando il re di Gerusalemme, Baldovino III (1130-1162) sul quale pesava
la difesa dei territori conquistanti, sia di fronte a Nour
ed-Din padrone di Damasco, sia per gli attacchi dei
musulmani d�Egitto;� Baldovino riteneva
che la salvezza dei latini poggiasse sull�alleanza con i greci, per questo si
decise a chiedere all�imperatore in moglie una principessa bizantina e
l�imperatore gli concesse la mano della nipote Teodora (figlia del sebastocrator Isacco) di tredici anni
assegnandole una dote ... principesca ...
di centomila hyperperi e altri diecimila, per le
spese del matrimonio, oltre al valore di trentamila hyperperi
in pietre preziose, perle, vestiti, tappeti, stoffe di seta e vasi preziosi; per
di pi� a titolo di dote, le fu assegnata la citt� di Acri e il territorio
circostante che Teodora avrebbe potuto governare, come dotaria,
alla morte del marito: e cos� la piccola principessa stava per diventare regina;
piena di tali ricchezze e accompagnata da�
lungo seguito si imbarc� (1158) per Gerusalemme, dove furono benedette
le nozze reali.
Ad Antiochia, dopo il saccheggio di Cipro si era formato
un partito contro Rinaldo con alla testa il patriarca Amaury; costui proveniva
dalla Francia (era stato eletto patriarca nel 1142); era ricco, potente, con
molto seguito, ma (secondo Guglielmo di Tiro) illetterato, di carattere poco religioso, dalla vita licenziosa, il
quale non aveva molto apprezzato la fortuna capitata a Rinaldo, e si era
mostrato contrario al suo matrimonio con la principessa.
Amaury inoltre, si esprimeva liberamente sui compiti del
principe e gli faceva la pi� viva opposizione;�
questi particolari furono riferiti a Rinaldo, il quale ne fu talmente
corrucciato che lo fece portare sulla torre della cittadella e dopo essere
stato denudato, fu fustigato� e gli
fu� spalmata la sua testa calva con miele
e fu lasciato sotto il sole cocente dell�estate, esposto alle mosche e agli
insetti.
Quando Baldovino lo venne a sapere, invi� a Rinaldo legati,
con una lettera di biasimo, ordinandogli di liberare immediatamente il vecchio
prelato, il quale, liberato, se ne part� per Gerusalemme.�
L�imperatore dal suo canto era fuori di s� sia per il
saccheggio di Cipro da parte di Rinaldo che considerava un miserabile vassallo
sia nei confronti di Thoros che aveva conquistato dei
territori in Cilicia; egli allest� l�esercito (1158/59) e si diresse con una
guarnigione verso Seleucia mentre il grosso
dell�esercito era ad Attalia con l�intento di
sorprendere alle spalle Thoros che si trovava a
Tarso; Thoros per i pochi mezzi di cui disponeva,
avutane notizia, raccolse le sue ricchezze, i cavalli, la moglie e i figli,
seguito dai grandi della sua signoria,�
se ne fugg� verso le gole dei monti.
L�imperatore si trovava a Massissa
(Messis la Mamistra dei
crociati) dove Rinaldo si rec� per farsi perdonare, facendo ricorso alla scena
umiliante� dell�abito da penitente, a
piedi nudi, con la corda al collo, preceduto dai personaggi della sua signoria
e da una lunga fila di monaci piangenti e gementi tutti a piedi nudi; vi
assistevano tutti gli abitanti della citt� e l�armata greca, divertita dalla
scena.
L�imperatore era su un trono sontuoso circondato di
cuscini e tappeti di seta, posti davanti al padiglione e dalla sua guardia del
corpo;� Rinaldo dopo aver deposto la sua
spada ai piedi di Manuele, rimase in attesa che gli venisse concessa la parole;
l�imperatore lo fece attendere lungamente, alla fine gli concesse la parola:
Rinaldo grid� ripetutamente grazie, accompagnato dal pianto dei monaci che
alzavano le mani al cielo; la scena poco dignitosa aveva sdegnato e disgustato
i superbi francesi presenti; a questo modo Rinaldo ottenne il perdono imperiale
... ma appena rientrato ad Antiochia, riprese a saccheggiare i territori
cristiani e musulmani, nonostante tra Saladino e il re di Gerusalemme fosse
stato firmata una tregua; inutili furono le lamentele di Saladino presso il re
di Gerusalemme.
Ma giunse il momento in cui la fortuna che lo aveva
accompagnato fino a quel momento, lo abbandonava: durante una razzia nei pressi
di Edessa nelle mani dei turchi, governata dall�atabek Medj ed-Din
fratello di Nour ed-Din
(1160), dove aveva fatto un grosso bottino di animali, Rinaldo fu inseguito mentre
gli animali lo impacciavano nel cammino, fu raggiunto e dopo un duro
combattimento fu fatto prigioniero con i suoi soldati; con le mani legate
dietro la schiena fu portato nelle prigioni di Aleppo, dove rimase per
sedici� anni.
Un suo� vecchio
compagno si ricord� di lui e si offr� di pagare il riscatto, versando una somma
enorme (centomila pezzi d�oro); �Rinaldo
fu cos� liberato (1176) e recatosi ad Antiochia trov� che Costanza era morta e
regnava Boemondo III, figlio di Raimondo nel frattempo divenuto maggiorenne,
liberatosi dalla prigione in cui era stato tenuto da Rinaldo.
Rinaldo si rec� a Gerusalemme dove fu ben accolto dal re
Baldovino IV (il Lebbroso) e dai baroni che avevano dimenticato il male che
aveva fatto ai cristiani, ricordando invece tutti i suoi patimenti per la causa
cristiana!
Gli fu data la signoria della fortezza di Karak (o Crac dei Templari, finita nelle mani di costoro
dopo la morte di Rinaldo), che si elevava su una cima montagnosa che separava
la contea di Tripoli e la valle delll�Oronte, e
Montreal e spos� in seconde nozze, la vedova di Homfroy
de Thoron.
TENTATIVO DI
RUGGERO II
DI CONQUISTARE
L�IMPERO
|
R |
uggero II (1095-1154) figlio del gran conte Ruggero (1031
c.a-1101) fratello di Roberto Guiscardo,�
conquistatore della Sicilia, aveva ereditato anche lui le mire di quest�ultimo e del
figlio Boemondo (v. P. I), sull�impero bizantino; aveva iniziato chiedendo in
matrimonio all�imperatore Giovanni II, una delle sue figlie, per uno dei suoi
figli; morto Giovanni e salito al trono Manuele I, Ruggero torna alla carica
mandando ambasciatori che Manuele, conoscendone le nascoste intenzioni, fece
imprigionare: questa fu la buona occasione per Ruggero per dare inizio alla �aggressione contro �l�impero bizantino.
Ruggero con la sua flotta si dirige a Corf� dove gli abitanti,
stanchi di pagare le dure imposizioni fiscali a Bisanzio, si arrendono
spontaneamente; quindi i siciliani vanno a saccheggiare le coste del
Peloponneso, raggiungono Tebe di Beozia (dove avevano prelevato tutti i
lavoratori della seta) e saccheggiano Corinto; erano tante le ricchezze che
avevano preso, che le navi per il peso affondavano per met� nel mare.
Manuele a sua volta, raccolto l�esercito, attravers� la
Tracia, sconfisse dei peceneghi che aveva trovato lungo il suo� percorso, entr� in Illiria e and� ad
assediare Corf� (1148), con l�aiuto dei veneziani che avevano mandato una
flotta per soccorrerlo.
Prima dell�attacco Manuele aveva proposto agli abitanti
una onorevole capitolazione, ma essi non accettarono in quanto il giogo sotto
l�impero greco era pesante e risposero con una scarica di pietre e di frecce e
gli assedianti da terra e dalle navi fecero altrettanto; i colpi che arrivavano
da parte degli assediati, dall�alto, avevano maggior vigore di quelli che
venivano lanciati dagli assedianti dal basso, ma erano ugualmente colpiti gli
uni e gli altri, quasi con ugual effetto.
Attaccare l�isola era una impresa difficile in quanto la
citt� era posta sulla cima di un promontorio molto elevato, circondata da uno
spesso muro, fiancheggiato da torri; il piede del promontorio era bagnato da un
mare profondo e sparso di scogli scoscesi; mentre le navi la circondavano dal
mare vi erano le truppe di terra che la circondavano dalla piazza sottostante,
con gli scogli che formavano un argine inaccessibile.
Dalla parte del lido sorgeva uno scoglio molto alto che
terminava con un muro; Manuele fece collocare sotto alcune navi, legate tra di
loro e ben assicurate alle ancore, e vi fece costruire una solida torre fatta
con grossi tavoloni e alberi maestri, incassati gli uni negli altri, con la
base piuttosto larga da poter appoggiare una scala altrettanto larga, che
giungeva fino alla sommit� dei merli del muro.
L�imperatore chiam� i soldati pi� intrepidi i quali
guardando quell�altezza si tirarono indietro dallo spavento, ma quattro
fratelli di origine provenzale, Petraliphes, si
offrirono di salire; il loro esempio fu seguito da Givanni
Axuch, detto Pupace (del
seguito dell�imperatore, v. sopra); altri si presentarono, l�imperatore ne
scelse quattrocento ai quali promise ricchi premi anche per le mogli e i figli.
Pupace fu il primo a salire, seguirono i quattro fratelli e poi
tutti gli altri; i dardi e le pietre non li spaventavano e la citt� sarebbe
stata presa se non fosse intervenuto un banalissimo incidente; Pupare era gi�
giunto sul muro, quando la scala sotto il peso di quelli che lo seguivano
cedette e caddero tutti gli uni sugli altri, finendo o sulla piattaforma o
sugli scogli o sulle navi o nel mare.
Dall�alto arrivavano anche gragnuole di pietre e furono pochi
a salvarsi; Pupace invece entrato in citt� riusc� a
infilarsi in una porta e si salv� con meraviglia dei suoi e spavento degli
assediati; durante questo assedio, moriva, colpito da una pietra, il megaduca Stefano
Contostefano e Giovanni Comneno, �colpito
da un sasso che gli fracass� i reni e lo stese sulla sabbia; accorse il figlio Andronico
(che chiameremo il Crudele per distinguerlo da altri con lo stesso nome), al
quale Giovanni raccomand� (vilmente), di vendicare i suoi nemici che gli
avevano accorciato i giorni di vita e lo stesso Manuele che aveva usurpato il
trono che spettava a lui (in effetti al padre Isacco fratello maggiore, e poi a
lui!), e ci� sebbene Manuele lo avesse gratificato in tutti i modi e nei suoi
confronti si era mostrato sempre generoso!; Andronico, ambizioso e crudele gli
prest� il giuramento al quale, come vedremo (nella prossima puntata), si
manterr� fedele.�
Alla fine Manuele prese la citt� per fame, in quanto gli
assediati non potevano rifornirsi di cibo, n� potevano ricevere aiuti da parte
di Ruggero; per mezzo di Teodoro Capellano comandante
di Ruggero, furono condotte trattative con gli abitanti che chiedevano di
uscire dalla citt� con le loro armi e i loro effetti; Manuele fece loro sapere
che potevano rimanere, oppure potevano andar via con ci� che gli apparteneva;
molti rimasero, altri se ne andarono in Sicilia; Capellano
temendo il risentimento di Ruggero, pass� al servizio dell�imperatore.��
Giovanni Axuch aveva partecipato
onorevolmente all�assedio, ma non conoscendo l�arte marinara, non potette dare
il meglio di s�; Manuele nel tentativo di bloccare i normanni in Italia, voleva
occupare l�Italia e mand� Axuch a prendere Ancona
(1151) che fu quasi interamente distrutta e quindi Bari (1155), dove per� ogni
tentativo falliva in quanto l�esercito bizantino guidato da Giorgio Paleologo era
sconfitto a Brindisi (1156); Manuele invece dopo aver preso parte della
Dalmazia, se ne tornava a Costantinopoli dove fu ricevuto con trionfo e dove la
vittoria fu festeggiata con i tornei che i greci avevano imparato dai latini,
in cui l�imperatore era altrettanto bravo, sfidando un cavaliere italiano
vanitoso nel maneggiare la sua arma, seguito da un gruppo di romani e uno di
latini: Manuele abbatt� contemporaneamente due cavalieri, uno con il suo
destriero, l�altro con l�asta �e per la
veemenza del colpo cadde anche quello che gli era vicino. ��
.
IL TRAGICO
�DISASTRO DI
MIRIOCEFALO
|
A |
mauury di Gerusalemme (1162-1173) aveva chiesto il suo
aiuto all�imperatore in quanto, non solo i diversi capi turchi (Nour ed Din, Kara Arslan; Timourtash signore di Mardin, Yakoub Arslan e altri) attaccavano i latini da tutte le
parti, ma anche gli armeni comandati da Thoros (v. in
Nota: Le quattro Armenie), attaccavano territori
dell�impero e si erano impadronite (1151) di Tarso e Mopsueste
facendo prigioniero il duca di Cilicia, Thomas; a proposito di quest�ultima
citt�, essa era stata messa sotto assedio da Andronico Comneno (il Crudele), il
quale ebbe da Thoros una sonora sconfitta, per cui Thoros diveniva padrone non solo della montagnosa Cilicia,
ma di importanti citt� quali Tarso, Adana, Anazarbe, Sis e Mopsueste.
A tutti questi avvenimenti � da aggiungere un�altra
circostanza: all�emiro di Melitene Ain el Daulah, succede il figlio Dhou�l Qarnein sotto tutela della
madre; Yakub Arslan che intendeva ricostituire la
potenza danichmendita (*), invita suo nipote, nuovo emiro, a non riconoscere la
sovranit� di Masoud; Dhoul Qarnein segue il consiglio dello zio pensando che a questo modo �il suo territorio non sarebbe stato razziato,
ma Masoud non tard� molto a mandargli l�esercito e razziargli
i dintorni di Melitene; Dhou�l
vistosi abbandonato dallo zio (Masoud era una volpe e
avendo capito le mire di Yakub, per tenerlo buono gli
fece sposare una sua figlia!), per far cessare le ostilit�, si sottomette a Masoud, riconoscendolo come sovrano.
Tolta la spina di Yakub Arslan, Masoud ne aveva un�altra da togliere: quella di Thoros che continuava a conquistare territori, il quale,
approfittando della divisione dei principi musulmani, aveva invaso la Cappadocia,
tornando da questa campagna con numerosi prigionieri.
Al momento Masoud era alleato
con i greci e la sua spedizione in Cilicia (occupata da Thoros)
non ebbe i risultati sperati da Bisanzio; la marcia dell�esercito di Masoud per andare a occupare il Taurus,
doveva essere segreta, ma quando vi giunse il suo esercito, trov� tutti i passi
presidiati dai soldati di Thoros.
Di fronte a questa situazione Masoud
ebbe delle trattative con Thoros, suggerendogl� di riconoscerlo
come sovrano e restituire ai greci le citt� che aveva conquistato; Toros rispose che accettava il primo suggerimento, ma
rifiutava la restituzione delle citt�; l�accordo si fece in danno dei greci, in
quanto Masoud si vide riconosciuta la sua autorit� di
sultano, lasciando cadere la richiesta fatta per conto dei greci (1153).
Manuele resosi conto che a fronte di questa situazione generale
occorreva un intervento energico, chiese all�impero uno sforzo per tentare di
regolarizzarla, non escludendo per prima cosa il tentativo di far passare
Antiochia sotto la giurisdizione dell�impero; egli aveva proposto (1150), alla
vedova Costanza, il matrimonio del cognato, il cesare Giovanni, rimasto vedovo,
ma Costanza respinse la proposta perch� Giovanni era troppo vecchio e Costanza
(aveva gi� deciso diversamente, come abbiamo gi� visto!); Giovanni se ne torn�
a Costantinopoli e ammalatosi poco dopo, prese l�abito monastico.
Giunse il momento della azione e l�imperatore era tanto
sicuro che le operazioni si sarebbero svolte, come era sempre avvenuto in
passato con i turchi, che si era recato a occupare la citt� di Dorilea, in rovina in seguito alle invasioni musulmane, ma che
in precedenza si era particolarmente sviluppata sotto il governatorato greco (con
il cesare Melisseno).
Manuele fece costruire delle mura di cinta da servire come
rifugio per la popolazione e per le truppe e fece altrettanto per Sibilia o Soublaion dove fece anche qui restaurare le mura di cinta;
quindi scriveva una lettera al papa Alessandro III (gennaio 1176) con la quale
gli partecipava i successi della sua spedizione che avrebbero permesso ai
pellegrini di raggiungere Gerusalemme percorrendo una strada sicura; egli
inoltre partecipava al papa le sue intenzioni di continuare la lotta contro i
turchi per liberare il santo Sepolcro e gli chiedeva quindi di invitare i
sovrani occidentali per combattere i musulmani.
Dopo aver svernato a Costantinopoli, l�imperatore si rec�
in Tracia per preparare l�esercito e munirsi degli approvigionamenti, caricati
su non meno di tremila carri; alle truppe regolari si aggiunsero nuove leve di
latini, peceneghi, serbi e ungheresi che furono concentrati all�inizio della
primavera (1176) nei pressi di Lopadion, con l�accampamento
montato sui bordi del Ryndakos.
Manuele aveva preso egli stesso il comando dell�armata
destinata a combattere Kilidj Arslan; nell�esercito
vi era il fiore dell�aristocrazia bizantina e latina; i due figli di Costantino
Angelo, Giovanni e Andronico (a capo dell�avanguardia), seguiti da Costantino
Macroduca e Andronico Laparda; l�ala destra era sotto
il comando del� re� Baldovino, cognato dell�imperatore; l�ala
sinistra era sotto il comando di Teodoro Maurozone;
seguivano tutti i carri, e quindi l�imperatore con il grosso della truppa con
la �retroguardia comandata da Andronico
Contostefano .
Le intenzioni dell�imperatore erano quelle di andare a
conquistare Iconio; pensando di sorprendere il nemico, egli non segu� la strada
ordinaria per Dorileo, ma discese per Akhiraos fino a Laodicea, da dove
per Kelaina e Lamp�
raggiunse l�alta valle del Meandro; da qui si rec� a Soublaion
(Homa) che dominava la strada per Iconio; raggiunta Soublaion le truppe si diressero a est nella regione di Douz Bel che dominava la fortezza di Miriocefalo
(Myriokephalon) in Frigia, posta in prossimit� della frontiera;
in questo luogo avevano perso la vita molti greci e il nome derivava appunto �(�myrios� infinite �cefale� teste) dalle
infinite teste cadute.
La fortuna che aveva sempre accompagnato Manuele, questa volta
lo abbandonava nella battaglia che si sarebbe combattuta (1176), tra le gole
delle montagne; in verit� neanche si era trattato di battaglia ma di corpo a
corpo che aveva avuto luogo nella trappola delle gole montane, dove Kilidij aveva nascosto il suo esercito, pur essendo stato
l�imperatore avvertito di questa possibilit�.
Manuele inoltre, aveva respinto per ben due volte la
richiesta di pace di Kilidj Arslan (che si era comunque
assicurato l�aiuto dei sultani di Aleppo e della Mesopotamia, di tutti i turchi
della Persia e della Siria, e l�esercito era stato nascosto tra le gole delle
montagne che sarebbero state atraversate
dall�imperatore), aizzato dai giovani ufficiali dei quali, come scrive Niceta, �l�imperatore aveva accolto il suggerimento
proprio di coloro che non avevano mai sentito la tromba ma conoscevano solo la
bellezza dell�oro e delle gemme di cui erano fregiati� .
La marcia dell�esercito era rallentata dai numerosi carri
carichi che trasportavano anche macchine d�assedio; non mancava la guerriglia
dei turchi, che attaccavano e fuggivano e gli avvelenavano l�acqua, tanto da
far diffondere una epidemia di dissenteria che aveva fatto strage di numerosi
soldati.
Superata la fortezza di Miriocefalo
(era il mese di settembre) si apriva un passo angusto chiamato Cibrilcine (Chiuse di Tzybritze-Tourrije
Boghaz), tra una lunga catena di montagne separate
l�una dall�altra da profonde valli e massi scoscesi pendenti a precipizio.
Manuele senza rimandare verso la coda dell�esercito la
lunga fila di carri e senza essersi preoccupato dei turchi appostati tra gi
anfratti, marciava come se fosse in aperta campagna; l�armata era talmente
ristretta che si prolungava per dieci miglia; l�avanguardia era comandata da
Giovanni e Andronico Angelo; seguiva il grosso dell�esercito comandato da
Costantino Macroducas, Andronico Lamparda,
Maurozome e il re Baldovino, poi seguiva� la lunga colonna di carri seguita dal grosso
dell�esercito con l�imperatore Manuele; la retroguardia era comandata da
Andronico Contostefano, quando fin� di entrare nella strettoia, l�armata era interamente
circondata e sulle due coste delle alture apparvero i musulmani ed ebbe inizio il
massacro.
Erano passati indenni per l�intricato sentiero le sole coorti
dei due Angelo, di Macroduca e di Laparda che erano
riusciti a occupare una collina dove si erano asserragliati; tutti gli altri �non potevano n� retrocedere, n� avanzare
chiusi a destra e sinistra dalle rocce mentre i carri formavano un argine
impenetrabile, per cui gli uomini a cavallo cadevano colpiti dai dardi; una
gran parte di soldati fin� in un precipizio in cui morirono molti ufficiali e
congiunti dell�imperatore; le truppe dell�imperatore non poterono erano
bloccate dagli animali che tiravano i carri che i turchi avevano ucciso chiudendo
ogni possibilit� di avanzare o retrocedere; la retroguardia era bloccata da
altri turchi.
Su una cima rocciosa, su una picca tenuta da un turco, era
mostrata la testa di Andronico Vatatze, nipote
dell�imperatore, mandato a Neo-Cesarea per�
aprirgli le porte della citt�, ma con la sua scorta era stato fatto a
pezzi; gli unici a trovarsi in una buona situazione erano stati quelli
dell�avanguardia che usciti dal passo e saliti sulla collina vi si erano
trincerati, costruendo una palizzata e predisponendo un accampamento. ��
Manuele, vistosi perduto, grid� ai suoi �Tutto � perduto, salvatevi come potete�
ed egli si avvent� contro i turchi� infilandosi
tra di essi mentre la sua armatura si riempiva di frecce; il suo corpo era �pieno di ferite, un pezzo del suo elmo si era infilato
nel suo cranio; abbandonato, coperto di sangue egli combatteva con forza e pareva
terribile, circondato, faceva vittime con la forza delle sue sole braccia.
Alla fine gli si apre uno spiraglio e vi si lancia col suo
cavallo inseguito da tre turchi che uccide; dieci cavalieri greci giungono in
suo soccorso e attraversando diversi squadroni di saraceni, giunge in
prossimit� di un pero selvatico; un cavalleggero greco lo riconosce e gli
presta il primo soccorso, ripulendolo dalla polvere e dal sangue, gli fascia le
ferite e gli sistema l�elmo rimettendolo a cavallo.
Nello stesso momento giunge un turco che prende il cavallo
per la briglia e voleva portarlo con s�; Manuele aveva solo un pezzo di lancia
e gli dette un colpo cos� forte sulla testa che lo tramort� a terra; altri
turchi si avvicinarono ma l�imperatore ne uccise uno con la lancia del
cavalleggero e l�altro era stato ucciso da quest�ultimo; gli altri si erano
dati alla fuga; nel frattempo era sopraggiunta anche una tempesta di sabbia che
aveva oscurato il cielo, non si vedeva, come se fosse notte e si uccideva a
caso, abbattendo anche i propri commilitoni; il campo era divenuto un cimitero
di morti, l�uno sull�altro di greci, turchi, cavalli e buoi; vi erano feriti
che chiedevano aiuto senza nessuno che potesse aiutarli.
UN SOLDATO
REDARGUISCE
L�IMPERATORE
|
L |
�imperatore spingendo il suo cavallo sui cadaveri riusc� a
raggiungere il fiume, che scorreva fra le gole, arrossato di sangue; ora era circondato
dai suoi soldati, arrivavano ufficiali turchi che si distinguevano per i loro
bei cavalli, magnificamente bardati e con sonagli, ma furono respinti.
Stanco per le ferite l�imperatore chiese dell�acqua che fu
presa dal fiume; nell�assaggiarla avvert� il sapore di sangue: �Ah sciagurato, disse, questo � sangue
cristiano�; un soldato che si trovava nei pressi ebbe l�audacia di
rispondergli: �Voi imperatore non
incominciate oggi a gustare questa orribile bevanda; ne avete bevuta per lunghi
tratti e ve ne siete ubriacato da quando avete oppressi i vostri sudditi caricandoli
di imposizioni� Manuele rimase in silenzio e vedendo i turchi prendere i
sacchi di danaro, disse ai suoi soldati:, �Correte,
andate a prendere quel bottino che � vostro e avete pi� diritto di loro ad
averlo; �S�, rispose lo stesso
soldato, ma sarebbe stato meglio non aver
tolto tanto denaro ai vostri popoli,� che
restituirlo ora che non possiamo ottenerlo se non a prezzo del nostro sangue�.
Nel campo dei turchi vi era il sultano Kilidj
Arslan il quale continuamente riceveva notizie dell�esercito greco; egli non
aveva un fisico normale, ma era deforme in molte parti del corpo con cattive
articolazioni con alle mani e ai piedi, tanto da non poter camminare ed era trasportato
su un cocchio coperto; nonostante ci� aveva raggiunto un grande potere e aveva
allestito delle potenti forze militari; era turbolento di natura e quando aveva
da combattere i greci, lo faceva senza avvertirli; attaccava battaglia senza
motivo, violando gli accordi senza alcuna ragione, rompendo i patti e
regolandosi secondo il suo arbitrio anche con i suoi stessi correligionari; si
scagli� infatti contro Melitene il cui emiro Afridum, era correligionario e non gli aveva arrecato
alcuna offesa, ma solo per cacciarlo dalla citt�.
Kilidj riflett� sulle possibilit� che aveva di uccidere o far
prigioniero l�imperatore con i soldati rimasti, ma facendo ci�, non avrebbe
distrutto l�impero greco; egli si comport� con la massima magnanimit� nei
confronti dell�imperatore e dei greci, contrariamente al suo carattere,
comportamento che quando l�imperatore sar� libero, non solo non ricambier�, ma
come vedremo non manterr� fede agli accordi presi con il trattato di pace.� �
Il campo greco �allestito sulla collina, era completamente
circondato dai turchi che avrebbero potuto annientarli, imperatore compreso;
mentre alcuni turchi avevano iniziato a svellere la palizzata, giunse un messo
turco, l�emiro Gabras, dicendo loro di fermarsi, in
quanto aveva un messaggio per l�imperatore. Entrato nel campo e facendosi annunziare,
�egli portava all�imperatore a nome del
sultano, in dono, una lunga spada e un bellissimo cavallo niseo (*), con le redini d�argento; dopo essersi prostrato, parl�
lungamente all�orecchio dell�imperatore offrendogli la pace; l�imperatore
sembrava appena uscito da un sepolcro e non credeva a ci� che aveva sentito e
dopo avergli fatto ripetere il messaggio, si convinse della seriet� della
proposta; l�emiro �avendo visto la veste
d�oro che l�imperatore indossava sulla corazza, gli disse: �Signore, questa non � degna di un principe
guerriero come la maest� vostra: � la corazza il magnifico abito di guerra�,
al che Manuele tolta la veste, la don� all�emiro.
Manuele, resosi conto che gli accordi con Kilidj non nascondevano insidie, decise di rientrare a Costantinopoli,
ma voleva chiese alle guide di fare un�altra strada, volendo evitare la vista
dei cadaveri, ma le guide, perfidamente gli dissero che non vi erano altre
strade in modo che l�imperatore dovette assistere allo scempio del percorso
peno di cadaveri e di bestie morte; i turchi avevano tolto ai cadaveri la pelle
del capo e dei genitali per non far distinguere i circoncisi dai cristiani e
ci� perch� anche da parte turca vi erano stati molti morti e non si riuscisse a
capire a chi appartenesse la vittoria.
Nessuno, scrive Niceta, pass�
di l� senza spargere lacrime e senza dire qualche preghiera per gli amici o parenti
defunti.�
*) I cavalli �nisei� erano dei bellissimi purosangue
da parata, allevati nella pianura di Nisei (tra Balkh e Midis, Iran occidentale),
dal collo lungo magro e flessibile, con occhi larghi, una testa forgiata
nitidamente, arti magri e forti, atti a portare un cavaliere con corazza
(corrispondente al destriero degli occidentali), probabilmente conosciuti come
�akhalteki� tra le duecentocinquianta
razze di cavalli, considerata la pi� antica, evoluta nel corso dei millenni.
*) LA DINASTIA DANICHMENDITA
|
L |
a dinastia
aveva avuto inizio con il re (melik) Danichmend che regnava a Malathia,
Sivas e altre citt� (1067-1173/74) da cui discendeva
Sidi Batthal (Abou Mohammed Djaafar
ben Soulthan Housein ben
Abbas iMalathiene); la sorella di questo Sidi Batthal era la moglie dell�emiro di Malathia
Amr ben Nou�mann ben Ziad
ben Omar Maadi e il loro figlio Nezir
el- Djemal aveva sposato un
emiro turcomanno, Aly ben Mizrab
il cui figlio era Melik Danicmend
chiamato dagli autori europei Dalisman o Talisman o Doniman e dallo
storico Abou�l-Feda Thilou.
Melik Danichmend
viveva con un suo parente sultano Toursoun ben Aly, figlio di Seyid Djaafar el-Bathal, a Malathia e tutti e due, a imitazione del loro avo,
incoraggiati dal califfo allora regnante, si misero a far guerra ai cristiani
(greci), facendo escursioni contro di essi (1067) e melik
Danichmend si impossess� delle citt� di Silvas, Sisdiy� (o Comnat), Carcara, Kharchina (o Amasia) e poi di Castemouni,
Gunichmaadin (con miniere d�argento) e Niksar dove Danichmend (Aboul Abbas Ahmed ben Yoursouf el-Dimechqy), colpito da una freccia; il suo vizir era Alpteghin e suo figlio Melik Ghazi Mouhammed si rec� a Bagdad
e chiese aiuto al califfo Mouchtadi bi-emar Allah (Billah) (1094-1118).
Quest�ultimo, avendo consentito, gli fece
prestare aiuto dall�emiro seldjuchude Souleiman la cui sorella fu data in moglie a Melik Ghazi; ambedue combatterono
onorevolmente contro i greci.
Melik Ghazi,
conosciuto col nome di Ibn el-Danichmend e si
impadron� di Cesarea e Malathia (1099); fu colui che
fece prigioniero Boemondo (1099); si era impadronito di numerose citt� , oltre
a Malathia di Amasia; Niksar
Erzerum, Ancyra, Cesarea e
tante altre; alla sua morte (1142) gli succedette il figlio Abou�l-Mouzaffer
Yaghi Befan (morto nel
1157) il quale ebbe per successore il figlio MoudjahidAbou�l-Mehamid
Djemal Ghazi e a queste
succedette lko zio Melik
Ibrahim seguito da Abou�-Cadr Ismail (morto nel 1160)
e infine, ultimo della dinastia, Zou�l-Noun ben Mouhammed che fu privato (1173) del suo potere da Qilidj Arslan.
���������������������������������������������������������������������������������
LA
BATTAGLIA DI
HATTIN� E LA
VENDETTA DI SALADINO
|
R |
inaldo nei suoi possedimenti aveva introdotto un gran
numero di Templari e nello stesso tempo, non avendo perso il vizio dei
saccheggi, nonostante fosse stata firmata una tregua con Saladino,� nelle vicinanze di Karak
spogli� una ricca carovana di musulmani.
Saladino se ne lament� con Baldovino il quale non pot� dargli
nessuna garanzia su Rinaldo, e Saladino per ritorsione, prese in ostaggio
millecinquecento pellegrini cristiani, ma n� le richieste di Saladino n� le
preghiere del re riuscirono a far desistere Rinaldo dai saccheggi, ora accompagnato
dai templari; per di pi� aveva fatto una escursione a Petra, in quanto aveva in
mente di andare alla Mecca e a Medina e prendere la kaaba (il pezzo di meteorite
venerato dai musulmani) e il sarcofago di Maometto, per distruggere la
religione islamica:� Saladino in queste due
occasioni aveva giurato che se Rinaldo fosse caduto nelle sue mani lo avrebbe
ucciso.
Saladino deciso a vendicarsi chiam� a raccolta tutti i
guerrieri di Siria, Egitto e Mesopotamia; tutti risposero e un primo scontro
avvenne (1187) nei pressi di Nazareth tra musulmani e Ospitalieri
e Templari, che furono fatti a pezzi; i cristiani si erano radunati in una
forte posizione a Sefori� da dove non si muovevano e
Saladino per stanarli and� a saccheggiare Acri (Tiberiade); a questa notizia
l�esercito cristiano si mosse per andargli incontro e Saladino fece lo stesso.
Li sorprese in un luogo stretto e arido dove i cristiani
furono bloccati senza risorse;� l�armata
musulmana era infiammata da terribile ardore, al solo vederla incuteva paura;
quanto al numero, era stato scritto che sembrava
che il genere umano si fosse raccolto per il giudizio universale; quello
cristiano non era da meno, era intorno ai cinquantamila uomini, ma
sfortunatamente per loro, erano i primi giorni di luglio quando il caldo era pi�
insopportabile, i cavalieri erano nelle loro armature di ferro e tutti erano
presi dalla sete.
Saladino aveva alle sue spalle il lago di Tiberiade; la
sua fanteria era al centro, i cavalieri ai due lati; l�unica possibilit� per i
cristiani era di aprirsi un varco; un primo scontro, durato fino alla notte
rimase senza alcun risultato (3 luglio); l�indomani i cristiani erano spossati
per la sete; Saladino diede fuoco alla sterpaglia su cui essi combattevano; tra
il fumo e il fuoco in cui si trovavano i cristiani senza potersi muovere, pi�
che di combattimento fu un enorme massacro.
La vera croce
(si trattava di una grossa croce di legno in cui era stato inserito un pezzo
della croce che si riteneva originale), che essi portavano con s�, non li aveva
aiutati e cadde nelle mani dei musulmani.
Chi non era stato ucciso fu fatto prigioniero (erano tanti che per mancanza di corde furono
legati a gruppi di trenta-quaranta: a vedere il numero dei morti non si credeva
che vi potessero essere prigionieri e a vedere il numero dei prigionieri non si
credeva che vi fossero dei morti).
�Attraversai il
monte Hittin (era il nome usato dagli arabi) - scriveva
Kemal-ed-Din - che
mi offr� un orribile spettacolo: vidi ci� che una nazione fortunata aveva fatto
a un popolo sfortunato; chi potrebbe descriverlo? Vidi delle teste tagliate,
degli occhi spenti o crepati, dei corpi coperti di polvere, delle membra� sconnesse, delle braccia separate o delle
ossa e delle cosce tagliate, dei lombi spezzati, dei piedi che non tenevano pi�
le gambe, dei corpi tagliati in due, delle labbra lacerate, delle fronti
fracassate; ricordai le parole del Corano: L�infedele dir� non sono io polvere?
Che odore soave esalava da questa terribile vittoria!�; �l�anno seguente, aggiunge lo storico, �tornai
sul campo di battaglia e vidi le ossa ammucchiate, erano sparse qua e l�, senza
contare che il torrente e gli animali� li
avevano trasportati sulle montagne o nella valle�.
Tra i prigionieri vi erano il re Guido di Lusignano e� tutti gli altri signori tra i quali Rinaldo
di Chatillon; Saladino (nel racconto di Kemal-eddin,
testimone degli avvenimenti) fece venire nella sua tenda il re Guido e alcuni dei
signori tra i quali Rinaldo; volle far sedere il re accanto a lui e siccome
questo era assetato, fece portare dell�acqua di neve offrendola al re; dopo
aver bevuto Guido stava passando la coppa a Rinaldo, ma Saladino lo ferm�
dicendogli che non aveva dato a quel
miserabile il permesso di bere; dopo avergli chiesto se voleva farsi
musulmano, Rinaldo rispose di no, dicendo che era preferibile morire; il
sultano con aria terribile gli ricord� i suoi attentati, Rinaldo rispose per
mezzo di interprete, che tale era il
costume dei principi e che non aveva fatto altro che seguire il loro esempio;
Saladino a questo punto and� verso di lui e gli sferr� un colpo di scimitarra
tra il collo e la spalla e Rinaldo cadde per terra ai suoi piedi; il re Guido tremava
dalla paura, ma Saladino lo rassicur� che non gli avrebbe fatto del male; dopo
aver fatto segno ai suoi soldati, essi si avvicinarono al corpo di Rinaldo e
gli tagliarono la testa.�
Saladino diede ordine a tutti i suoi soldati di uccidere gli
Ospitalieri e Templari (erano duecento), che avevano
come prigionieri nel suo campo e per evitare qualche gesto di piet� promise
cinquanta pezzi d�oro� per il corpo di
ognuno di essi; era stato tanto l�odio che essi avevano suscitato con i loro
massacri e per la loro crudelt�, che mand� l�ordine a tutti gli atabek del regno
di uccidere tutti i Templari e Ospitalieri che
avevano come prigionieri, il re con gli altri prigionieri furono mandati a
Damasco.
La esecuzione avvenne in forma spettacolare: l�armata
musulmana era disposta in ordine di battaglia e gli emiri erano in due file,
Saladino era assiso con volto sorridente; ai cristiani prima della esecuzione
era chiesto se volevano convertirsi e, in questo caso, era concessa loro la
vita, ma furono pochi quelli che accettarono; secondo le fonti arabe di
quarantacinquemila soldati cristiani ne rimase solo un migliaio.
���������������������� ����������������������������
IL FEROCE
SALADINO (*)
 Malek-Nasser Youssouf Salah ed-Din figlio di Nodgem ed-Din Ayouh, con il fratello Shirkouh erano dcesi dalle
montagne curde per mettersi al servizio dei musulmani; era nato a Trecrit (Mesopotamia) dove �il padre svolgeva le funzioni di governatore, lo
chiamavano Ayoub.
Malek-Nasser Youssouf Salah ed-Din figlio di Nodgem ed-Din Ayouh, con il fratello Shirkouh erano dcesi dalle
montagne curde per mettersi al servizio dei musulmani; era nato a Trecrit (Mesopotamia) dove �il padre svolgeva le funzioni di governatore, lo
chiamavano Ayoub.
Il suo genio, la sua bravura, il suo
senso di giustizia e la sua generosit� lo imposero alla ammirazione dei
cristiani che ne avevano terrore; ben presto la sua potenza super� quella degli
altri sultani arabi e turchi.
Durante la giovinezza si era dato alla
dissipazione e ai piaceri del corpo amando le donne e il vino, lontano dalla
politica e dalle guerre; era un tipo molto riflessivo e con la lettura modific�
i suoi costumi divenendo un uomo nuovo colto e saggio, molto osservante della
religione, della setta sunnita (un giorno che un giovane di nome Sahraverdi si prendeva gioco della religione lo fece
arrestare e mettere a morte); era apprezzato dagli emiri per la sua generosit�
e le sue liberalit�.
A trent�anni era entrato nell�esercito di
Nour ed-Din (Nureddin-Norandino) in cui presto si distinse e Nour ed Din lo mand� a
conquistare l�Egitto (1171) dove per due secoli avevano regnato i fatimidi (che
vivevano isolati nei loro palazzi e lasciavano tutta l�autorit� nelle mani dei
visir), il cui califfo Aded moriva in quei giorni,
senza sapere di aver perduto il suo regno; Saladino ne assunse l�autorit� e
riusc� a dare alla popolazione un indirizzo religioso unico (che era quello
musulmano sunnita); la bandiera nera degli abbasidi sostitu� quella bianca dei ragazzi di Al� e i musulmani d�Egitto e
di Siria furono unificati nella religione sunnita.��
Le accuse fatte nei confronti di Saladino
dai suoi invidiosi rivali erano per� veritiere, in quanto Saladino aveva in
mente l�ambizione di voler regnare per proprio conto e portarono Nour ed-Din a tirarlo fuori dall�Egitto,
dove regnava per proprio conto e associarlo nelle sue imprese contro i
cristiani.��
Saladino volendo dare l�impressione di
obbedire, durante il suo viaggio saccheggi� e sottomise alcune citt�, quando
gli giunse la notizia della morte di Nour ed-Din.
Questo lasciava un figlio di pochi anni e
Saladino prese il comando del suo esercito e approfittando delle rivolte tra i
vari atabek che travagliavano la Siria, si
impadron�� del regno, avendo ora la
possibilit� di combattere solo i cristiani, sebbene alcuni califfi non volessero
cedere i loro regni; �Saladino li accontent�
tutti con ricchi doni e ottenne una tregua della quale approfitt� per imporre
le sua potenza e eliminare gli ostacoli che potevano frapporsi al suo impero
(1176).
Saladino si era ripromesso di cacciar via
tutti �i cristiani dall�Oriente, cosa che
avverr� per suo merito, in quanto aveva insegnato a turchi e arabi che per
vincere dovevano combattere uniti.
Morto Nour ed-Din, Saladino divenne sultano d�Egitto, dove per� aveva �suscitato il malcontento sia perch� nel
prendere il potere non aveva tenuto conto che la popolazione era in preda alle
fazioni (in funzione della religione!), sia dal punto di vista prettamente religioso,
in quanto i fatimidi erano sciiti (nemici acerrimi dei sunniti che ancora dopo circa
mille e quattrocento anni dalla morte del profeta, continuano assurdamente a massacrarsi!).
La terza causa era dovuta ai negri (eunuchi) giunti dalla Nubia e
dall�Abissinia su invito dei precedenti califfi, che dominavano a corte e
nell�esercito e non erano rimasti indifferenti alle donazioni di terre ai
soldati da parte di Saladino, per cui si form� un partito per abbatterlo, che
coinvolse il maresciallo di palazzo (moutamen elkhelaf�), eunuco
nero che doveva contattare il re Amaury di Gerusalemme (succeduto al
fratello Baldovino III, il quale aveva ripudiato la moglie Agnese per sposare
Maria, figlia di Manuele); ma la congiura fu scoperta e Saladino pun� i
responsabili.
Non contento dell�Egitto Saladino volle
appropriarsi dei territori posseduti dai familiari di Nur ed Din in Siria ma fu sconfitto da Rinaldo di Chatillon,
principe di Karak, a Ramlah
(1177), e le cattive condizioni del suo esercito lo costrinsero a rientrare in
Egitto; ritorn� dopo cinque anni (1183) e recatosi a Damasco di cui era padrone
gi� da otto anni, conquist� Edessa e poi si diresse ad Aleppo e obblig� il
sultano Zenghi II a capitolare.�
Con i franchi aveva sottoscritto una
tregua� (1185) che fu violata da Rinaldo,
il quale, come abbiamo gi� detto, aveva saccheggiato una ricca carovana;� Saladino, sdegnato, riprese le ostilit� e
vinse la battaglia di Hittin (Hattin
per i musulmani) presso Tiberiade (1187).
A causa di questa vittoria i franchi
perdettero tutte le citt� che possedevano in Siria, compresa Gerusalemme
(2.X.1187) nello stesso giorno in cui i cristiani l�avevano presa ottant�anni
prima; con la differenza che Saladino si comport� in maniera diversa di come si
erano comportati i cristiani� (v. P. I),
senza saccheggi e devastazioni, limitandosi a cambiare alle chiese la croce,
dopo averle fatte lustrare con acqua di rose; aveva permesso ai cristiani di
rimanere nella citt�� concedendo loro la
chiesa del santo Sepolcro; infine ai latini che non avevano possibilit�
economiche fece doni e diede loro la scorta per recarsi ad Antiochia, dove
ricevettero dai loro confratelli cristiani ben diverso trattamento!
Boemondo di Antiochia si rec� accompagnato
dal seguito, a Berito a fargli visita, senza scorta,
senza averlo avvertito e senza lasciapassare; il sultano gli fece una
bellissima accoglienza e per mostrargli la sua soddisfazione gli don� delle
campagne confinanti con il suo principato e ai signori che lo accompagnavano offr�
ricchi doni.
Dopo Gerusalemme Saladino si present� a
Tiro che pose sotto assedio, dove il marchese Corrado si prepar� a riceverlo e
Saladino alla fine fu costretto a ritirarsi, ma si rec� (1189) ad assediare
Acri (Tolemaide), che resistette per due anni e alla
fine (1191) si arrese; Saladino per garantire la libert� agli abitanti si
impegn� a versare una somma in tre rate; alla scadenza della prima rata chiese
a garanzia degli ostaggi e lui fece altrettanto.
Riccardo d�Inghilterra (Cuor di Leone),
offeso per questa diffidenza port� duemilasettecento prigionieri musulmani dove
era accampato Saladino e li fece massacrare; Saladino ne rimase inorridito e per
�rappresaglia fece uccidere dei
cristiani, ma in numero limitato; ci� nonostante fu conclusa una tregua (1192)
in cui fu stabilito che le citt� di Acri, Giaffa, Arsof
e Acca, con le loro dipendenze, rimanessero ai franchi e �il regno di Gerusalemme si ridusse a queste
citt�.
Saladino mor� a Damasco (1193) all�et� di
cinquantasette anni dopo aver regnato ventiquattro anni in Siria e diciassette
in Egitto. ��
Aveva avuto il senso della giustizia� (diversamente da Riccardo Cuor di Leone
esaltato dai romanzi di cavalleria �dell�epoca!) e della umanit�, che gli avevano
fatto esercitare il potere� con prudenza,
saggezza e equit�; liberale fino alla profusione, musulmani, ebrei e cristiani
furono beneficiari delle sue larghezze e elemosine; se doveva aiutare qualcuno,
non chiedeva della religione di appartenenza ma solo delle sue sciagure:
ammalatosi, prima di morire, fece portare in giro il lenzuolo con cui doveva
essere seppellito, facendo dire: Ecco
quanto Saladino porta con s� di tutte le sue conquiste; Saladino lasciava
sedici figli, primogenito Almalek-Alafdal Nour-eddin Ali (Malek Afdal), e una figlia.
Saladino non aveva disposto per la
successione e questo determin� il disfacimento delle sue conquiste; Malek Afdal fu proclamato sultano
di Damasco, padrone della Siria e sovrano di Gerusalemme e della Palestina (ma
era corrotto e dedito agli eccessi dei piaceri e aveva fatto cadere tutto nel
disordine e nella confusione); �al Cairo
prese il comando suo figlio Aziz, Almalek Aldaher Gaiat-eddin Gazi si
impadron� di Aleppo; Almalek Aladel
Seif-eddin Abu beerMohammed,
di Damasco; Afdal e Daher
si divisero la Siria, l�uno regnava a Damasco, l�altro ad Aleppo; Malek Adel, fratello di Saladino
si fece riconoscere sovrano della Mesopotamia e di alcune citt� dell�Eufrate; i
principali esponenti della famiglia del fratello paterno Shircouh
che regnarono in Egitto, furono detti ayubiti.
*) Il nome de� � Il
feroce Saladino�� gli era stato dato
in Italia nel 1937 in occasione di un concorso della Buitoni e Barilla con la
raccolta di figurine disegnate da Angelo Bioletto,
che si trovavano in confezioni di pasta, cacao, mandorle, cioccolatini e
caramelle e tra le figurine introvabili vi era quella de �Il feroce Saladino� (Museo delle Figurine di Modena); il concorso
aveva avuto un grande successo in quanto era in palio la �Topolino� Fiat, messa in produzione l�anno precedente.
LA GUERRA
CON VENEZIA
E ANCONA SALVATA
DALLA CONTESSA
ALDRUDE
|
L |
e origini di questa guerra con i veneziani non sono molto
chiare in quanto le varie fonti sono diverse l�una dall�altra: sembrerebbe che
Manuele per invadere la Sicilia avesse chiesto l�aiuto dei veneziani che per�
erano alleati dei siciliani; Manuele aveva chiesto a Venezia di rompere il
trattato con la Sicilia ma Venezia aveva rifiutato; per vendicarsi i greci
entrarono in Dalmazia e si impadronirono di alcune citt� sotto il dominio dei
veneziani; per ritorsione furono richiamati tutti i mercanti veneziani che si
trovavano nell�impero, ma poco dopo Manuele (secondo alcuni Manuele mirava a
impadronirsi delle ricchezze dei mercanti veneziani), fingendo di riconciliarsi
con la repubblica, promise di restituire le citt� che aveva tolto ai veneziani
e invit� i mercanti a rientrare; Venezia dal suo canto revoc� il divieto di
trafficare con l�impero per cui vi fu un ritorno di mercanti (ventimila!) e una
ripresa di traffici che portarono nel Bosforo navi dei nobili veneziani (che
fungevano da ambasciatori), cariche di mercanzie.
Non appena giunti a destinazione seppero che l�imperatore
aveva fatto arrestare in tutto l�impero diecimila mercanti e requisire le navi;
gli ambasciatori, strabiliati, se ne tornarono a Venezia dove gi� erano giunti
molti mercanti che erano riusciti a fuggire.
Come abbiamo gi� visto in precedenza, i veneziani godevano
nell�impero grandi privilegi e godevano della qualifica di cittadini, dopo aver
fatto un giuramento di fedelt�; essi avevano per� l�obbligo di risiedere nel
quartiere loro riservato e non potevano risiedere altrove, ma eludevano questo
divieto sposando donne greche e andando ad abitare presso le loro mogli.
Essi avevano grandi ricchezze e a loro opulenza gli
consentiva di imparentarsi con le grandi famiglie bizantine e occupavano
cariche pubbliche sia in citt� sia a corte; i nemici mortali dei veneziani
erano i lombardi ai quali i veneziani saccheggiarono i magazzini e distrussero
le case; i veneziani furono citati in giudizio e condannati a restituire i beni
e rifare le case; i veneziani invece di ubbidire minacciarono i greci di far
loro ci� che avevano fatto ai lombardi; Manuele invi� ai governatori delle
province l�ordine segreto di requisire tutte le navi veneziane che si trovavano
nell�impero e i veneziani imprigionati, molti dei quali per le amicizie che
avevano o pagando la cauzione avevano ottenuto la libert� sotto condizione di
sottomettersi alle disposizioni imperiali (cosa per� che non intendevano
fare!).
Un mercante veneziano, distinto per le ricchezze, aveva
fatto costruire una caracca (grossa
nave da carico) di straordinaria grandezza, che mai se n�era vista di simile in
Costantinopoli e l�aveva venduta all�imperatore, il quale gli aveva lasciato il
comando; costui aveva concordato segretamente con i compatrioti veneziani che
intendevano fuggire, che sarebbero saliti a bordo in una notte di vento
favorevole e sarebbero stati condotti a Venezia.
La fuga riusc� ma i greci si accorsero della fuga e molte
navi con varanghi furono mandate all�inseguimento; la caracca fu quasi raggiunta nello stretto dell�Ellesponto,
gli inseguitori avevano con s� il fuoco
greco che non riusciva a colpirla sia per la distanzia sia perch� la caracca era stata rivestita di pezze di
feltro inzuppate nell�aceto; gli inseguitori non potendo fare altro se ne
tornarono a Costantinopoli.
A Venezia intanto si preparava la costruzione di navi
(cento galee da costruire in cento giorni!) a due ordini di remi oltre a venti caracche e l�anno seguente (1171) la
flotta al comando del doge Vitale Michiel si impadron� delle citt� costiere
della Dalmazia (di Trau e Ragusa); giunto a
Negroponte il governatore (per dar tempo all�imperatore), gli sugger� di mandare
dei legati a Costantinopoli in quanto l�imperatore era ben disposto per
trattative, per cui Michiel mandando suoi legati, attese tutto l�inverno la
fine delle trattative che Manuele portava per le lunghe; ma essi avvertiti da
una spia, Aronne, che l�imperatore li stava ingannando, se ne tornarono
indietro.
Per somma disgrazia tra i veneziani sopraggiunse la peste
che decim� soldati e marinai; Vitale avendo saputo che una flotta di
centocinquanta navi stava navigando contro di lui, riprese il mare, ma fu
inseguito dai greci al comando di Andronico Contostefano e molte delle sue navi
furono catturate, quelle che riuscirono a fuggire se ne tornarono a Venezia.
Lo sfortunato doge Michiel oltre alla sconfitta port� a
Venezia la peste e il popolo lo accus� di tradimento e lo assassin� in citt�,
in pieno giorno (1172).
La Repubblica volle trattare la pace e mand� ambasciatori
fra i quali vi era Enrico Dandolo, al quale Manuele (non se ne conoscono i
particolari), gli avrebbe fatto avvicinare davanti agli occhi una barra di
ferro incandescente da accecarlo (o quasi accecarlo); i veneziani per
vendicarsi decisero di impossessarsi di Ancona che era una ricca citt�
commerciale sotto il dominio greco (con un governatore greco e delle truppe di
stanza), �chiedendo aiuto Federico
Barbarossa.
Federico mand� l�esercito al comando dell�arcivescovo di
Magonza che invest� la citt� dalla parte di terra, mentre i veneziani la
attaccavano dalla parte del mare; l�assedio durava dal mese di aprile e a
ottobre (1173) gli abitanti ridotti all�estremo, chiesero la resa, ma il
vescovo chiedeva la resa a discrezione.
Nel frattempo la contessa Aldrude
di Bertinoro (Romagna) della famiglia dei Frangipani di Roma (paragonata a una
nuova Giuditta), si un� a Guglielmo degli Adelardi di
Ferrara, e impegnati tutti i loro beni e Aldrude anche
i propri figli, misero insieme un�armata; Aldrude
inviava messaggi di incoraggiamento ad Ancona, preannunciando il suo arrivo; quando
vi giunse si accamp� sotto le mura.
Aldrude alla testa dei suoi soldati attacc� l�esercito alemanno e
dopo una sanguinosa battaglia sconfisse gli alemanni e �poco manc� che l�arcivescovo fosse fatto
prigioniero: il vescovo seppur crudele ma poco coraggioso,� pens� bene di allontanarsi dalla citt�; Aldrude seguita dai soldati and� nel porto e salita sulle
navi, accompagnata da Guglielmo, si avvent� contro le navi veneziane mettendole
in fuga; dopo questa vittoria in citt� si inneggiava, Viva l�imperatore Manuele (dopo il trattato di pace tra il papa e
l�imperatore� - 1177 - Ancona si liberer�
dalla dipendenza greca).
Guglielmo si rec� dall�imperatore, il quale non solo
ricompens� generosamente lui e Aldrude da poter
riprendere le loro propriet�, ma indennizz� anche gli abitanti delle perdite
subite. �
MANUELE I
VERSO LA FINE
|
T |
ra l�imperatore e Kilidj Arslan,
dopo la sconfitta di Miriocefalo, era stato firmato il
trattato di pace che prevedeva la distruzione dei� castelli e borghi di Dorileo
e Sibilia� (Soublaion);
nel tornare a Costantinopoli Manuele si erra limitato a distruggere Sibilia,� lasciando intatta Dorileo;
alla richiesta del sultano, l�imperatore rispose con arroganza che non si
riteneva obbligato a osservare la parola data in quanto strappatagli dalla
necessit�; il sultano fece subito partire un esercito di ventiquattromila
uomini, dando incarico al generale di distruggere tutta la citt�, fino alla
marina e di portargli l�acqua del mare, un remo e un pugno di sabbia; il
generale saccheggi� tutte le rive del Meandro, prese Tralles e Antiochia della
Caria e distrusse tutte le fortezze giungendo fino al mare.
Manuele non aveva forze sufficienti per contrastare quelle
del sultano e mand� Giovanni Vatatze, fratello di
Andronico morto poco prima, dandogli come luogotenenti il giovanissimo
Costantino Ducas e Michele Aspiete con la disposizione
di non attaccare i turchi se non quando fossero stati sicuri della vittoria; i
turchi tornavano pieni di bottino saccheggiando tutto ci� che non avevano
saccheggiato nel loro primo passaggio.
Vatatze era giunto al Meandro e gli avevano riferito che i turchi
stavano per attraversarlo; egli fece appostare i suoi su una collina nelle
vicinanze e appena i turchi incominciarono ad attraversare il fiume, furono
ricoperti di frecce lanciate dalla collina; il generale turco tent� di salire sulla
collina destreggiandosi con valore, ma vide che sulle rive del fiume� i greci facevano carneficina dei suoi; scese
verso il fiume e non potendolo attraversare si serv� del suo scudo come barca e
della scimitarra come remo, tenendo con una mano le redini del suo cavallo;
giunto per� sull�altra riva non pot� evitare la morte, trafitto dalla lancia di
un soldato; ai turchi non rimase altro che fuggire; Aspiete
mor� in combattimento, il suo cavallo era stato travolto da un cavallo turco
che lo rovesci� nel fiume e anneg�. ���
Il ricordo della triste giornata di Miriocefalo
non dava pace a Manuele che passava notti insonni e quando chiudeva le palpebre
gli apparivano le ombre sanguinolenti di tanti infelici che vi avevano trovato
la morte; il suo vigore lo aveva abbandonato e fu costretto a mettersi a letto
(marzo 1180) e ogni tanto si alzava e attendeva alle cure della famiglia.
Dalla prima moglie aveva avuto una figlia, Maria (oramai
trent�enne) che si attendeva di sposare un monarca, ma aveva finito per sposare
il figlio del marchese Guglielmo del Monferrato, Ranieri (di diciassette anni),
al quale fu dato il nome di Giovanni, nominato cesare, e l�imperatore per dare
alla figlia la soddisfazione di avere un regno, elev� a regno la provincia di
Tessalonica, di cui Giovanni fu insignito re.
Dalla seconda moglie, Maria di Antiochia, aveva avuto il
figlio Alessio (1169-1183) che sar� il suo successore (ricordiamo che dalla nipote
Teodora aveva avuto un altro Alessio, che in assenza del legittimo �sarebbe stato destinato all�impero); Alessio
che aveva dieci anni, spos� (1179) Agnese (1171-1240), figlia di secondo letto di
Luigi VII, che non ancora� aveva compiuto
gli otto anni (vedremo nella prossima parte III, il seguito di questi due sposi
bambini), Manuele li fece sposare nel palazzo di Costantino (Blaquerne), e la cerimonia fu officiata dal patriarca
Teodosio che incoron� gli sposi con la corona imperiale.
L�imperatore si indeboliva giorno dopo giorno; gli
astrologi� gli avevano predetto che
sarebbe guarito e sarebbe vissuto ancora quattordici anni e gli parlavano delle
conquiste che avrebbe ancora fatto e per accontentare le sue debolezze, gli
prevedevano ancora dei piaceri libertini; gli avevano anche previsto che prima
di morire avrebbe assistito a una rivoluzione dell�universo, all�urto degli
astri, a furiose tempeste e a una convulsione generale della natura ... e gli
indicavano anche l�anno, il giorno e l�ora di questi avvenimenti e l�imperatore
impaurito faceva abbattere palazzi e scavare grotte in cui si sarebbe rifugiato
... con i cortigiani che lo assecondavano! �
Era il mese di settembre e poich� le condizioni dell�imperatore
peggioravano, fu chiamato il patriarca�
il quale dopo aver fatto ritirare tutti, gli fece sottoscrivere un
documento col quale l�imperatore rinunciava alle
visioni dell�astrologia chiedendo perdono a Dio di avervi creduto.
Egli, dopo essersi tastato il polso (come abbiamo gi�
detto, aveva profonde cognizioni mediche: un giorno andava a caccia in un bosco
con il re Bakldovino, che cadde da cavallo e si luss�
una spalla, Manuele gli prese il braccio e con uno strappo gli tolse la
slogatura!), si percosse la coscia e chiese l�abito monastico, come d�uso
presso molti imperatori che credevano a questo modo di salvare la propria anima.
Gli fu tolta quindi la porpora (ricordiamo che la porpora
per la sua rarit� costava pi� dell�oro!) e gli fu messa una cocolla nera che
gli dava, prima di spirare, la certezza di aver avuto il passaporto per �il Paradiso! ����
Il processo di restringimento dell�impero (opposto dai
Comneno) sar� irreversibile perch� da una parte vi era la pressione dei latini,
dall�altra il pericolo selgiuchide dal quale Manuele aveva ricevuto la pesante �sconfitta a Mioriocefalo
(1176) che aveva annullato le precedenti conquiste.
La sua morte (1180) non � altro che il canto del cigno del
secolo dei Comneno (ufficialmente 1185 con l�undicenne Alessio II e Andronico
che regneranno tre anni il primo e due il secondo), di ci� che rimaneva
dell�impero, in cui si sono avuti gli ultimi sprazzi dell�antico splendore e ha
inizio un periodo turbolento di complotti all�interno e di attacchi
dall�esterno, da parte dei latini che si appropriano della capitale e tolgono
all�impero bizantino un�altra parte del suo territorio, di cui quello che rimane
non sono che brandelli; poi arriveranno i turchi che daranno il colpo finale ma,
l�agonia sar� piuttosto lunga, perch� durer� circa due secoli e mezzo!
FINE
PARTE
II
La prossima,
terza puntata, sar� dedicata a
ANDRONICO COMNENO:
LA VITA COME UN ROMANZO GOTICO.